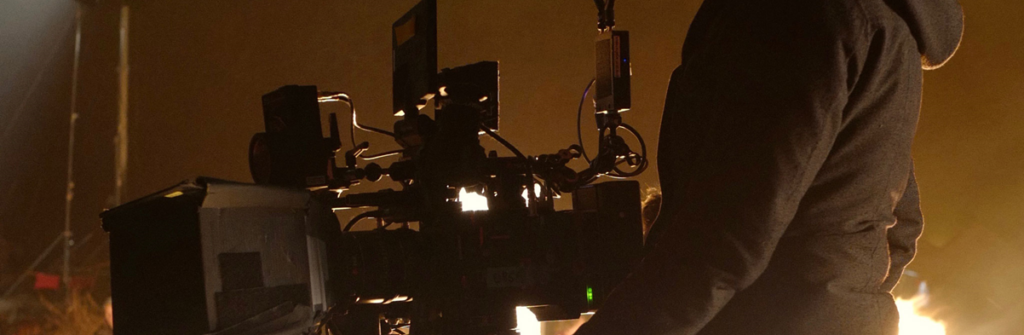(Le illustrazioni sono di Lucia Lamacchia, che è responsabile di quanto segue almeno quanto lo sono Ugo e Michel)

L’aria della città, priva di forma, ci riempie i polmoni. Camminiamo a debita distanza e indossiamo la mascherina. L’aria deve attraversare il tessuto perché la si possa gustare e quel filtro attenua il nostro godimento. Abbiamo lasciato l’auto in un parcheggio. «Le chiavi nel quadro», ha detto il ragazzo indiano allungando la mano guantata per passarci la ricevuta. Probabilmente sorrideva, ma di questi tempi è così difficile capirlo.
Le suole a contatto con il marciapiede ci hanno riverberato una strana emozione nei talloni. Il tremore è risalito, come una scossa, fino alla base del collo. È difficile dire quello che sentiamo. Mordiamo questa città da decenni, godendone a fondo. Ci siamo guardati, respirati, toccati, desiderati e presi. Da mesi le regole e i decreti (e forse il buon senso) ci impongono di ridurre al minimo i contatti. Vaghiamo per la nostra città e, negli occhi, il sospetto ha preso il posto del desiderio. Indossiamo mascherine che ci costringono a respirare il nostro stesso fiato. Se qualcuno si avvicina troppo lo imploriamo con occhi molli di tenere la distanza.
Siamo puntualissimi e, come al solito, dobbiamo aspettare le nostre amiche. In altri tempi le avremmo attese nel locale, sorseggiando un bicchiere di vino e godendo dell’attesa. Al loro ingresso in sala, ci saremmo alzati e avremmo sorriso. Un abbraccio, forse un bacio sulla guancia, spingendo il contatto fino al punto suggerito dalla maturità della schermaglia della seduzione. Quell’istante di vicinanza avrebbe definito le regole della conversazione e del desiderio per tutto il resto della serata. Oggi, no. Preferiamo aspettare fuori dal ristorante. Quando arrivano, anche loro coperte dalle mascherine, ci salutiamo senza avere il coraggio di ridurre le distanze. Il gioco delle parti si deve risolvere nello sguardo.
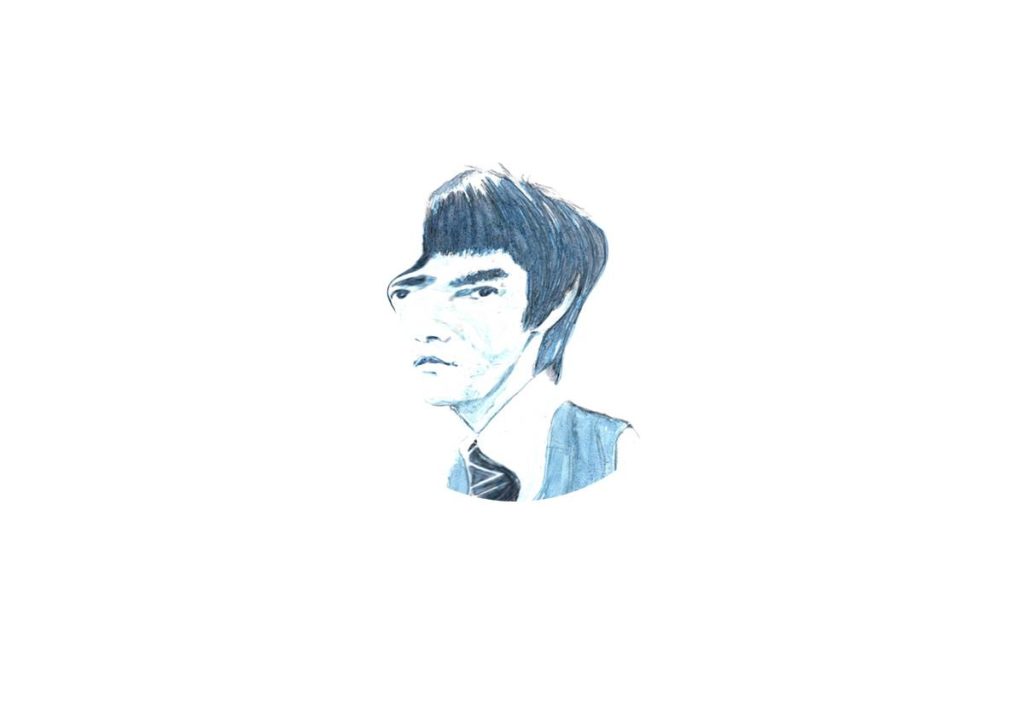
Entriamo nel locale e, mentre reggiamo la porta perché possano entrare anche le nostre amiche, la proprietaria, da dietro il banco ci chiede di aspettare. Una ragazza con i capelli neri raccolti in una coda, grembiule, guanti e mascherina ci viene incontro. Dopo averci chiesto a che nome è stata fatta la prenotazione, ci comunica che dobbiamo entrare uno alla volta e disinfettarci le mani con il gel erogato dal dispenser sul bancone. Ci dice, scusandosi, che ci misurerà la temperatura e chiederà le nostre generalità per il registro. Procediamo con ordine e, mantenendo le distanze necessarie, raggiungiamo il largo tavolo in cui diluire la presenza di umani, garantendo il rispetto delle norme. Prima di sederci, un po’ spaventati, raggiungiamo, uno alla volta, il bagno per lavarci le mani e liberarci dall’odioso odore di disinfettante.
Ecco. Ora siamo a tavola e possiamo ordinare. Non fosse per la distanza innaturale tra le sedie dei conviviali, parrebbe una serata normale. Ma la rottura della ritualità ha infranto la naturalezza del momento. La frequentazione dei ristoranti richiede il rispetto di un cerimoniale, fatto di luci e odori, di prossimità e calore, di rispetto e confidenza, di ironia e attesa. Il rituale disatteso modifica la nostra disposizione intorno al tavolo e la nostra coscienza conviviale.
Due coppie al ristorante. Sono solo amici. Ancora. Forse succederà qualcosa tra di loro. Forse solo tra due di loro. Non si sa. Il succedersi degli eventi è dettato dalla vita e dalla sua imponderabile combinazione di caso e necessità. Tutto contribuisce a definire cosa accadrà. Anche la forma del tavolo. Quando quattro persone si siedono attorno a un tavolo rotondo, la loro relazione diventa rotonda; quando il tavolo è rettangolare, le posizioni dei corpi devono essere speculari. La dimensione del tavolo, poi, costringono a scelte di prossimità. Spostare la sedia e il tovagliolo, magari anche di poco, per ridurre la distanza, suggerisce una direzione possibile al corso degli eventi. Le sedie, distanziate regolarmente per decreto, definiscono una norma inviolabile. La ritualità interrotta modifica il corso degli eventi in un modo che nessuno ha l’esperienza per gestire.

Il vino non ha forma. Quando abbandona il collo della bottiglia per depositarsi in una cascata sottile e gioiosa sul fondo del calice, diventa il calice. Solleviamo il bicchiere, mostrando finalmente i nostri sorrisi, diciamo una sciocchezza sulla vita interrotta che riparte a sobbalzi e portiamo il bicchiere alle labbra. Il naso ci si riempi di aromi fruttati e minerali, in bocca finalmente un sapore fresco e morbido, dopo interminabili minuti trascorsi a respirare il proprio fiato in una mascherina che sente di medicalizzazione. Il mondo rallenta e vive un tempo nuovo scandito dal ritmo della chiacchierata distesa, delle risate e dell’apparizione discreta di un cameriere mascherato che serve le portate, sostituisce le posate e ha cura che i bicchieri di tutti siano sempre pieni.
Un po’ alla volta il muro di diffidenza si affievolisce. Il vincolo delle distanze si ammorbidisce alla fine della prima bottiglia. Quando viene stappata la terza è stato ristabilito il contatto fisico. La modifica del rito ha solo aumentato il tasso alcolico della serata. A voler essere onesti, neanche tanto. Quando arriviamo al dolce, violiamo la regola elementare del distanziamento sociale. Lo scambio dei cucchiaini per garantirci gli assaggi è solo il primo passo per avere in bocca l’altrui saliva.
Usciti dal locale, si deve decidere come proseguire la serata. A quel punto ci sono due coppie, che si tengono sottobraccio con un affetto e un desiderio che sono rimasti inespressi per un periodo troppo lungo. Si può simulare sfiducia e accennare al fatto che i bar sono ancora posti pericolosi. Si può decidere di andare a casa a bere un altro bicchiere. In quel momento i corpi prenderanno la forma della casa e la sera proseguirà assecondando la vita e la sua imponderabile combinazione di caso e necessità.