Il cielo in questi giorni è in parte bravo soldatino autunnale, grigio e piovoso, in parte matto svitato perso, con continui rivolgimenti – sereno assolato, caroselli di nuvole à la Constable, grigio opprimente passivo-aggressivo, nubifragio. Oggi siamo pure arrivati alle nubi mammellari. Però la puntata “patata bollente” era un paio di numeri fa e non è l’unica ragione per fermarsi qui perché per quella di oggi non c’è il porto, questa non è Chiba e non c’è manco Chrome, a meno di non considerare il marchio della ditta Brin&Page che etichetta il prodotto con cui sto inserendo queste righe sul supporto di pubblicazione. Cioè, Brin&Page avrebbero potuto essere Chrome, con qualche licenza, ma non sono più «bruciabili» da parecchio, quindi buonanotte.

Una delle conseguenze del meteo contingente – la premessa implicita è la galoppante senescenza cognitiva e creativa dell’autore, nel suo non trovare di meglio che parlare del tempo – è che si sta abbastanza rinserrati tra le mura domestiche anche nel fine settimana (ma non è una novità, il distanziamento sociale viene abbastanza naturale a questo interno) e allora gli spunti per tenere il passo con la linea editoriale di QUASI (concetto che non viene mai nominato nella redazione di QUASI ma non vuol dire che abbiamo la certezza che non esista), gli spunti, dicevo, li devi andare a ripescare nel passato, tuo o di qualcun altro, non importa se immaginato, vissuto o raccontato o un mix dei tre.
Il cielo sopra il porto di Chiba è un cielo particolarmente alieno per il bassista da salotto. Non che non si sia letto La Notte che Bruciammo Chrome, qualcuno l’ha fatto, né che ci dispiaccia l’atmosfera e il milieu culturale del cyberpunk. Solo che la colonna sonora che ti potevi, e puoi, illudere di sentirci suonare sopra non contempla linee di basso suonate da mani umane. Programmate magari, ma suonate no.
Nell’immaginario collettivo la città del futuro («Los Angeles, Novembre 2019») era quella di Blade Runner, e quella, perlopiù, è rimasta. Se ti fai un giro in rete cercando «cyberpunk digital art», o giù di lì, vengono fuori immagini che aderiscono in modo ardente ad un canone stilistico che scimmiotta quei dintorni lì. I miei amici di QUASI, quelli non alloctoni come me, conoscono sicuramente la genealogia di questo idealtipo (a me viene in mente Akira, non so se ci sia stato altro prima) ma anche oggi, a quasi quarant’anni di distanza, c’è una fedeltà alla linea che impressiona – soprattutto perché non c’è una Reichskulturkammer a dirti che la metropoli e i suoi abitanti cyberdevastati li devi raffigurare così.
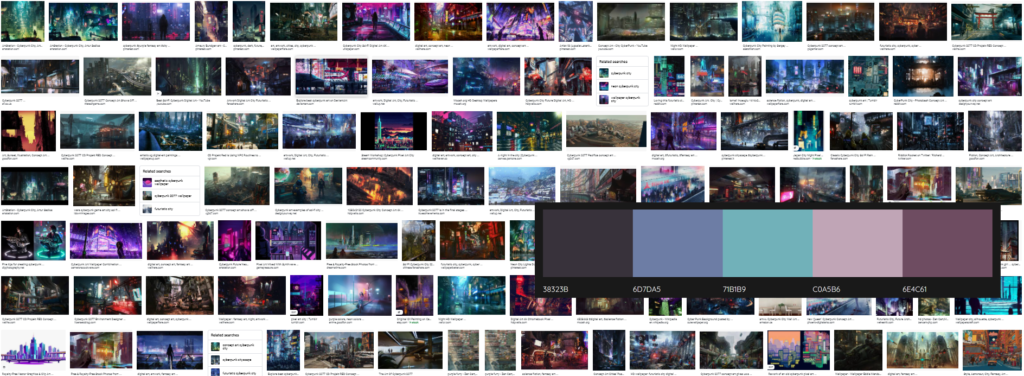
E sul canale audio, visto che si diceva che non ci si immagina un basso suonato, che cosa diamine c’è?
C’è Vangelis.
C’è chi ci mette del metal, ne sono sicuro, o della elettronica di questo o quell’altro tipo e sottotipo (ammetto una ignoranza abbastanza spinta su questi fronti) però Vangelis si è preso quasi tutto. E l’hanno messo, dappertutto (vedi Linea Verde su Rai 1, che mi devi spiega’ checcacchio c’entrano gli End Titles di Blade Runner con la sagra del farro perlato con le zucchine trifolate). Fine parentesi polemica. Vangelis ci dà dentro e sgancia il carico da undici: si chiude in studio con una tonnellata di strumenti «mutanti», tra cui sette-dico-sette Yamaha CS-80, una portaerei di synth polifonico dall’accessibile costo, unitario, di seimilanovecento dollari del 1977, più un bel po’ di ferraglia, strumenti a percussione etnici e non, un piano elettrico, un Fender Rhodes e un corredo di oggetti da rumoristica cinematografica. Niente basso (anche niente chitarra, sia chiaro).
Gli anni Ottanta sono stati strani (e brutti) da vari punti di vista, però non si può dire che non siano stati relativamente pittoreschi e decisamente fertili quanto a boutade futurofile. I Depeche Mode decretano, se non ricordo male, l’avvenuta dipartita della chitarra elettrica, salvo recuperarla in modo totalmente disambiguo almeno dai tempi di Violator e di Personal Jesus, e siamo al ’91, con quegli armonici in apertura e il riff ossessivo, tre note appena, ma di chitarra vera, sparata in faccia a tutto volume. Tra le varie cose che non sono c’è anche lo storico della musica contemporanea, quindi non so quando hanno iniziato a presentarsi fenomeni di convergenza stilistica e di mezzi tra generi distinti fatti con strumenti distinti. Però in tanti casi non pareva esserci un disegno preciso, solo un mix di sperimentazione brada e tribalismi di genere. Quindi era del tutto normale che non si trovasse un synth sui pezzi dei Nirvana e non una chitarra distorta su quelli dei Pet Shop Boys. Certo, pure nel mondo del jazz si era assistito a fenomeni di sostituzione del bassista con qualcosa di sintetico: nel 1973 Herbie Hancock si era procurato un ARP Odyssey e su Chameleon si sbarazzava (parzialmente) del bassista.
Se dovessimo enunciare una sorta di improbabile morale, è che il cyberpasticcio riesce male quando metti in mezzo il bassista, che da poco influente rischia di diventare pure superfluo. Il patto col diavolo sintetico non funziona benissimo quando arrivi a tentare di gestire la mutazione dell’umano in umano+ o post-umano. Si entra quasi sempre in una modalità abbastanza manichea: o te lo tieni o lo sostituisci con una macchina adeguatamente programmata (poi, vabbe’, se il bassista fa parte del gruppo registra comunque la sua parte, quella che, puntualmente, non sente nessuno, neppure col sistema hi-fi da audiofilo compulsivo-ossessivo con l’amplificatore valvolare che sembra un robot da cucina high-end). Quasi sempre, dicevo, perché in qualche caso la questione non si pone a livello di bassista ma un filo più in alto – per poi, quando torni a guardare il bassista, trovare qualcuno che gliene ammolla senza pietà, al di sopra del bene e del male del synth/non-synth. Mi viene in mente Outside di David Bowie, con Gail Ann Dorsey, che a Bowie sta come Tony Levin a Peter Gabriel – e insieme, dal mio punto di vista, i primi battono i secondi sul traguardo, anche se non con tutto questo distacco.

Bowie e Dorsey hanno collaborato in tante occasioni, ma Outside è quello che stiamo cercando quando pensiamo di dare una dimensione sonora alle inquietudini da attraversamento del Rubicone di fine millennio verso l’utopia già sabotata della metropoli totale-globale del futuro. Fatevi un giro su The Heart’s Filthy Lesson o Deranged (usata anche da David Lynch in Lost Highway, un altro dei miei chiodi fissi anni ’90, prima di finire nella diluizione e nella noia che attendevano di là dal Rubicone) e ditemi se non raccontano il sottobosco tecno-disperato che ci aspettiamo dalla città degradata del futuro. «Something in our sky, something in our blood» – soprattutto vedete di alzare quel cacchio di volume – «What a fantastic death abyss! Tell the others». E c’è il piano di Mike Garson, che pure lui dove le trova certe idee non si riesce a immaginare…
La synthizzazione-modellazione degli strumenti elettrici non ci ha fatto benissimo – non è certo un male di per sé, ma ci ha impastoiati in una rete di pedalini, multieffetto, effetti a rack, catene non più comprensibili, figuriamoci gestibili, patite all’insegna della Gear Accumulation Syndrome, con cavi di alimentazione artigianali da duecento euri, pedaliere multipiano da un metro quadro e quindici chili, con un turnover tecnologico pazzesco all’inseguimento dell’ultimo emulatore di synth più meglio di quello precedente. Poi però non suoni con nessuno, non ti fai manco i video da mettere su Youtube, non c’hai la cover band (e meglio così, ché poi quando ce l’hai fai i Toto o i Dream Theater, o Albano). La tecnica degli oggetti, stratificata su sé stessa, difficile da domare e asservire a un proposito chiaro, facile a sembrare posticcia e stancamente caricaturale, piazzata come uno strato spesso di cerone sul volto timoroso della TUA tecnica, quella delle tue mani sullo strumento. Opportunità o pèso el tacon del buso?
Gli innesti elettronici non hanno risolto niente – come avrebbero potuto? – però hanno espanso in modo significativo delle possibilità e ridotto in modo drastico le barriere all’ingresso della realizzazione e registrazione della musica. Ma da qui a dire che i contenuti ne hanno beneficiato ce ne corre. Se avevi idee di merda nel 1988 continui facilmente ad averle anche nel 2018. Se hai iniziato da poco allora avrai le idee di merda del 2020, mi pare giusto così. In questo consiste l’Ecclesiaste della musica. Niente di nuovo sotto la chiave di Sol – figuriamoci sotto quella di Fa. [la notazione musicale per basso è scritta in questa chiave, sperando che l’autore non stia virando dalla mania per le assonanze mitologiche verso quella per le bibliche – N.d.R.]
Queste righe prendono forma nel relax concitato del fine settimana, nell’incombenza della corvée settimanale del lavoro gassoso, quello che tende a occupare tutto lo spazio del contenitore (ahimè, la vita) in cui è liberato, ma non è inopportuno, per quanto inquietante, ricordarci che il «retrofitting» ottuso della tecnologia elettronica, analogica prima, ma soprattutto e in particolare digitale poi, ha in primo luogo, nel mondo del lavoro, della produzione, delle «piattaforme», inasprito le conseguenze dell’inadeguatezza dell’organizzazione sottostante, quella che si presupporrebbe radicata nei concetti, nelle idee, prima ancora che nelle «soluzioni». Che sia la dimensione privata o quella pubblica, l’inserimento di livelli di interazione digitale non ha sempre reso le cose più semplici – anzi, in molti casi ha consentito di perfezionare la dimensione kafkiana della burocrazia in un sistema ormai auto-sufficiente, auto-replicante (tipo Second Variety di Dick), perfettamente metastatizzato, a livello delle tecniche come del linguaggio. Una garanzia infallibile di sperdimento – come un mash-up borghese tra Apocalypse Now e Il Deserto dei Tartari ma con noi protagonisti. Anzi no, comparse. Sarà un’inclinazione che trova spazio nel DSM-V, ma mi sento comunque di dire che l’angoscia di fine millennio non appare per niente fuori luogo anche una volta fatti questi venti passi nel primo secolo del nuovo…
E quindi? quindi c’è la possibilità, e almeno in parte il dovere, di resistere, intorno al legno, alle corde, agli spartiti su carta, all’elettronica analogica solo apparentemente semplice, ai magneti, ai trasduttori, ai condensatori, ai pezzi e pezzettini fuori e dentro i nostri strumenti. Intorno all’idea che il suono ce l’hai nelle dita, nelle mani, in quella testaccia che ti ritrovi, anche prima di accendere un amplificatore. Così che quando lo accendi e non è un robo schifoso, ecco che il suono è buono, il suono è bello. Per spiegare meglio cosa intendo, immaginiamo che ora entri in scena, lì dove siete in questo pomeriggio piovoso, un violinista, bravo quanto basta, col suo strumento. C’è un blackout, si accende una candela, la freccia del tempo entra in uno stato di momentanea sospensione, quello suona la cosa più semplice del mondo ed è altrettanto semplicemente giusta, perfetta, hic et nunc. E tu non hai manco una cassa armonica, dipendi in modo sostanziale dalla rete elettrica e dall’amplificazione e finché non finisce il blackout sei meno di un animale da tiro con un basto strano al collo. Per sperimentarlo dal vivo andate a sentirvi un concerto di musica barocca cercando di occupare un posto nelle prime file, quello è il potere, la virtù atavica della musica suonata.
Noi reietti del salotto-spazio ci trinceriamo dietro al nostro equipaggiamento e c’è chi di stipendi in «roba» ne ha spesi parecchi. Non è per virtù di essenzialità che non ho fatto così, non saprei dire neppure perché, sarà la liquidità un po’ dubbia, ma è andata com’è andata, sono entrato a fare parte della corrente di quelli che di bassi ne hanno uno solo e basta e avanza, perché è più bravo lui di me.

Vi presento il mio, dono dei miei genitori all’epoca dei miei sedici anni: un Blade quattro corde del 1989, corpo in frassino, finitura alla nitro sunburst, tastiera in ebano, elettronica attiva – liutaio americano, azienda svizzera, manifattura giapponese. Oggi, molto prevedibilmente, mi piace immaginarlo lavorato e assemblato a Chiba, sotto un cielo color canale morto della TV.
È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.



