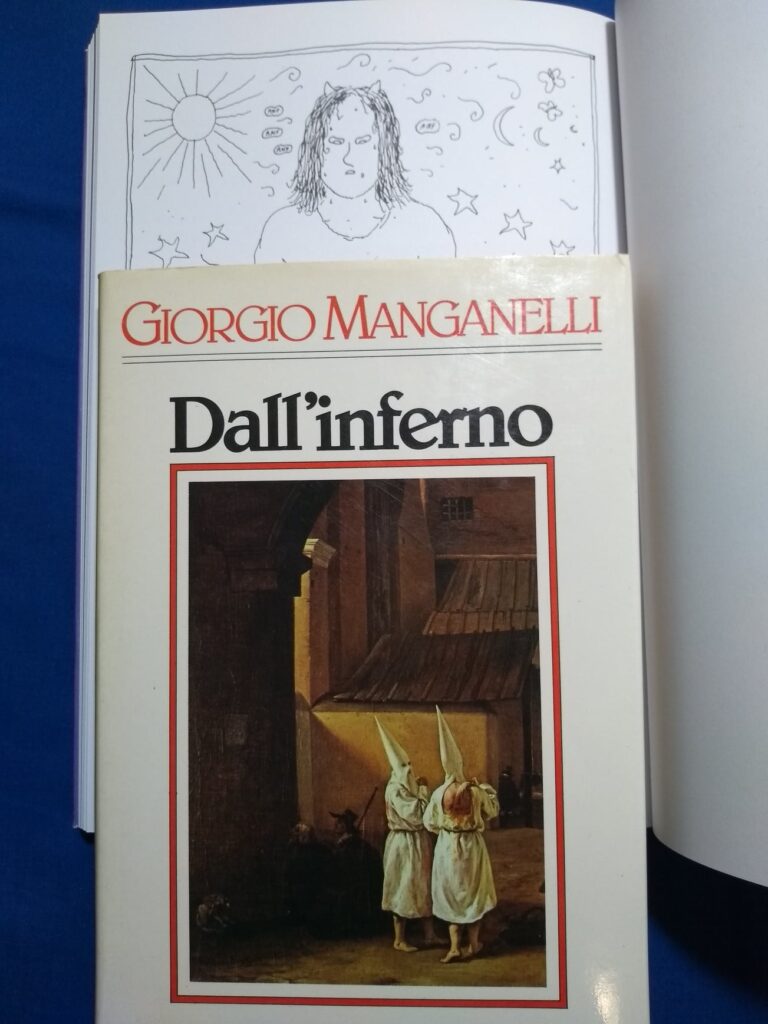
In un volume antologico dedicato a storie incentrate sul tema del compromesso, Andrea De Franco racconta quello per eccellenza della storia della letteratura, e lo fa con il suo segno piccolino (prendo a prestito su (pre)cauzione l’aggettivo qualificativo applicato dalla mia ricorrente cliente che descriverva (eh sì, perché ci vuole anche una briosa verve per dire certe cose: bisogna saperle pronunciare, mica tutti.) in dettaglio il modello desiderato di tovagliato da cm. 140: «Lo volevo con un colore piccolino. Ma non ce l’hai più, quelle con il colore piccolino?». E come darle torto? Chi non desidera accomodare prelibate pietanze sul proprio desco accogliendole con le tonalità meno ingombranti possibile? Piccoline, quindi, va senza dirlo.).
La triplice striscia di ognuna delle nove tavole su cui si sviluppano le infauste (ehm.) vicende della protagonista, prima della decima, conclusiva ed efferata splash-page finale, non è suddivisa in singole vignette ma si apre nello spazio aperto orizzontale da sinistra verso destra che, oltre a richiamare illustri precedenti (dalle grotte di Lascaux ai geroglifici egiziani, come rinfresco da doveroso ripasso della sempre attuale lezione di Scott McCloud, non tralasciando i crostini al formaggio di Winsor McCay, appetizer ideali per un rinfresco, a patto di non invitare Hank McCoy che quello è una Bestia, sai già in anteprima, anzi in antepasto, che si mangia tutto lui.) lascia libero sviluppo alle forme cangianti dei personaggi: nelle loro imprevedibili evoluzioni (o devoluzioni) li vediamo ondeggiare, (ri)flettersi, espandersi, trasformarsi come dei novelli Barbapapà, scaturiti questa volta non dalla morbida sinuosa dolcezza allo zucchero filato di Tison & Taylor, ma da una acuminata penna a sfera, brandita con l’illuminata sfrenata libertà a cui ci ha viziati da decenni il Dottor Pira.
Fausta trascina con sé, ad ogni appesantito e male accolto risveglio, le ansie congenite e le preoccupazioni spicciole (la carenza di (s)piccioli, ad esempio) dell’uomo moderno (?!) e prova a risol(le)ve(/a)rsi grazie al più elementare dei numeri condivisi attraverso l’appendice telefonica che non manca (or)mai in nessuna tasca, dalle più floride a quelle così così. L’offerta è allettante e conveniente: chi non baratterebbe un po’ di amore per tutto il resto?
Nell’esplosiva e concitata sequenza definitiva, previa ad una rinascita degna come massimo di Miller/Mazzucchelli, la nostra cara contraente il Patto di cui sopra, (le) si apre la patta (ehm.) e prende in (doppia) Mano (eh, vedi. Inutile che dici: «Ma, nooo!». Miller centra sempre. Tipo Bullseye, ti ricordi?) la situazione impugnando il problema ed estirpandolo alla radice. A noi astanti, memori nelle orecchie di Gino Paoli (che in fondo tutto si svolge in una stanza), potrebbe sembrare un organo (è un organo) che vibra per noi e per Lei, su nell’immensità del cielo. Ecco ora, dopo un Bloodbath all’altezza (una ventina buona di centimetri, si direbbe, da qui) del suo creatore Peter David, non vibra più. Ma meglio, no? Tutti quei trillini molto notificanti e poco edificanti, alla lunga, infastidiscono.



