Le teorie filosofiche sulla verità, almeno per quel poco che posso saperne (ed è una buona cosa che ne sappia veramente poco), frugando nella memoria rinforzata a colpi di Wikipedia, sembrano slittare, nell’arco del XX secolo e oltre, lungo un pendio parecchio ripido e scivoloso che rimette invariabilmente nello stesso stretto pozzo artesiano le cui pareti paiono essere la realtà e la sempre più ridotta aria respirabile, al suo interno, la verità stessa.
Un trenino logico innestato nella mia zucca (ma anche nelle vostre, penso) mette in fila come materiale rotabile facilmente abbinabile concetti come «realtà», «conoscenza» e «verità», quasi come se si trattasse di benevole autoevidenze indiscutibili, da collegare in diagrammi a scatole-frecce da consulenza contemporanea. Non ho alcuna intenzione di infilarci, cari non-lettori, in un brutto tunnel di gnoseologia dilettantesca (il pozzo artesiano sopra citato è ben più scomodo della trita caverna platonica in cui avevamo comunque imparato a sistemarci), quello che voglio dire, piuttosto, è che nella nostra inesausta ricerca di sicurezza probabilmente agganciamo puntualmente vagoni con scartamenti e sistemi di alimentazione diversi. Un simile convoglio è bene che non tenti mai di muoversi dal luogo metaforico in cui lo componiamo – va bene come feticcio, non come strumento operativo. O meglio, l’esperienza dell’allegorico disastro ferroviario che ne consegue ha un valore formativo non banale, quasi un rito di passaggio, solo che non è per niente piacevole – mette capo all’esigenza di imparare a sopravvivere ubi mures ferrum rodunt, come avrebbe detto il mio prof di letteratura latina annunciando il proprio rotacismo prima di leggere il passo di una certa opera satirica di Seneca. Si è finiti in una landa selvaggia, dove non c’è cibo, non c’è acqua (assonanze di The Waste Land vengono facilissime, «Here is no water but only rock/Rock and no water and the sandy road»), niente ristoro né riparo. La zona del dubbio, insomma, apparentemente inospitale come una Caloris Planitia mercuriana. Apparentemente un corno.

Eppure lì dentro ci si vive – ci si finisce un po’ per scelta, un po’ per imperscrutabile disegno della sorte (stava scarabocchiando mentre era al telefono, nessun disegno, in verità…), un po’ perché proprio non si riesce a stare lontani dai guai – fatto sta che l’illusione si sgretola, il velo di Maya in cortina di piastrelle marroni viene giù tutto insieme di colpo e i tre allegri «vagoncini» restano privi di un mezzo di locomozione: la conoscenza è la prima a venire messa in discussione e la domanda «ne so abbastanza?» gode pure di un certo credito sociale, anche se drammaticamente in via di erosione da parecchi anni a questa parte. Segue, necessariamente, la nozione di verità, ma la disamina qui diventa più privata, quando è riflessione personale (cosa è vero¸ cosa è vero per me, c’è ancora del vino in casa?), oppure sguaiatamente pubblica quando l’inflessione del discorso si fa politica (scegliete voi gli esempi, su questo versante mi sento come Madame de Tourvel in Le relazioni pericolose, esausto, un po’ fottuto e scoglionato in sommo grado, da non volerne più sapere). Se non conosco qualcosa, o non lo conosco a sufficienza, non posso tentare di dire cosa è vero e cosa no. Se il mio avversario può dimostrare, o anche solo affermare, che non conosco qualcosa può togliermi di colpo la possibilità di apparire portatore di una verità, qualunque verità, fosse anche la più piccola. Da qualche parte, in un passo che non trovo più, manco fosse recuperato dal Necronomicon, Horkeimer e Adorno ci spiegano, ci dimostrano, perché è impossibile difendersi da argomenti materialmente falsi. Vabbe’, anche senza i due cervelloni abbiamo sperimentato tutti, sia sulla nostra pelle che nel dibattito pubblico, come le cazzate si mangino viva la verità, come il fosforo bianco la pelle umana. Basta seminare il dubbio – un po’ come il marchese di Rollebon convince il morituro ateo a farsi dare i sacramenti: la paura dell’inferno fa meraviglie. [Non stupirà, ancorché susciterà un livello di interesse che per essere captato ci vorrebbe il rivelatore Atlas del CERN, che io ritenga la scommessa di Pascal una delle cose più brutte, pavide e schifose mai intenzionalmente formulate.]
Infine, ci sarebbe la realtà, ma siamo a un livello ancora più arduo. Come diamine si mette in discussione la realtà? Per quel che mi riguarda rimango al test rapido di Philip K. Dick: «Reality is that which, when you stop believing it, doesn’t go away». A volte ho provato a smettere di crederci – non è mai andata via, e spesso sarebbe stato confortante che l’avesse fatto. In generale, per quel che attiene al discorso comune, collettivo, reale tende necessariamente alla corrispondenza semantica con vero.
Lungo un paio di millenni e mezzo di storia, ma anche da prima, ne sono sicuro, da quando abbiamo potuto smettere, tendenzialmente, di vivere nella fifa più totale di non riuscire a mangiare, e da quando poteva iniziare a non essere più un problema argomentare se la tigre dai denti a sciabola che ti stava inseguendo fosse più vera o più reale – o più illusoria – da allora abbiamo iniziato a porci degli interrogativi tormentosi utilizzando i concetti-vagone che ho citato sopra, e altri ancora, sempre alla ricerca di qualcosa che, invece di creare convergenza, ha prodotto un’esplosione di percorsi interpretativi, e tanta voglia di litigare. Nel frattempo chi più sapeva affondava nelle tenebre di una episteme sempre più esoterica.
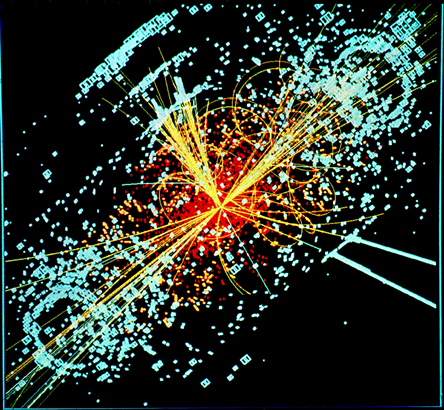
Qualche anno fa un amico mi suggerì caldamente la lettura di La Lite di Cambridge (Wittgenstein’s Poker), un libro piuttosto simpatico incentrato su un evento assai notevole avvenuto nel 1946: l’ospitata di Karl Popper a un dibattito del club (Cambridge University Moral Sciences Club) presieduto da Ludwig Wittgenstein, con un Bertrand Russell in prima fila e, come piatto unico della serata, il tema «Esistono problemi filosofici?». Ora, in prima battuta questo mi fa ricordare l’unico dibattito scolastico a cui ho partecipato. Era un’epoca di occupazione, sicuramente post-Pantera e pre-qualcos’altro – per alcuni giorni l’istituto, un liceo scientifico con un migliaio di studenti, divenne una cosa diversa, imprecisa, incerta, ma pur sempre nuova, inedita. Si assistette a tentativi anche degni di darsi un’organizzazione, un coordinamento con i colleghi di altri istituti anche se non riusciva a essere chiaro per fare cosa, e nel frattempo la vita quotidiana dell’autogestione si riempiva di passatempi più o meno creativi, mentre il consumo di droghe leggere e alcool superava la barriera dei cancelli, senza però degenerare. Tra gli spunti finto-responsabili, a qualcuno venne in mente di organizzare il dibattito dal titolo «Può esistere l’amicizia tra uomo e donna?». Insomma, l’innesco ideale per la molotov del cazzeggio. Non ricordo più neppure come andò, probabilmente una trita goliardia si impossessò di tutto nel giro di pochi minuti, la cosa importante è che non si litigò affatto – Wittgenstein invece a un certo punto impugnò un attizzatoio, anche se i testimoni non concordano sul fatto che fosse la rabbia a guidarlo o, piuttosto, l’esemplificazione di un punto che andava sostenendo, amplificata da un corredo gestuale, da una messinscena, per così dire. Con quel che so della biografia di Wittgenstein, tragica e persino romanzesca (quante volte avete riscattato le vostre sorelle dai nazisti in cambio di una tonnellata punto sette di oro?), propendo abbastanza rapidamente per la prima ipotesi. Fatto sta che Wittgenstein, sfidando Popper a fargli un esempio di legge morale ottenne come risposta «non minacciare un ospite con un attizzatoio» – indicandoci in modo evidente che le discussioni si agganciano con maggiore facilità al contingente, all’esemplificativo piuttosto che all’universale. Ecco perché se fai entrare in un jazz club un metallaro o un musicista classico ti dicono entrambi che la musica è una merda. Poi magari lo è davvero, mica è detto che perché qualcosa è difficile debba essere bello per forza. Pressoché sicuramente, se facevi assistere un bassista jazz al dibattito di Cambridge quello andava a cercare il mobiletto bar con gli scotch, mica era scemo.
Ma è vero che è difficile? Un po’ di decenni fa la musica popolare era in gran parte riconducibile al jazz – voglio dire, le all-girl jazz band degli anni ’30/’40 svolgevano (anche) un ruolo titillante che in seguito sarebbe stato esercitato dalle Madonne, dalle Spice Girls, dalle Rihanne di turno e dalle loro eredi di ultima generazione [alcune hanno dei nomi veramente strani]. Ecco un esempio:
Certo, anche i pezzi pop che hanno sbancato negli ultimi tre decenni mica sono fatti con i piedi – tutt’altro. Sono prodotti bene e registrati ancora meglio, suonati e messi su da gente maiuscola. Solo che sono… più facili, ecco, meno sottili, il linguaggio di cui sono fatti si è generalmente banalizzato, si è investito tanto sulla sonorità, l’elettronica ha aiutato ad aprire nuovi fronti, e si è fatta passare in secondo piano la finezza della trama. Un po’ come passare dal broccato di seta alla tinta unita di uno spandex verde fluorescente. Tanta distanza.
I decenni dai ’60 in poi hanno visto una serie di trasformazioni, tecnologiche in primo luogo, che hanno portato altrove, più che avanti, il discorso della musica «popolare», quella che il periodo precedente aveva liberato da una subalternità da retrobottega, da fiera paesana, da esclusi e reietti, proiettandola sotto le luci della ribalta. Le trasformazioni ci hanno dato strumenti con gamme sonore assolutamente nuove, mai udite prima né lontanamente immaginabili – i generi, e i sottogeneri, musicali sono esplosi anche grazie a questa nuova estesissima varietà. Abbiamo vissuto un’epoca di portentosi e impetuosi cambiamenti – non ultimi quelli guidati dall’estensione dell’utilizzo di Internet (ah se avessi avuto ‘sta cornucopia quando ho iniziato a studiare!).
Ma mentre tutto questo accadeva e accade, fuori, noi qui, dentro (nel nostro salotto, nelle nostre camerette, nei garage, nelle tavernette) che cosa sappiamo? È vero che suoniamo bene? male? Troppi termini di confronto sono lì a portata di mano per farci sentire inadeguati, troppi pochi possono essere accolti in buona fede come testimonianze sincere. Prendiamo l’epoca del gruppo ai tempi del liceo – che, per caso, la gente veniva a sentirci per la musica? Quando andava bene era perché il contorno era appetitoso, perché la festa era organizzata bene – ricordo il mio primo live ai tempi del liceo, tre dita di birra e alcolici sul pavimento di tutta la sala e polizia e carabinieri fuori verso le quattro del mattino. Ma non fu particolarmente esaltante – avevamo suonato di merda, com’era prevedibile. La gente ci si era sorbita e poi i dj avevano fatto il loro lavoro. La storia era andata avanti molto per conto suo.
Ecco, sì, senza troppo timore di far torto a un capolavoro letterario, posso dire che la tua, la mia, esperienza di musicante dopolavorista e da salotto (o liceale) possiamo accostarla al mix sbilanciato di cattiverie, bassezze, disincanti, consolazioni fugaci, lirismi arresi, semiperiferie dannate, impietose messe a nudo di sé di cui è fatta l’anima del Voyage del Bardamu/Céline: in gran parte è essere vittime del proprio tempo, sballottati dagli eventi e da fenomeni su cui non si ha il benché minimo controllo, l’unica reazione possibile ritirarsi in zone e luoghi diversi, ancorché impervi, prendere decisioni evidentemente contraddittorie in preda ad ambizioni spastiche, spesso inconciliabili con principi pure esplicitamente sottoscritti, una incompiutezza di tutto, il discorso frammentato eppure ininterrotto di un condominio interiore di tante voci micragnose. Certo, non abbiamo vissuto, non io almeno, fenomeni come la guerra mondiale, l’industrializzazione fordista, il colonialismo. Un curriculum simile, combinato con il re-innesto nella società del tempo di «pace» non può far presagire vedute troppo rosee, come potrebbe essere altrimenti? («After such knowledge, what forgiveness?» chiede T.S. Eliot prima che il ‘900 vada alla malora in un modo ancora più evidente). Difatti, a un certo punto, l’io del libro ci dice, senza giri di parole, che «la vita è un cazzo fritto». Non sembrano esserci molti appelli per le epoche e per le vite successive, però, a volte, come nel libro, pure se con frequenza tantalizzante, rari, puntiformi, isolati spunti di bontà, di genuinità ravvivano per brevi attimi questi affannati personaggi, comprimari di non sa cosa e di non si sa chi, che siamo anche noi in questa rumorosissima epoca.

Ci siamo attestati qui, in questo territorio inospitale, tremebondi come suricati e tuttavia ancora presenti, assoggettati all’ansia e sovrastati dall’incombenza di una predazione imprecisa ma inesorabile, adattati al mondo di sabbia corrosiva in cui viviamo. Nelle nostre tane, nei nostri cunicoli, che non si vedono né si intuiscono da fuori, conserviamo i paraphernalia (da intendersi nella erronea accezione anglosassone) della nostra attività, cordonandoli dei dettami che ci paiono irrinunciabili: quanti bassi, di che tipo, quali corde, quali amplificatori, quali libri, quali metodi, quali effetti, quali cavi, e via e via. Ci dedichiamo il tempo che possiamo, perché il ritmo dei giorni è scandito da quello delle corvée non dispensabili, se non a pena della destituzione dalla collocazione nella società degli scambi economici. Quindi non siamo molto bravi, non in termini oggettivi, però a volte siamo convinti di quello che facciamo, perché, almeno per un breve lasso di tempo, suona veramente bene. Cerco di ricordar(me)lo più che posso come un mantra, sin dal primo numero di questa rubrica.
Quando riusciamo a suonare in modo soddisfacente la vita ci sorride, e per un attimo lungo quanto quello che impiega il bosone di Higgs a farci cucù, non son più cazzi fritti – o almeno, diventano light. E inoltre il privilegio del suricato, nel suo essere bestiola di piccola taglia e non di primo piano, è di non poco conto. Tenete presente che tutti i musicisti professionisti a cui ho avuto occasione di fare la domanda «quanto spesso sei soddisfatto della tua esecuzione dal vivo?» mi hanno sempre risposto, senza essersi preventivamente messi d’accordo, lungo un periodo di almeno vent’anni: «mai».
E così va oggi, neanche un bassista citato, solo mestieranti di altre discipline. Va bene così. Salutiamoci con un pezzo adatto.
È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.



