Agli inizi di novembre, su queste colonne, Michele Ginevra (QUI, QUI e QUI) si è chiesto se il fumetto è ancora popolare. Si è dato una risposta lunga e articolata, che ha suscitato varie reazioni, e non ha convinto tutti. I due dioscuri-direttori di QUASI si sono accorti del mio disaccordo, e mi hanno invitato a spiegarne le ragioni. Per farlo, dovrò dire sia del quadro storico e critico di titoli e di autori citati da Michele, sia di quello che reputo un errore fondamentale, quando si continua a usare la definizione di “fumetto popolare” in contrapposizione a un’altra errata, quella di graphic novel quale versione attuale del “fumetto d’autore”.
Partiamo da qui.
In Italia si è abituati a identificare il “fumetto popolare” con quello a grande tiratura, meglio se seriale e con un protagonista principale fisso, con uscita periodica in edicola: quindi un fumetto edito fino agli anni Ottanta da editori come Bonelli, Mondadori-Disney, Astorina, Dardo, Bianconi, Cenisio, Eura, Edifumetto, Corno, Universo. Questo tipo di fumetto è più propriamente definibile “industriale”, nel senso migliore del termine, perché la sua realizzazione prevede un preciso processo editoriale volto a far sì che, con cadenza mensile (quindicinale, settimanale) un determinato prodotto arrivi in edicola nello stesso giorno, con lo stesso numero di pagine e lo stesso standard di realizzazione in testi, disegni e paratesti del numero precedente.
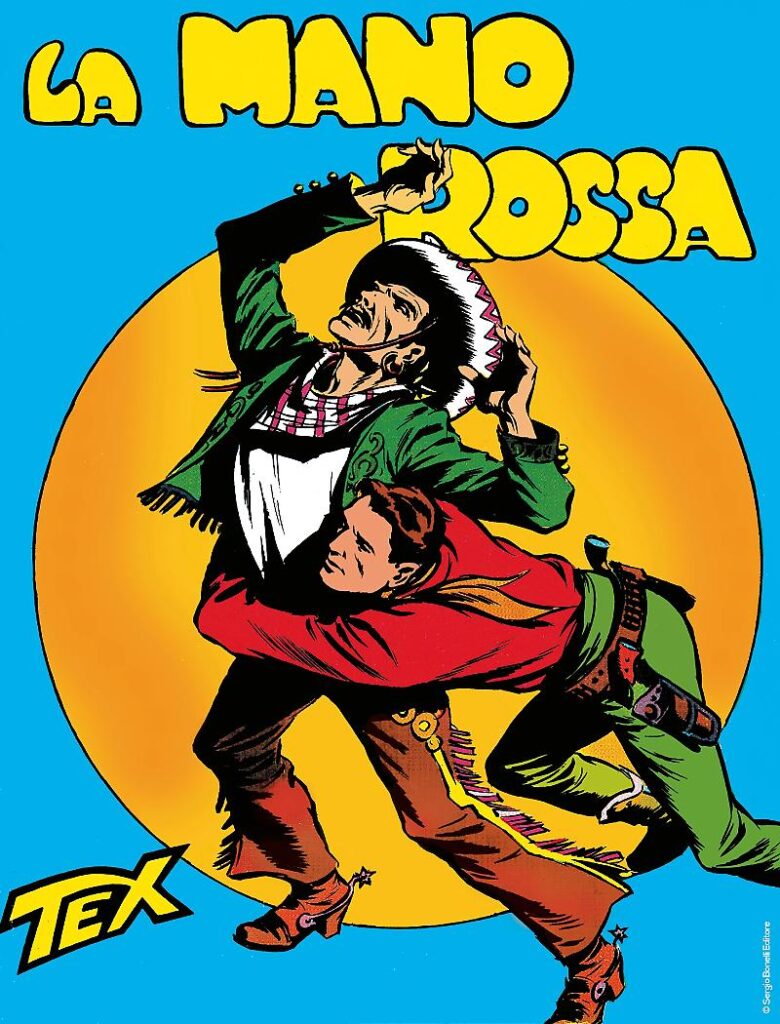
“Tex” è un prodotto industriale come lo è un quotidiano, i romanzi seriali, le saghe cinematografiche, le serie televisive. Per vari motivi storici, l’industria editoriale del fumetto ha privilegiato fin dalle origini questo tipo di prodotto che ha avuto moltissimi lettori, ha dato moltissimo lavoro e ha posto le basi economiche e strutturali (promozione, distribuzione, lettori, stampa) per quello che chiamiamo impropriamente “fumetto d’autore”, ossia libri e graphic novel. Dico “impropriamente” perché ogni opera ha il suo autore, anche, o forse soprattutto, quelle “industriali”, e i capolavori nascono a dispetto dei quarti di nobiltà alla nascita: due esempi per tutti, Terry e i Pirati e Li’l Abner (Little Nemo è troppo facile), nati come strisce giornaliere e tavole domenicali.
Apro una parentesi: in questa terra di santi, navigatori, eroi ed ex studenti di liceo classico old style dove avere 5 in matematica è un onore, l’idea che la creatività autoriale sia inserita in processi lavorativi ha sempre fatto e continua a fare orrore, e per capirlo basta analizzare il lungo cammino che ha avuto un genere letterario come il giallo in Italia. Al di là delle Alpi invece il rapporto tra industria editoriale e autori è dato per assodato e anche raccontato in molti capolavori come Illusioni perdute di Honoré de Balzac, Bel Ami di Guy de Maupassant, Martin Eden di Jack London e perfino il Don Chisciotte di Miguel de Cervantes. Forse perché in inglese e in francese con il termine “arts” (“kunst” in tedesco) si intendono non solo l’arte in sé ma anche i mestieri a essa collegati, quelli che nel Medioevo erano le arti liberali, cioè i mestieri, tra i quali c’erano anche pittura e scultura: infatti anche geni come Leonardo o Piero della Francesca dipingevano a comanda. Chiusa parentesi.
In Italia si è chiamato “popolare” quel fumetto industriale che aveva il suo canale preferenziale nelle edicole solo a causa delle sue vendite. All’epoca, anche quando queste erano basse, erano sempre più alte di quelle di romanzi letterari e libri a fumetti in libreria. Sì: i libri a fumetti erano in libreria e in pianta stabile, ben prima della nascita del termine graphic novel, sia per editori letterari (Mondadori, Rizzoli, Bompiani) sia piccoli e/o alternativi (Lerici, Savelli, Ottaviano), e anche con opere che non venivano prepubblicate su rivista ma direttamente in volume
Era l’epoca in cui Sergio Bonelli diceva che qualunque cosa pubblicasse vendeva minimo 40 mila copie. Che era il minimo per pareggiare i conti. Perché questo tipo di fumetto ha un grosso punto debole: costa molto in termini di tiratura, all’epoca c’erano più di 30 mila edicole da raggiungere, quindi deve vendere molto, sennò muore. Poi arrivarono gli anni Ottanta: fu nella seconda metà di quel decennio che, nonostante il successo di “Dylan Dog”, esplose quella crisi delle vendite del fumetto da edicola che travolse uno dopo l’altro, prima gli editori “industriali” in apparenza consolidati come Universo, i cui settimanali “Monello” e “Intrepido” erano arrivati a vendere anche centinaia di migliaia di copie a settimana, e dopo tutte le riviste cosiddette d’autore, costringendo, di conseguenza, a interrompere la produzione di libri a fumetti e portando i suoi autori a emigrare all’estero oppure a cercare rifugio presso i pochi editori che ancora riuscivano a produrre fumetti, come Disney, Bonelli e Eura. È in questo periodo che si palesa l’equivoco che “popolare” e “industriale” non sono affatto sinonimi.

Racconto a questo proposito un aneddoto vissuto in prima persona. Nel 1989 sono appena iscritto all’università e il successo di “Dylan Dog” era al massimo insieme a quello di “Lupo Alberto”. Durante le elezioni studentesche di quell’anno, la lista di CL (Comunione e Liberazione) organizza a Perugia, dove abitavo, un incontro con un disegnatore di “Dylan Dog”, Giampiero Casertano, che arriva con Pasquale del Vecchio. Nonostante la pensi in maniera, diciamo così, diversa da CL, ci vado anch’io. La sala designata è enorme e gremita, al punto che si deve organizzare un servizio d’ordine per proteggere i disegnatori. La città è piccola, di vista ci conosciamo tutti, e quindi rimangono stupito nel vedere tra il pubblico tante persone che conosco e che mai avrei pensato leggessero “Dylan Dog” o anche solo dei fumetti. Iniziano le domande dal pubblico e subito arriva la prima da parte di un mio compagno di università che chiede: «Ho visto che su Dylan si fa pubblicità ad altri fumetti, tipo Zagor, Tex o Nick Raider, io ho provato a leggerli, ma li ho mollati subito, non sono brutti solo che non dicono nulla, ma perché li pubblicate?» Mormorii di approvazione dal pubblico, tanto che nei giorni successivi molti amici mi faranno la stessa domanda (ero già quello dei fumetti). In quel momento Casertano sbianca, e come dargli torto, quindi risponde che no, non sono brutti, ma scherzi?!, sono fatti dagli stessi professionisti di Dylan e quindi bisogna leggerli perché sono belli.
La risposta, purtroppo, era sbagliata.
La risposta giusta era che quei fumetti non erano letti perché non parlavano più la lingua dei lettori: non perché fossero brutti, (va bene, qualcuno era anche brutto), ma semplicemente perché il loro linguaggio era diventato obsoleto, nei testi come nei contenuti. Un po’ come quando a metà anni Settanta sbarcarono prima Goldrake e poi Indiana Jones, e quindi la mia generazione scese dall’arca di Yoghi e salì sull’Arcadia di Capitan Harlock: chi sarebbe tornato indietro? Nessuno, e infatti lo stesso accadde nei fumetti. Anzi, se all’epoca qualche editore avesse pubblicato i fumetti giapponesi originali e non i brutti surrogati autoctoni, i manga avrebbero invaso il Belpaese già allora. E quindi: chi poteva appassionarsi a “Nick Raider” dopo aver visto Miami Vice, Hill Street o come minimo Magnum PI? È vero che c’erano dei sempreverdi, come “Diabolik” o “Tex”, ma sempre con meno forza man mano che le generazioni cambiavano. Da allora, le case editrici egemoni del mercato editoriale italiano non hanno investito in maniera sistemica in nuovi autori, nuovi temi, nuovi modi di scrivere, disegnare, raccontare. Non hanno saputo rinnovare i loro personaggi ma hanno perseverato nel cammino già tracciato. Un caso da manuale furono i settimanali della Universo che in passato avevano venduto copie su copie pubblicando storie che trattavano degli stessi interessi dei loro lettori, ossia la musica, lo sport e la scuola accanto quelle di genere (giallo, western, ecc.), e che ora erano sul baratro della chiusura (ci fu poi la fiammata di “Intrepido” di Sauro Pennachioli). Anche i cosiddetti bonellidi e gli epigoni di “Dylan Dog”, a parte pochi casi isolati, non ebbero vita lunga. E questo accadeva perché games, videogiochi e serie televisive parlavano ai lettori con una lingua e delle storie che nel fumetto non trovavano. O meglio: lo trovavano nei manga, come “Dragon Ball”, “Dylan Dog” e “Lupo Alberto”, proprio come oggi in Zerocalcare, Gipi, Yole Signorelli, Ortolani (li ritroveremo più avanti).
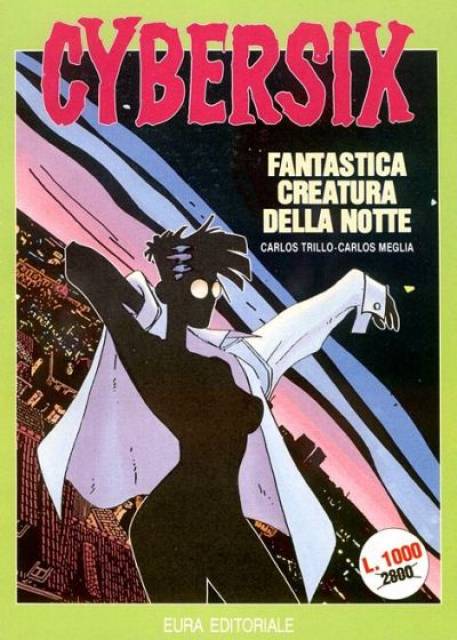
Dagli anni Novanta in poi il pubblico, in particolare quello più giovane, ha trovato le sue storie e il suo linguaggio nei manga, registrando il successo ancora oggi senza precedenti di “Dragon Ball”, e in parte anche nei supereroi che dal decennio precedente si stavano rinnovando. Furono altri due cambi di linguaggio che gli editori italiani non seppero cogliere nonostante “Sprayliz” di Luca Enoch fosse partita con il piede giusto. Lo stesso accadde per “Cybersix” di Carlos Trillo e Carlos Meglia,e le due incarnazioni della rivista “Cyborg” ideata di Daniele Brolli. Bonelli capitalizzò il successo dell’Indagatore dell’incubo varando il Dylan Dog Horror Fest (quattro edizioni), e proverà ad avvicinarsi a quel pubblico con uno spin off di “Nathan Never”, la testata di “Legs Weaver”. In casa Disney tra il 1995 e il 2012 si sperimentò molto: si iniziò con “PK”, che seppe dialogare con le nuove generazioni riprendendo temi e linguaggio sia dai fumetti giapponesi sia da quelli dei supereroi, seguito dal breve (ma intenso) “Mickey Mouse Mistery Magazine” (1999-2001), quindi il successo planetario e la seguente caduta di “W.I.T.C.H.” (2001-2012), infine da “Monster Allergy” (2003-2006, poi ripreso a Tunué ndal 2015). Qualche altra luce venne dagli autori riuniti intorno a “Mondo Naif”, rivista nata in casa Kappa dalle ceneri di “Dinamite”, voluta, guarda caso, dal solito Bernardi, sulle cui pagine si sono affermati Davide Toffolo, Giovanni Mattioli, Vanna Vinci, Sara Colaone, Otto Gabos, ecc. Infine, il mensile di “Lupo Alberto” divenne un punto di ritrovo per adolescenti di tutta Italia che organizzavano raduni, detti “Tane del Lupo”, accordandosi sulle pagine della rivista. Un vero peccato che il gemello “Lupo Alberto Magazine” non decollò: le storie di Tank Girl di Alan Martin e Jamie Hewlett e quelle delle Locas e della gente di Palomar dei Fratelli Hernandez lì pubblicate vi avrebbero trovato il loro vero pubblico.
La crisi del fumetto industriale ebbe due conseguenze.
La prima fu la progressiva chiusura delle riviste. Da allora fino agli anni Novanta, in Italia come in Europa le riviste a fumetti caddero a una a una perché non erano più un luogo di dialogo con i lettori ma solo una vetrina per le storie a puntate che poi uno avrebbe ricomprato in libreria. Nella caduta furono travolte anche quelle più recenti, come “Comix”, “Corto Maltese” e “Dolce Vita”, e quelle per bambini come “il Corriere dei Piccoli” e “Snoopy”. Con un problema in più: a parte Milano Libri, le case editrici di queste riviste (come Comic Art e Nuova Frontiera) non avevano la struttura e la mentalità per sbarcare in libreria. Le uniche riviste che continuarono a uscire furono “Frigidaire”, “Blue”, “Il Giornalino” (con lo spin-off “G Baby” per i piccolissimi) e “Linus”. Di queste, oggi solo le ultime due sono ancora vive. Questo perché, ognuna a modo suo, con i loro articoli e i loro fumetti (fra quelli di “Linus”, Maus di Art Spiegelman e Doonesbury di Garry B. Trudeau), ha tenuto sempre aperto un dialogo con quei lettori che vedono il fumetto come uno dei tanti linguaggi per raccontare il mondo e non come una collezione da avere completa. Per una coincidenza all’epoca entrambe erano osteggiate al punto che nessuno si filò Il commissario Spada di G.L. Gonano e Gianni De Luca, mentre i due volumi di Maus di Art Spiegelman, ebbero successo di pubblico e di critica fuori dal mondo del fumetto. Lo aveva capito Luigi Bernardi che, con Granata Press, aveva contaminato il fumetto con il romanzo, i film, la saggistica e la politica, ma la sua esperienza editoriale finì prima di coglierne i frutti. Già che c’era, Luigi portò in Italia, definitivamente, anche i manga (aveva cominciato nel 1990 con “Akira” di Otomo Katsuhiro per Glénat Italia), di cui qualcosa si era visto nelle pagine della rivista “Eureka” nel 1980, dove furono ospitate storie di Tatsumi Yoshihiro, Ishinomori Shotaro e Saito Takao (“Golgo 13”), e poi “Black Jack” di Tezuka Osamu nel 1983.
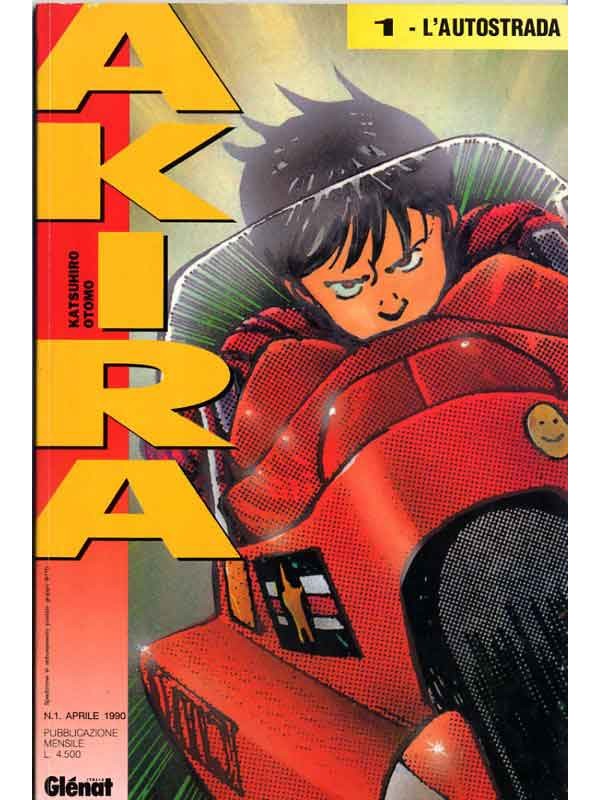
La seconda conseguenza fa la creazione di un gap generazionale nei lettori. Molti che si sono avvicinati al fumetto in quegli anni hanno infatti saltato a piè pari tutti quegli autori italiani e stranieri pubblicati nelle riviste, autori che in parte avrebbero ritrovato sotto forma di libro solo dalla fine degli anni Novanta, quando nacquero piccoli editori (Kappa, Coconino, Black Velvet, BD, Tunué, ecc.) che li riportarono in libreria e in fumetteria.
Fu una scelta inevitabile. In assenza di un mercato di ampio respiro, i costi di produzione e distribuzione per tornare in edicola erano insostenibili. Arrivarono comunque nuovi libri, nuovi autori, si aprirono mercati, soprattutto all’estero. Siamo però ancora lontani dai fasti degli anni passati: in Francia, e ancora di più in Italia, gli autori di fumetto faticano a mantenersi con il solo lavoro editoriale come mostra il recente lavoro del gruppo di ricerca MeFu (Mestieri del Fumetto), e i cahiers de doléances dei colleghi francofoni.
Oggi, dopo anni di pubblicazioni, sono approdate ai graphic novel anche le grandi case editrici di narrativa come Mondadori, Rizzoli, De Agostini, Salani, Fetrinelli: un po’ per riprendere un discorso interrotto all’inizio degli anni Novanta, un po’ per cercare nuove nicchie di mercato dove espandersi (solo Mondadori e Rizzoli avevano continuato a pubblicare fumetti: la prima negli Oscar, la seconda nella BUR). Accade questo un po’ perché nel resto del mondo gli editori stanno scoprendo il “graphic novel” per adulti e ragazzi, un po’ perché i quotidiani avevano scoperto nei fumetti degli allegati molto remunerativi. Anche in Francia la fine delle riviste alla fine degli anni Novanta ha spinto tutta la produzione fumettistica in libreria, ma lì c’era già un pubblico già abituato da molti decenni a questo prodotto, mentre in Italia è stato necessario ritrovarlo dopo anni di assenza. Per ora l’offerta sta superando la domanda, ma non disperiamo.
In questi anni alcuni autori si sono affermati al grande pubblico e sono diventati popolari, tanto da pubblicare anche in periodici fuori dal mondo del fumetto, grazie a vendite molto importanti: Zerocalcare, Gipi, Ortolani, Yole Signorelli, oppure nel campo del fumetto seriale le riviste e i libri di Sio, il serial “The Walking Dead” di Robert Kirkman, Tony Moore e Charles Adlard e il sempre verde “Dragon Ball” di Akira Toriyama. Sono autori popolari perché hanno trovato decine, quando non centinaia di migliaia di lettori che hanno deciso così, a prescindere dai desiderata degli editori e dalle diverse nascite editoriali: edicola, libreria, rete. Sono autori completamente diversi l’uno dall’altro per segno, storie, età, formazione ed esperienze editoriali: l’unica cosa che hanno in comune è che a priori nessuno avrebbe scommesso sul loro successo. A posteriori possiamo dire che sono le loro specificità a farli diventare “popolari”, ossia a far incontrare a ciascuno di loro il grande pubblico. Quel che è certo è che oggi questi autori sono il nuovo standard narrativo con cui si deve avere a che fare.
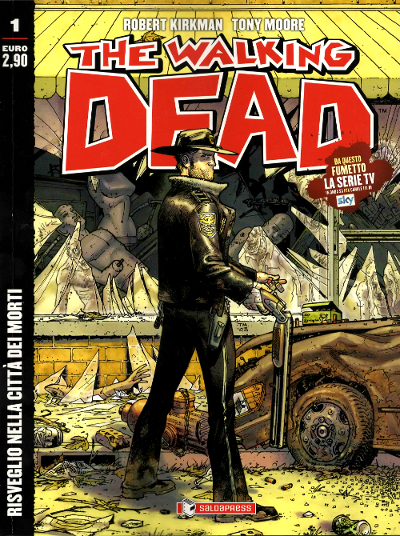
Non importa se piacciono o non piacciono: chi lavora in questo settore non può prescindere da queste narrazioni e da questi autori.
Un’autrice come Yole Signorelli ha colmato un vuoto nella nostra narrativa a fumetti: basta andare a una sua presentazione e osservare il vasto pubblico in sala per rendersi conto di come, con soli tre libri, Yole abbia saputo dare parole e immagini a chi non le aveva, esattamente come Zerocalcare. Lecito domandarsi quali opere faranno in futuro questi autori, meno lecito stroncarli a priori. Invece di domandarsi se questi sono fumetti o graphic novel, se sono fumetto d’autore o popolare, di fronte a questi successi editori, autori e operatori dovrebbero chiedersi quale domanda soddisfano queste opere.
Ma è possibile creare un fumetto che sia a priori popolare? Purtroppo non esiste una formula per creare successi popolari a comando, sennò qualcuno l’avrebbe già utilizzata. Il successo di un fumetto non dipende dalla sua origine, se nato come seriale o come libro a sé, quanto dalle sue vendite e dall’impatto che ha sul pubblico una volta finita la lettura, nel bene come nel male: solo che nessuno sa a priori quando e se accadrà, e quale la forma e quale contenuto servano a raggiungere tale obiettivo, come mostrano le macroscopiche differenze di stile e contenuto degli autori sopracitati.
Si potrebbe pensare che il successo di Yole Signorelli o di Zerocalcare fosse prevedibile perché parlano dei fatti loro e mettono loro stessi come protagonisti, due fattori che, nell’era del narcisismo, paga. Ma è davvero così? L’autofiction è presente da anni nel mondo editoriale, in letteratura anche troppo, ma non tutti questi prodotti hanno lo stesso successo. Si può provare a imporre un prodotto con la forza un po’ sul modello dei blockbuster cinematografici, ma se qualcosa va storto il fallimento è dietro l’angolo, come sanno i nostri editori di varia che di presunti bestseller costruiti a tavolino hanno pieni i magazzini (qualcuno ricorda il libro del vincitore del talent letterario “Masterpiece”?). Difficile però pensare che un prodotto editoriale abbia qualche possibilità di diventare popolare se non ha alcuna sintonia, linguistica e/o contenutistica con il pubblico a cui si rivolge (incredibile che in Italia il bestseller sul calcio sia stato la serie Gol! di Luigi Garlando, composta da romanzi per ragazzi che aveva anche inserti a fumetti, mentre in Bonelli o in Disney non abbiano mai pensato a una serie su questo sport) o viene pubblicato usando canali di distribuzione e promozione, per esempio le edicole, che i lettori non usano più.
Sergio Bonelli aveva ragione quando diceva che games e serial televisivi rubavano lettori al fumetto, ma solo perché hanno innalzato l’asticella del pubblico nei gusti e nel linguaggio. Pubblico che, in partenza, non disdegna alcun genere a priori, dato che è capace di passare da The Crown alla Regina degli scacchi passando per The Walking Dead, A Game of Thrones, Strange Things, Peaky Blinders, I Soprano e così via. Quindi anche l’alibi “i lettori non leggono (mettete un genere a caso)” non funziona. Lo vediamo bene dal successo di vendite di serie come “Harry Potter” di J.K. Rowling e “Millennium” di Stieg Larsson; con il divario di popolarità che si è creato tra i fumetti dei supereroi, sempre in ristrettezze di vendite, e il successo dei film con gli stessi personaggi, oppure con la fatica che fanno a ritrovare lettori personaggi di successo come “Dylan Dog” e “Lupo Alberto”, probabilmente troppo consumati da decenni di onorato servizio e dal prosciugamento del loro canale privilegiato di vendita e promozione, le edicole, prosciugamento che deriva dalla crisi dell’intero comparto editoriale a cui appartengono quotidiani, riviste e periodici.
Per chiudere, vorrei in parte dissentire anche da quanto scriveva, sempre su QUASI, Giorgio Trinchero sulla distinzione tra “fumetto”, inteso come quello che leggiamo e ci suscita emozioni, e il “prodotto”, ossia il manufatto fisico che veicola la narrazione, nella discussione sulla copertina e l’intervista del magazine “Sette” a Yole Signorelli. In sintesi, secondo Trinchero quando parliamo di prodotto in realtà parliamo dei soldi a esso collegati. Se da un lato potremmo dire che questa distinzione tra fumetto e prodotto potrebbe essere vera per chi legge un fumetto (ma anche un romanzo, un racconto, un film), dall’altro non lo è più per chi quel prodotto, qualunque sia, lo realizza. Ogni autore sa bene che le caratteristiche editoriali sono vincoli ineliminabili che potrà subire passivamente oppure utilizzare per trovare nuove soluzioni narrative. Anche le grandi opere della storia dell’arte nascono da commissioni ben precise che toccano ogni parte dell’opera. Le prime storie di Corto Maltese hanno tutte 20 pagine perché erano le sole che la rivista “Pif” metteva a disposizione di Pratt: questo non ha impedito al buon Hugo di creare una serie di capolavori che, quando li leggi, ti scordi della loro lunghezza, e che non hanno nulla di meno delle successive storie più lunghe.
E poi, davvero tutti i lettori non distinguono tra fumetto e prodotto facendosi abbagliare dal fatto che un autore è in copertina? È chiaro che una copertina non garantisce a priori copie vendute in più, come i fatti dimostrano, ma di certo una maggiore visibilità per librai, promotori, produttori televisivi, o anche editori stranieri che possono interessarsi per i diritti di traduzione. E infine: davvero agli autori non interessa ricavare soldi dalla propria opera che è anche il proprio lavoro? Fu lo scrittore latino Petronio a definire con precisa schiettezza nel Satyricon (I secolo d.C.) che «Amor ingenii neminem umquam divitem fecit» («L’amore dell’ingegno non ha mai fatto ricco nessuno»), citazione poi riassunta nel Medioevo come «carmina non dant panem», come sanno bene tutti gli artisti che, da Omero in poi, si sono dovuti cercare dei mecenati o un altro lavoro per permettersi di realizzare il proprio talento. Sulla ricerca di visibilità che si traduce in soldi e prebende anche da parte di autori più recenti, consiglio di leggere il testo di Francesca Sanvitale in coda alla sua traduzione per Einaudi di un classico francese del XX secolo, Il diavolo in corpo di Raymond Radiguet, che racconta il lancio commerciale alla sua uscita nel 1923. Il raffinato editore Grasset usa ogni mezzo, dal pettegolezzo allo spot cinematografico, per trasformare in bestseller il libro del giovane autore esordiente scoperto da Jean Cocteau, giocando sul fatto che il protagonista del romanzo è l’autore stesso.
Oggi il gioco dei media è parte ineludibile del mondo editoriale in cui si trova il fumetto. E dato che il fumetto, inteso come prodotto e come emozione che racconta, è entrato da protagonista in questo grande gioco, è normale che alcuni autori diventino popolari, finiscano in copertina e altri no, anche a prescindere dalla qualità delle loro opere. Lo stesso accade per il romanzo, per il cinema, per la televisione. Questo accade anche perché non viviamo un mondo perfetto ma, anzi, è un mondo più duro di quello del passato, più grande, più incerto, più precario, pieno di grandi rischi ma anche di grandi possibilità, e forse proprio per questo dovremmo impegnarci per cambiarlo anche unendo le forze, anche alzando l’asticella delle opere che proponiamo invece di scannaci tra simili. Grande la confusione sotto il sole, il momento è propizio (forse).



