«Tutti i movimenti ai bordi del fotogramma, le vibrazioni della camera dovuti al mio respirare, al battito del mio cuore, ai miei passi, ai miei movimenti: questi sono tutti ritmi diversi. Un’altra categoria di ritmi sono i movimenti delle persone all’interno dell’inquadratura. Una terza categoria sono i movimenti creati dal passaggio da inquadratura a inquadratura. E io devo articolare queste tre categorie in modo armonico e adeguato a quello che sto filmando.»
Con queste parole, parafrasate da una conversazione con il pubblico del 1972, Stan Brakhage (1933-2003), uno dei più famosi film-makers di cinema sperimentale americano, descriveva la tecnica del suo montaggio.
Il cinema sperimentale è un fenomeno che, dopo essere stato un’appendice di alcune avanguardie storiche, dalla fine della seconda guerra mondiale ha cominciato a strutturarsi in modo organico e indipendente, attraverso gruppi e cooperative nazionali, a cominciare dagli Stati Uniti con il New American Cinema. Non stiamo parlando di cinema distribuito nelle sale, né con un sistema produttivo alle spalle, merchandising o franchise. Tutto l’opposto. Il cinema sperimentale avversa completamente l’idea produttiva alla base di Hollywood, essendo in primo luogo quasi completamente artigianale e “casalingo”. Un cinema che si muove ad altre velocità, che propone altre velocità, altre visioni, percezioni e ritmi. Completamente fuori tempo, in ogni tempo. Cinema che non guarda nessuno, insomma.
Marco Lori è un amico che ha passato molti anni della sua vita a studiare l’opera di Brakhage come ricercatore universitario a Londra, dove ha completato un PhD in Film Studies, con la tesi Stan Brakhage’s Spiritual Imperative: Its Origins, Corporeality, and Form (Birkbeck University, 2017), e ha poi organizzato varie proiezioni e conferenze, curando la raccolta di saggi, inedita in Italia, Stan Brakhage. Realm Buster (John Libbey Publishing, 2018). Gli ho fatto qualche domanda sull’opera di Brakhage, così da aiutarmi a rintracciare quel ritmo fuori tempo che mi è parso di intendere nel suo cinema.

Francesco: Ciao Marco, intanto grazie per aver accettato questa intervista, o chiacchierata se preferisci. Per prima cosa ti chiedo: qual è la differenza fra il cinema considerato classico o narrativo e quello sperimentale?
Marco: Tra gli “esperti” le opinioni variano in base alle posizioni ideologiche o agli interessi settoriali. Ma di fatto, se il cinema comunemente inteso può essere definito con una approssimazione accettabile, sul cinema sperimentale (mi riferisco qui a cinema analogico) la casistica si apre talmente tanto che nessuno è mai riuscito a dare una definizione, specie dagli anni ‘80 quando ha cominciato a ibridarsi con la videoarte, la performance, l’installazione, l’arte concettuale, e il circuito internazionale delle gallerie d’arte.
Comunemente, intendiamo il cinema come un settore economico che si è sviluppato obbedendo a logiche e necessità industriali, di mercato. Cinema quindi dominante nel senso dell’idea dominante che l’opinione comune ha del cinema, il senso comune della parola cinema, nonché il cinema ovviamente più praticato. Cioè la forma di cinema che ha prevalso su tutte le altre in quanto più adatta a soddisfare le esigenze della cultura occidentale dominante.
Il cinema sperimentale è (quasi) tutto il resto. Mi è sempre piaciuto immaginare un termometro per sottolineare che ci sono sfumature intermedie, non compartimenti stagni. Se ad un polo del termometro c’è il cinema di Hollywood, e tutto quello che da esso è derivato, dall’altro polo c’è l’infinita casistica del cinema sperimentale. Nel mezzo c’è il cinema d’autore (Fellini, Antonioni, Godard, Herzog, ecc.) dove la “voce” è sì molto più personale ma la sua articolazione si rifà ancora a quei principi dominanti. Questo non toglie che molti film-makers sperimentali apprezzassero autori come quelli che ho nominato e viceversa.
Molti, e in parte anch’io, sostengono che il discrimine tra cinema comunemente inteso e cinema sperimentale sia la narrazione. Cioè, il cinema sperimentale sarebbe non-narrativo, mentre la forma che si è rivelata più efficace per vendere film, per massimizzare l’identificazione e per veicolare ideologie al pubblico, è la narrazione. Anche se questa divisione non è totalmente accurata, è utile per farci uscire dalla logica a cui siamo abituati quando si parla di cinema. Una logica per la quale quando ci viene chiesto di parlare di un film, o quando ne leggiamo, si comincia sempre dal genere e dalla trama. Dicevo che la discriminante della narrazione non è totalmente accurata perché esistono film sperimentali che utilizzano stilemi narrativi, anche se è sempre una narrazione debole e non è mai il principio originario a cui tutto obbedisce o con cui bisogna fare i conti.
Le esigenze della narrazione hanno determinato quella che è la grammatica del cinema così come la si studia nelle università e nelle scuole di cinema, così come la si utilizza nella produzione di immagini in movimento e, in definitiva, così come è penetrata nel nostro immaginario comune. Una grammatica completa di tutte le sue variazioni, eccezioni e strappi alla regola, che però si rifanno sempre al principio originario.
Nel cinema sperimentale tutto questo non c’è perché mancano dei principi a priori ed ordinatori, manca la logica del mercato, manca l’ideologia dominante, manca la necessità del narrare. Tutto è appannaggio del singolo film-maker. Possiamo pensare a come un Jackson Pollock creava i suoi dipinti: un’espressione personale che solo incidentalmente può essere apprezzata da un fruitore. Il dipinto non è concepito con quello scopo ma per esprimere un non meglio determinato “qualcosa” dell’autore. Una analogia usata spesso negli anni ‘50 e ‘60 negli Stati Uniti era che il cinema commerciale è come la prosa, mentre il cinema sperimentale è come la poesia. E nonostante esista il romanzo sperimentale, la dicotomia in questo modo diventa più chiara. il film-maker è prima di tutto un artista e un artigiano che, a fronte di uno strumento come la macchina da presa, così come la penna del poeta o i colori del pittore, si trova davanti ad infinite possibilità. Quasi sempre si autofinanzia, esprime una visione completamente personale, esegue in prima persona tutte le operazioni per fare un film. Il cinema sperimentale sarebbe l’anarchica somma di tutte queste individualità.

In questo contesto, come e dove si inserisce Stan Brakhage? E cosa del suo lavoro ti ha spinto a studiarlo per tanti anni?
Stan Brakhage è forse il film-maker sperimentale più famoso al mondo. Questo perché nei suoi anni giovanili e di maggior fama nell’ambiente (e purtroppo la sua immagine è rimasta prigioniera di questo stereotipo creato da certi critici che lo hanno canonizzato ma al contempo anche “marchiato”) ha incarnato l’idea del genio romantico. Il genio che si ritira in solitudine sulle montagne rocciose a creare tormentosamente e febbrilmente le sue opere visionarie, suggestive, mistiche. Genio e sregolatezza. Questo può essere vero per gli anni ‘60, precisamente tra il 1958 e il 1969.
Nella sua vita Brakhage ha creato tra i 350 e i 400 film (di cui solo 25 sonori), tra il 1952 e il 2003, il più breve di 9 secondi e il più lungo di 4 ore e mezza. La media è comunque tra i 10 e i 15 minuti. L’aspetto su cui non si insisterà mai abbastanza è la varietà della sua opera. È possibile dividerla molto grossolanamente in filoni, in tendenze periodiche, e sicuramente la sua “mano” è sempre evidente (un suo film è difficilmente confondibile con quello di qualcun altro); ma le opere hanno delle differenze cruciali che spesso non vengono considerate perché si va sempre a cercare l’aspetto visionario, lirico e autobiografico.
Se si somma alla varietà dei suoi film la generale apertura e ambiguità di senso che lui ricercava e la sua quasi impossibilità a descrivere e teorizzare la sua arte in modo preciso, si capisce come vi siano in qualche modo molti, moltissimi Brakhage. Ma questo non è neanche del tutto contrario alla sua consuetudine di creare film senza bene essere consapevole di quello che stava facendo e di darli quindi al mondo in modo libero. Un famoso esempio sulla apertura (non ambiguità nel senso di casualità) è un documentario, paradossalmente, che Brakhage girò a Pittsburgh a bordo di una volante della polizia seguendo la loro attività di routine per un giorno. Il documentario, eyes (1971), negli anni successivi fu proiettato sia dalla polizia, per mostrare come il loro operato fosse corretto, sia dalle Black Panthers, per dimostrare come la polizia fosse criminale.
Personalmente mi ero inizialmente avvicinato a Brakhage in quanto il suo cinema incarna una libertà e al contempo una critica ai modelli visivi (e non solo) occidentali, selvaggia, inaudita e innegabile. Studiandolo ho poi cominciato ad apprezzare il suo complesso retroterra culturale, figlio di una lunga tradizione di un modo specifico e molto antico di intendere l’arte; così come la effettiva raffinatezza del suo cinema apparentemente brutale e viscerale. Per chiarire meglio questo punto suggerirei una analogia con la pittura espressionista astratta.
Parlandone fra noi mi hai detto che uno degli aspetti del cinema sperimentale, e di quello di Brakhage in particolare, è il ritmo. Mi spieghi perché?
Questa è un mia convinzione che motivo col fatto che mentre una serie di accorgimenti tecnico-stilistici di un film sperimentale, ma qui restringiamo il campo a Brakhage, è in qualche modo analizzabile, nel senso di identificabile e descrivibile, “misurabile”, l’abilità nel montare di Brakhage, cioè il ritmo dei suoi film, la modulazione del tempo non solo del film ma anche del tempo interiore di chi guarda, così come l’orchestrazione armonica del materiale visivo, è un qualcosa che per essere riconosciuto deve appunto essere ri-conosciuto. È una sensibilità, un gusto che chi guarda deve già in parte avere in sé per poterlo apprezzare. Allo stesso modo in una poesia tutti gli accorgimenti tecnici sono elencabili ed analizzabili singolarmente, ma l’armonia del tutto, che è comunque articolata tramite queste tecniche specifiche, è qualcosa che solo alcuni riescono ad apprezzare. Così come il gusto, i gusti, di un buon vino (si tenga anche presente che per Brakhage il ritmo di un film non era limitato al solo montaggio ma si cominciava già a creare nelle esposizioni, nei colori, nelle composizioni, nei movimenti di macchina, ecc.)
Se noi pensiamo a come si insegna a fare cinema, ed insegnare al giorno d’oggi è principalmente dare dei parametri, specie per quella che è la pratica, ebbene non esistono parametri che non siano arbitrari per quanto riguarda il montaggio. Per il montaggio non esiste nulla che indichi con precisione ed efficacia per quanti secondi una certa inquadratura va mantenuta o per quanto tempo un certo movimento va seguito, o quali sequenze accostare. Se pensiamo poi al montaggio senza lo scopo di narrare, ecco che esso non ha più nemmeno i parametri della intelligibilità narrativa e della identificazione: si trova completamente libero. Ed è qui che la sensibilità del singolo entra in gioco, così come l’analogia con la musica.
Brakhage si trovava spesso di fronte a sequenze astratte (filmate o dipinte direttamente in pellicola), e dichiarava quindi di montare in modo intuitivo, con grandissima fatica (nel senso che gli serviva un grado di concentrazione altissimo che lui definiva trance), e senza alla fine essersi reso conto di quello che aveva fatto, ma avendo la consapevolezza che era fatto.
Brakhage a mio avviso è il film-maker in cui il ritmo (ed uso il termine in senso ampio) del film è più immediatamente percepibile e allo stesso tempo sofisticato. Più armonioso. Molte persone a cui ho mostrato certi suoi film, nonostante abbiano commentato con un «non ha senso», o magari non l’abbiano neanche apprezzato, sono rimaste però affascinate e quasi ipnotizzate dal ritmo del flusso visivo, come si potrebbe rimanere affascinati da una musica.
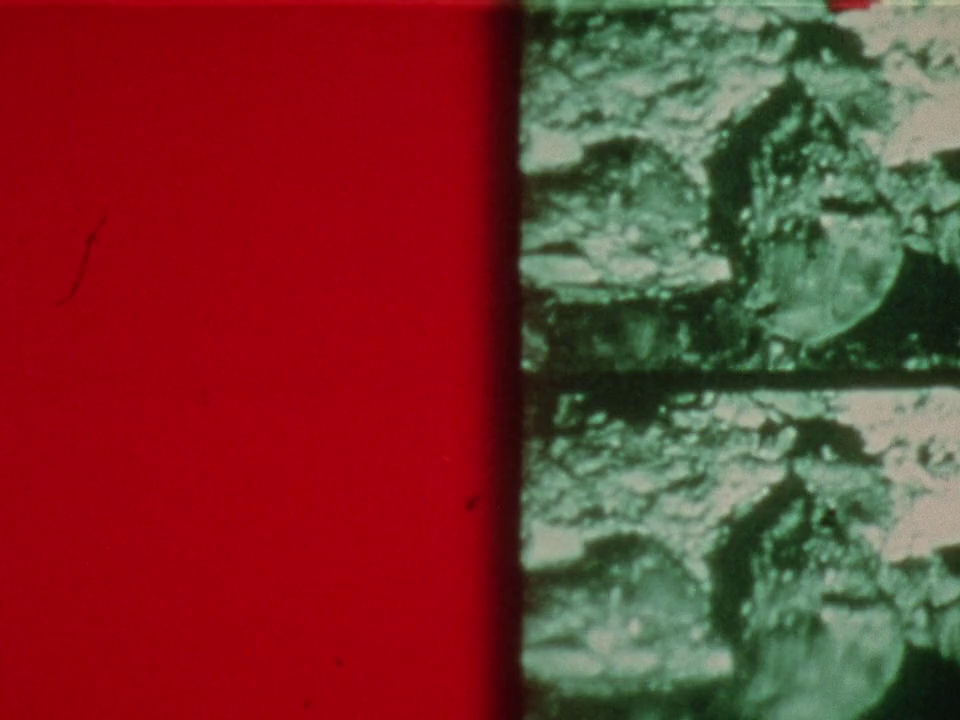
A questo proposito, Brakhage era un grande ammiratore della poesia di Ezra Pund, altro ricercatore e trovatore del ritmo che in qualche suo scritto, come mi hai raccontato, riporta questo motto (cito a memoria): “Tutte le arti aspirano alla musica”. È quindi nel concetto di ritmo di cui hai parlato sopra che nel cinema di Brakhage si trova Pound, o c’è anche altro?
Brakhage è stato un lettore e studioso di Pound sin da quando aveva 16 anni. Dobbiamo ricordare che Pound ha avuto una influenza incalcolabile sulla letteratura anglosassone, anche se da noi è limitato al ricordo del suo fascismo e della sua pazzia. Quando Brakhage dichiarava le sue influenze artistiche ha sempre nominato principalmente dei poeti. Lui stesso in gioventù sognava di diventarne uno. Ha frequentato personalmente, apprendendo da loro, molti poeti delle generazioni successive a quella di Pound, che a loro volta o avevano conosciuto Pound o ne erano stati enormemente influenzati e lo stimavano come un grande innovatore. Poeti come Robert Duncan, Charles Olson, Robert Creeley e tanti altri.
Le influenze di Pound su Brakhage non sono state solo filosofiche, ad esempio riguardo al significato dell’arte e alla funzione specifica dell’opera, ma anche operative. Pratiche. È stato notato come le prime innovazioni introdotte da Brakhage, a partire dalla fine degli anni ‘50, un acceleramento vertiginoso del ritmo di montaggio e la conseguente frammentazione del materiale visivo, possono trovare un parallelo nella adozione del verso libero del giovane Pound. Un verso frammentato e paratattico composto “a orecchio”, che è stato reso famoso dalla Terra Desolata, scritta dall’amico T.S. Eliot ma pesantemente redatta da Pound. Per Brakhage questo tipo di verso era la normalità, ed era quindi normale cercarne un corrispettivo visivo nel creare il film-poem.
Riguardo alla musica e alla musicalità, Pound aveva fatto propria la massima di Walter Pater secondo cui «Tutta l’arte costantemente aspira alla condizione della musica». E lo strumento comune è quello del ritmo. Per Pound tutti i dispositivi tecnici delle varie arti sono alla fine riconducibili al ritmo. Per questo egli credeva in un “ritmo assoluto”, idea derivante dalla certezza che a certi ritmi corrispondono certe emozioni (e che la dimensione divina non sia altro che uno stato mentale, quindi un’emozione, specifico ed eterno). In accordo con le sue idee sulla funzione spirituale dell’arte (idea ereditata sia dai poeti sopra menzionati che da Brakhage) vi era dunque una aspirazione ad una musica universale, non limitata da uno specifico medium. Per raggiungere l’efficacia in questo non c’è regola ma solo intuizione e “orecchio”.
Brakhage eredita tutto questo con piccole aggiunte. Descriveva il suo cinema come visual music, musica visuale. Dato che la sua idea di ritmo ha un’origine somatica, la sua idea di musica è un equivalente della mente in movimento, attivata dagli impulsi elettrici del sistema nervoso. Il ritmo elettrico del nostro sistema nervoso costituirebbe «la personale canzone fisiologica» di ognuno di noi. Quello che cercava di trasmettere nel film era la sua personale musica fisiologica, sperando che si sarebbe poi messa in relazione con la fisiologia dello spettatore.
Per Brakhage il film è letteralmente “luce ritmata”. L’associazione di suono e luce era per lui naturale non solo perché entrambi si manifestano sotto forma di onde modulate, ma specialmente perché questo era un punto quasi scontato all’interno della tradizione in cui si era posto. E in particolare per Pound e Duncan. L’opera d’arte deve quindi avere un effetto immediato, somatico, sul lettore/ascoltatore/osservatore, un effetto che non è raggiungibile con il significato delle parole o di ciò che è rappresentato. Si dovrebbe aprire una parentesi sulla loro idea dell’arte come strumento fondamentale di un processo spirituale. Qui basta dire che il ritmo diventa una specie di comunicazione universale, intraducibile razionalmente, per raggiungere un certo stato spirituale, rivelare l’ineffabile. Pound ad esempio insisteva sugli effetti fisiologici e di conseguenza spirituali che un’opera d’arte deve avere, mentre Duncan diceva che la costruzione verbale di certe poesie è più potente dell’oppio o di droghe psichedeliche. Entrambi questi punti si ritrovano nel cinema di Brakhage.

Scrive fumetti e scrive di fumetti, poi scrive anche canzoni e le canta, insieme a quelle degli altri che gli piacciono. Il suo sito è www.francescopelosi.it.



