A marzo, di colpo, è esploso il lockdown. Un po’ come l’Inquisizione Spagnola, nessuno se l’aspettava. Una sparizione collettiva che ci toccava fare perché la natura e i virus sono più forti di noi. Una condizione irreale, sospesa in un non-tempo, in cui la città si è svuotata per mesi, le case custodivano persone in preda ai sentimenti più diversi e confusi e le saracinesche erano abbassate e i portoni degli uffici erano chiusi e una primavera così non la vedevamo da anni. Io ho tenuto un diario. Le persone tranquille davano fuori di matto, mentre io e gli altri matti di mia conoscenza, ci rilassavamo. Non eravamo più quelli chiusi in casa mentre fuori scorreva una vita piena e operosa: eravamo quelli che in anni di disagio avevano costruito strategie per convivere con la solitudine, sopportarla e farsi proteggere dalla sua presenza di gommapiuma color nebbia.
Ogni uscita, nell’irreale solitudine di questo quartiere che conosco da tanto tempo, era significativa.

La mia prima uscita, dopo molti giorni di solitudine in casa coi gatti, è stata per buttare la spazzatura. Guanti, capelli coperti, avevo dimenticato la mascherina e ho aspettato a rispettosa distanza che passassero le uniche altre due persone visibili. Tornavano da chissà dove, lavori fondamentali, lavori inutili ma sacri per il capitale, entrambe con la mascherina. Quando le ho viste scomparire dietro l’angolo, ho attraversato la mia via per la prima volta. E ho scoperto cosa vuol dire eliminare le automobili da una città.
C’è una doppia linea di pruni lungo la mia strada che, dopo la prima apparizione di margherite e occhi-della-madonna, esplode in nuvole di petali rosa. È il mio calendario della primavera. Due righe rosa, piumose, delicate, di un colore fresco e pungente come il loro odore. L’esplosione fiorita è avvenuta pochi giorni dopo l’inizio del primo lockdown.
E mentre mi allontanavo di venti metri dal mio cancello, bum, mi sono accorta che erano lì, petali rosa, diafani, profumati come mai prima, nell’aria pulita, un velo colore dell’alba mi tremava nel cervello, profumo amarino e delicato, prezioso nella sua brevità, stordente nella sua potenza in questa città spopolata. Ho respirato e respirato. Ho sentito qualcosa che non so descrivere.
Ero il centro di tutto, ero niente. Camminavo attraverso questi veli di profumo, leggerissimo. Non c’era nessun altro in giro.
L’esperienza della città immobile somiglia a quella che provi quando cominci a meditare. Mancano le parole, ma colori e odori sono un linguaggio che riconosco e avrei voluto stendere questo lenzuolo di un freddo rosa quasi trasparente su tutta la città, fermare l’ansia per un secondo, dire respiriamo, anche con le mascherine, cazzo, riempiamoci di rosa, rosa, rosa, e profumo amarino e aria così stranamente pulita.
È il primo lockdown. Non sappiamo ancora che ce ne sarà almeno un secondo. Inaspettatamente: dormo, dormo tantissimo. Dormo felice sapendo che la sveglia non suonerà, perché il lavoro a distanza mi consente di organizzare la giornata lavorativa come preferisco, e mi sento uno schiavo liberato. Dormo profondamente, dopo mesi di insonnia. E sono incredula, perché il risveglio, da quando andavo alle elementari, è il momento più difficile della giornata. Invece, ora, non vedo l’ora di svegliarmi.
Certo essere soli a volte è rischioso. Smettere di mangiare, per esempio, perché nessuno mangia intorno a te e a te non viene in mente. Oppure cadere e farsi male, situazione a me ben nota perché sono la professionista degli incidenti domestici. Bambini e bambine hanno cominciato a esporre arcobaleni ai balconi e alle finestre: «Andrà Tutto Bene», scrivono, e io non lo so, cosa vuol dire «Bene». Tutto come prima? Stronzi come prima, ansiosi, egoisti, miopi, sfiniti come prima? Ho deciso di dare il mio contributo. Ho usato una camicia da notte rosa strappata e i pennarelli. Avrei voluto scrivere «Spero Che Tutto Sarà Diverso» ma stavo lavorando per i bambini della mia via, perché dev’essere pauroso essere piccoli e trovarsi di colpo coi genitori terrorizzati. Mentre appendevo il mio striscione di fortuna uno dei miei gatti è saltato oltre la finestra, sul terrazzino a cui a me è interdetto l’accesso dal design ignobile della finestra. Presa dal panico ho richiuso l’anta per evitare che il gatto volasse di sotto, l’anta ha colpito il manico di una chitarra acustica che non so perché stava sulla libreria, la chitarra è caduta, io ho urlato NO e mi sono lanciata. L’ho mancata, ma ho colpito con varie parti del corpo – non contemporaneamente, devo essere rotolata, o rimbalzata – un tavolino ikea di vetro e acciaio, che non si è rotto ma con la punta acuminatissima dei sui angoli mi ha sfregiato un braccio, una coscia, la schiena, una tibia. Quando mi sono trovata sul pavimento, sanguinante, scavalcata dal gatto atterrito, con l’Ibanez tutta scheggiata, non avevo ancora finito di gridare la O di Noooo! Se qualcuno avesse sollevato il tavolino ikea per colpirmi più volte, da differenti angolazioni, magari gridando «Che cazzo appendi un arcobaleno di notte!?», avrebbe senso. Ma avevo fatto tutto da sola. Mi succede spesso.
Sono rimasta sdraiata sul pavimento a guardare i lividi che diventavano blu e neri sotto i graffi rossi e rosa, rosa come la mia bandiera con l’arcobaleno. Ero stranamente serena. La situazione è così strana: ospedali, ambulanze, cure in generale sembrano circoscritte al coronavirus. Io, che sono la regina degli incidenti domestici, potrei anche preoccuparmi un po’ di più. E invece niente, ho pensato «È andata così».
La mattina dopo sono scesa a guardare il mio arcobaleno. Era tutto storto e sbavato. Aveva piovuto.
Andrà tutto bene? Ma va. Andrà strano, andrà nuovo, pensavo. Avrò paura, probabilmente.
E intanto era assurdo: molti miei amici, persone brillanti, piene di vita, mi chiamavano per parlarmi di rabbia, angoscia, senso di prigionia, e confesso che a volte i loro discorsi, alle mie orecchie, non avevano molto senso. «La paura mi fa schifo», mi ha detto una di loro. È una frase a cui ripenso ancora, perché la paura serve, è il panico che fa casino. Leggevo post su Facebook di persone che andavano a correre di nascosto nei parcheggi sotterranei deserti, leggevo affermazioni su come chi accettata il lockdown non sarebbe stato facilmente riammesso nella cerchia di quelli che lo sfidavano. Percepivo un panico diffuso e mi accorgevo che io, a sentirmi tagliata fuori da tutto per periodi anche lunghi, sono abituata. Sentivo i miei amici del gruppo della trasmissione sulla salute mentale, erano tutti stranamente rilassati. Ne parlavamo. Scoprivamo sentimenti comuni. La sospensione del tempo ci confortava, perché condivisa da tutti, volenti o nolenti. Non eravamo solo noi, fermi, mentre tutto scorre vorticosamente tagliandoci fuori. Il silenzio della città ci piaceva. Chiuderci in casa, insomma, ci piaceva. E mentre i nostri amici sbroccavano, noi ci adattavamo. Ho chiesto al mio psichiatra se avesse notato anche lui che le persone con problemi di fragilità mentale stavano attraversando il lockdown meglio degli altri. «Eh», mi ha detto, «Ho anch’io questa sensazione».
E mi ha confortato, come se mi fossi allenata per anni.
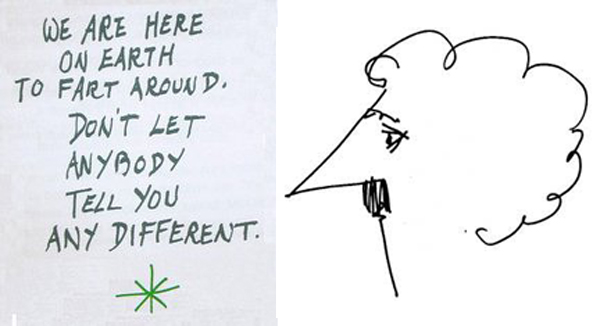
Non è che non mi accorgessi della tragicità della situazione. Per settimane l’unico suono che sentivo era quello delle sirene delle ambulanze. Non è una vacanza, mi dicevo, è vero che se cammini per le strade deserte per andare in farmacia è tutto un esplodere di alberi coperti di foglie, fiori, merli che ti si posano accanto perché sono nati in una stagione irripetibile in cui gli essere umani non sono in giro. Mia sorella mentre andava a lavorare in farmacia, la mattina presto, mi chiamava e mi raccontava. Ho capito veramente il dramma quando le terapie intensive si sono saturate, la Sanità lombarda, il famoso gioiello, ha mostrato tutta la sua fragilità, gli schemi contorti di cessione a un privato inadeguato per poter risparmiare sui posti letto, sul personale. Il mondo è pieno di fiori ma le persone non le ammazza solo il coronavirus, se ti rompi una gamba, se devi fare la chemio, se ti viene un infarto sono guai. E tra i morti comincio a contare gente che in qualche modo conosco, il padre di un amico, la madre di un altro.
Un incubo, ma reale. Eppure io, e con me moltissimi amici con diagnosi assortite di disagio mentale, mi sono adeguata quasi senza accorgermi all’isolamento forzato: non era la prima volta che mi chiudevo in casa e vivevo secondo una giornata di 27 ore, facendo le cose come vengono, scrivere, dormire, guardare serie tv, ascoltare musica, dormire, soprattutto dormire. E stavo bene. Mi vergogno a dirlo, ma io stavo bene: uscire dalla prigione degli orari stabiliti da altri, degli impegni che intreccio fitti fitti per non rischiare di scivolare tra le maglie e cadere nel vuoto del mondo, mi ha fatto stare bene.
Stare qui, sospesa. Preoccuparmi per cose reali. Il mio personale bestiario fantastico di disperazione e orrore taceva, sopraffatto dalla realtà. La gente muore, i racconti raccapriccianti si intrecciano, «Abbiamo dovuto tenere due bare nei garage», mi ha scritto un’amica. La notte, nel silenzio irreale che avvolge la città in quarantena, ascoltavo la sirena delle ambulanze che correvano nelle strade deserte verso l’ospedale civile, a un chilometro scarso da casa mia. Il suono della sirena arrivava da lontanissimo, da nord, da ovest, e a volte aspettavo dei minuti prima che diventasse fortissimo e poi, doppler, si allontanasse. Mi domandavo chi stesse trasportando quell’ambulanza: ce la farà o no? Non potevo fare niente. Accarezzare un gatto, se stava dormendo vicino a me. Accendere la luce e leggere. Controllare le chat. Chiudere gli occhi.
Le chat sono diventate importanti. Quel Pling che odiavo si è trasformato in una versione virtuale di una serata insieme. Parliamo di stupidaggini, ma anche della morte della mamma di Giorgio, delle nostre paure. Ridiamo molto. Giorgio ci ha raccontato della cerimonia funebre, tenutasi su WhatsApp: «Era strano. È stata velocissima, tre minuti, con l’addetto delle pompe funebri che al telefono mi chiedeva “Vede la bara?” e io “Ma veramente… vedo la sua faccia”. Poi per fortuna ha girato il telefono…».
Durante quella strana primavera mi è mancato abbracciare i miei amici, toccarli, prendere le loro mani, accarezzarli. Sono molto affettuosa, fisicamente, e per fortuna abito con tre gatti, altrimenti uscirei di testa, ma lo stesso
io
chiusa in casa
stavo bene.
Nell’ansia collettiva sto meglio di altri, perché sono ansiosa ma almeno il pericolo è reale, non sono danze macabre sul pavimento del mio cervello. Il mondo di colpo è in sintonia coi miei incubi di solitudine e pericolo, e io sono stranamente tranquilla.
Alla mia amica Ale facevano venire i nervi tutti i flash mob di applausi, canzoni, tarantelle, io penso che abbiamo paura, e vogliamo vederci, contarci, restare insieme, in qualche modo, e ognuno reagisce come può. Il mio amico Giorgio dopo il funerale di sua madre mi ha detto: «Non mi sono mai sentito solo». E mi ha riempito il cuore di una cosa che non so come si chiami, credo che sia la sensazione che provi quando hai paura e vedi una lucina.
Nel mio quartiere ai flash mob non partecipa mai nessuno, per quanto ne so potrebbero essere tutti morti, più probabilmente sono dietro i vetri, che si sentono ridicoli o insofferenti. Mia sorella mia ha detto: «È la paura arrabbiata che trattiene il respiro.»
Invece la mia amica Roby mi ha scritto: «Non ho più l’insonnia. / È bellissimo non avere più paura di andare a dormire. / Non prendo più pasticche.»
Le anime sono paradossali.
Vive in un condominio affollato e rumoroso. Le sue coinquiline e i suoi coinquilini hanno fatto di tutto nella vita: bibliotecarie, animatrici culturali, speaker alla radio, cantanti, mogli, mariti, amanti, complici… Ora ascolta tutte e tutti e sembra abbia visto, letto e goduto di ogni cosa. Me lei sa che quell’obiettivo non è stato ancora raggiunto e che si trova alla deriva in un punto indeterminato del processo.




2 risposte su “Tutti dentro, tutti fuori”