Parlare di cancel culture da donna bianca che non si identifica in un genere diverso da quello che presenta a livello biologico rappresenta una specie di suicidio social. Ma lo farò lo stesso.
In realtà, vorrei precisare, in un certo senso non sono sempre stata “bianca”. Per qualche anno ho vissuto in una città universitaria dell’entroterra americano, e, negli Stati Uniti, gli italiani non sono precisamente bianchi – o meglio, lo sono diventati piuttosto di recente. Nonostante il mio caso di immigrazione non sia neanche vagamente paragonabile alle circostanze che hanno portato la maggior parte degli italiani, nel corso degli ultimi due secoli, a emigrare negli Stati Uniti, per un americano “medio” – sempre che l’americano medio sia qualcosa di effettivamente esistente – avere a che fare con un italiano significa, anche di questi tempi, misurarsi con uno stereotipo.
Il campus in cui vivevo e lavoravo è una delle principali università pubbliche degli Stati Uniti e gode di ottima fama liberal e di apertura internazionale – ci vengono davvero a studiare da tutto il mondo – perciò non mi sono mai sentita neanche vagamente discriminata per la mia provenienza o la mia “olive skin”, secondo una fin troppo gentile definizione di un’amica del Midwest (ero arrivata là d’estate, in inverno tendo piuttosto alla “ghost skin”). Posso citare solo alcuni casi, in cinque anni vissuti colà, in cui mi sono sentita calare addosso uno stereotipo, e tutte le volte che è successo si trattava per lo più di idealizzazioni dell’Italia e di ciò che là veniva percepito come cultura italiana. Espressioni che mi hanno effettivamente lasciata con un vago senso di non appartenenza, insomma, di diversità, o di dissonanza rispetto all’ambiente dominante. Non che me ne crucci: anzi, da sempre, la molteplicità e il mescolarsi di più culture costituiscono il terreno più fertile dal punto di vista creativo e intellettuale.
Per fare qualche esempio pratico, ricordo il conoscente di una coinquilina che voleva assaggiare a tutti i costi le volgari zucchine lesse con l’olio che avevo cucinato per me in cinque minuti, riemergendo da una sessione di studio. Ancora mi domando cosa possa avere generato una tale profusione di elogi – in altre parole, suddette zucchine non erano particolarmente buone, ma erano cucinate da un’italiana quindi, nella mente di un americano di provincia che aveva a che fare con il suo primo italiano, per forza dovevano essere una Delikatesse. O di una volta in cui, in un pub, io e un altro italiano siamo stati fermati da uno sconosciuto esteta del look, che ci ha fatto i complimenti per il nostro aspetto, chiedendoci, estatico, «What are you, Jewish?» (intendendo che eravamo così distinti da sembrare ebrei). Oppure quando sono andata in un ufficio dell’università per ritirare un permesso per uscire dagli USA in occasione di un convegno che si teneva in Italia e una signora dell’amministrazione, molto simpatica, rendendomi il documento, mi ha chiesto dove fossi diretta. «Italy», le ho detto. «Ah, Italy! How fun!», ha risposto tutta emozionata. Eh già. Che divertimento, l’Italia. La signora deve avere semplicemente pensato che qualsiasi posto in Italia fosse chissà quale meraviglia e, di conseguenza, ha espresso l’entusiasmo che evocava in lei il solo vagheggiare. Oppure ha immaginato che, siccome andavo in Italia, dovesse necessariamente trattarsi di una gita di piacere, visto che l’Italia là è prevalentemente vista come una specie di parco giochi d’arte – e, francamente, questo stereotipo ci conviene. Mi è capitato anche di avere a che fare con benemerite teste di cazzo che diffondevano tra i miei studenti le più assurde stronzate sull’Italia, ma lì non c’entra essere o meno italiano: lì è una questione di stupidità e, peraltro, una delle persone in questione ha (evidentemente molto tormentate) origini italiane.
Tutto questo per dire: anche se positivi, gli stereotipi basati sulla provenienza possono essere irritanti. Figuriamoci, quindi, quelli negativi. Figuriamoci, a maggior ragione, quanto possano esserlo quelli basati sulla razza o sul genere di appartenenza.
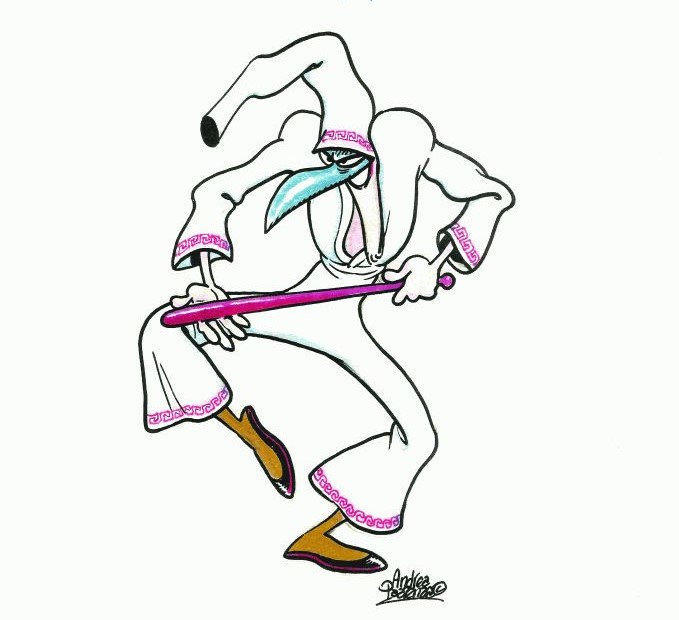
Quel pochissimo che ho visto dell’America è servito a farmi entrare in testa qualche minima tessera di buon comportamento secondo il canone americano: ho notato che, al di sotto di un certo livello di consapevolezza, ovvero in una condizione di ingenuità che può essere dettata effettivamente da una scarsa preparazione culturale, molti hanno un enorme problema con la rappresentazione. Per esempio, una volta mi è stato caldamente sconsigliato di evitare di proiettare a beneficio degli studenti (di ciò che per noi corrisponde al corso di laurea triennale), Lo chiamavano Jeeg Robot, in ragione del fatto che una sequenza del film corrisponde a una scena di stupro. Ovviamente, la stragrande maggioranza del cinema mainstream che mostra una scena di questo tipo non lo fa al fine di promuovere atti di violenza, tuttalpiù l’esatto opposto: nello specifico, si trattava di contribuire alla qualificazione del protagonista come disturbato esponente marginale di una società che non sa prendersi adeguata cura dei suoi anelli deboli, di chi è affetto da gravi patologie comportamentali, da chi proviene da situazioni di disagio. Sarebbe come prendersela con il Joker di Todd Phillips perché ammazza sua mamma!

Vaglielo a spiegare. Da qualche parte, nella testa di certa gente, qualcosa cortocircuita e, automaticamente, rappresentazione equals promozione – quanto, ovviamente, di più sbagliato. Non biasimo chi mi aveva dato quel consiglio: anzi, ha fatto bene, perché un insegnante di mia conoscenza, in un altro campus, una volta venne duramente richiamato dal magnifico rettore per aver mostrato Salò. Non che in Italia stiamo messi meglio. Un episodio di qualche anno fa: un attore di Gomorra era stato bombardato da minacce e improperi sui social semplicemente perché il suo personaggio aveva ucciso quello di una bambina. Anche tra gli spettatori italiani, quindi, di confusione tra realtà e immaginazione ce n’è davvero parecchia.
Diciamo che però il facile ragionare per stereotipi e superfici, la difficoltà di destreggiarsi tra realtà e rappresentazione, e, soprattutto, l’enorme instabilità sociale per il fatto che, negli Stati Uniti, si possono liberamente comprare e usare armi, e che la sanità e l’istruzione pubblica non sono garantite, restando appannaggio di pochi… insomma tutti questi fattori contribuiscono a creare un certo clima: in altre parole, miriadi di persone vivono veramente di merda, e non hanno – né vogliono (o sanno di volere) – gli strumenti per comprendere appieno il contesto culturale da cui si emanano film, libri, serie TV, fumetti, cartoni animati e altra sorta di narrazioni, o non sono in grado di distinguere il valore di un’opera dalla personalità del suo autore, o prescindere dalla persona dell’attore per valutare la validità della performance. Un clima in cui la via della discussione, del dibattito e del ragionamento non è molto praticabile e in cui, sempre in relazione a tutto questo, stare al mondo è difficile ancora di più per le vittime di stereotipi discriminatori di razza e genere. La damnatio memoriae risponde quindi a una sete di giustizia per troppo tempo soffocata. Anche se revisionare la storia semplicemente in virtù del fatto che ti fa soffrire potrà forse momentaneamente placare le tue – sacrosante – ire, ma non ti aiuta nel processo di comprensione delle cose.
Inoltre, si può obiettare, la cancel culture proviene soprattutto dagli ambienti intellettuali – è dolorosamente vero e, se devo cercare le cause di questo, le faccio risalire al fatto che, anche per chi una preparazione dovrebbe averla, cancellare, purgare, censurare, sterilizzare è più facile che spiegare. Ci vuole più pazienza, più tempo, più capacità, e invece le folle di consumatori vanno sedate subito. Qualche tentativo, secondo me da non condannare, è stato fatto: per esempio, le stringhe di spiegazione che precedono Peter Pan e Gli Aristogatti su Disney+. Va bene, alla maggior parte dei bambini non frega niente e vorranno solo vedersi il cartone, per altro più fittizio di così l’immaginario di entrambi i film non potrebbe essere, quindi paragonarli alla realtà è semplicemente ridicolo. Ma, se non altro, i bambini più curiosi, o i più perplessi, potranno guardare il film con un ulteriore beneficio: una nota sul perché i nativi americani sono ritratti in quel modo, o sul motivo per cui il gatto con gli occhi a mandorla e l’accento cinese suona il piano con le bacchette – tra l’altro la scena in sé denota piuttosto un atteggiamento di inclusività, dato che ritrae un momento di connubio artistico che celebra la diversità come momento dionisiaco di sperimentazione musicale – il protagonista è uno stereotipo di irlandese, poi c’è il jazzista di colore, l’italiano, il russo, il beatnik fattone, la wasp principesca dalla pelle nivea, tutti quanti a fare jazz.
In altre parole, è chiaro che lo sforzo di immedesimazione che sottostà a qualsiasi tipo di narrazione va preservato, perché l’arte, la letteratura, il cinema, il fumetto, i cartoni animati, le serie tv, questo ci esercitano a fare – oggi per esempio ho dovuto spiegare ai miei studenti Tanto gentile di Dante e lì, come vuoi fare?, lo devi precisare che bisogna mettersi nei panni di un uomo medievale, e che nel Medioevo vedere in giro delle donne belle (perché ricche e quindi nobili), giacché ce n’erano pochissime, era veramente come assistere all’apparizione di una fata o di un essere ultraterreno, nella coscienza di un borghese, seppure dell’alta società, come il giovane Dante. Ma, forse, questo sforzo di immedesimazione, cioè di temporanea perdita della propria identità per fondersi con la prospettiva che presenta un’opera, ancora non lo possiamo chiedere a quelle identità che, per troppo tempo, sono state oggetto di narrazioni penalizzanti della propria etnia e cultura. Laddove possiamo, però, abbiamo il dovere di continuare a tendere all’educazione alla lettura e alla visione.




