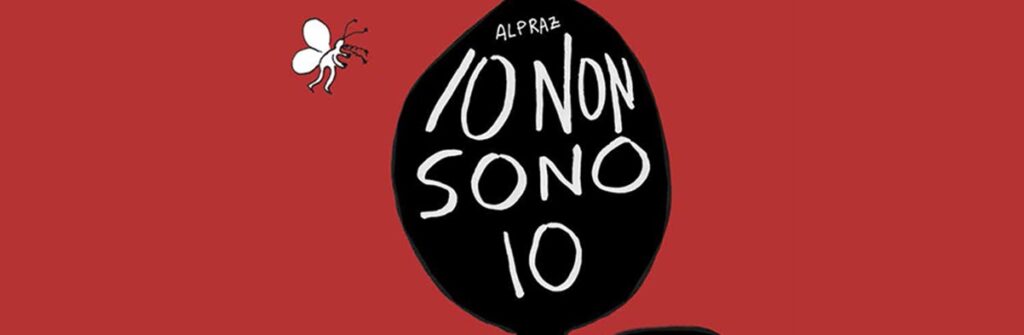Diciamocelo chiaramente. La famigerata DAD – Didattica A Distanza – non sarebbe così male se tutti avessero l’attrezzatura adeguata. Certo, i PC, i tablet, le aule virtuali e tutta la chincaglieria digitale, ma anche – e soprattutto – le stanze di casa insonorizzate. La cosa peggiore della DAD è l’obbligo dei conviventi di assistere, attraverso pareti sottili, a un’approssimazione di quello che succede in un’aula scolastica. I professori, di ogni ordine e grado, sono individui come tutti gli altri, né migliori né peggiori. La distribuzione normale delle loro competenze e della loro capacità di interagire con i discenti è rappresentabile con una curva a campana: quasi sempre media, in pochi casi eccellente e in altrettanti pessima. Benché ci piaccia immaginare docenti capaci di raccontare il mondo e la vita e di essere maestri, sentiamo spesso individui normalissimi che fanno discorsi banali in aula.
Compito di filosofia: «Stai con Hobbes o con Rousseau? L’uomo, allo stato di natura, è buono o cattivo?»
Ti viene la tentazione di entrare in quella stanza, spingere via l’adolescente, accendere il microfono e iniziare a sbraitare. Ma come buono o cattivo? Ma miseria porca! Allo stato di natura, prima di ogni costrutto sociale, la bontà e la cattiveria mica esistono. Quando diceva «Homo homini lupus», Hobbes mica stava dicendoci che il lupo è cattivo. Quello era Perrault! Non facciamo confusione. Il lupo è il lupo!
L’allineamento morale è un ruolo sociale determinato dalle regole del gioco. Quando inizi una partita a D&D – Dungeons & Dragons – devi decidere che personaggio vuoi interpretare, scegliendoti un nome, una specie (e le sue caratteristiche culturali) e un impianto etico. Un tempo dovevi dichiarare se eri “legale” (cioè rispettoso delle regole e delle leggi), “neutrale” (indifferente) o “caotico” (un fuorilegge per scelta). Dopo aver specificato come ti collocavi rispetto alle istituzioni e al potere, dovevi scrivere sulla tua scheda se eri “buono”, “neutrale” o “malvagio”. Quell’incrocio poteva fare di te un cavaliere senza macchia e senza paura (un “legale” “buono”), un soldato spietato (un “legale” “cattivo”), un ladro gentiluomo (un “caotico” buono”) e così via.
«Appropriazione!» Quante volte abbiamo sentito gridare questa accusa? L’appropriazione culturale è l’adozione di uno o più elementi provenienti da una cultura da parte di membri di un’altra cultura. Il guaio è quando una cultura dominante o maggioritaria va a fare la spesa nell’immaginario di una minoranza. Ricadono progressivamente in quel novero cose diversissime, dalla blackface ai dreadlock, all’arte che usa forme provenienti da culture minoritarie, all’interpretazione di ruoli incongrui da parte di attori che non fanno parte della minoranza rappresentata.
Per parlare di appropriazione bisogna riconoscere un passato (e forse anche un presente) di discriminazione, umiliazione, sopraffazione, sottomissione, colonialismo, … Tutte cose che ci riportano alla mente Tacito:
«Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico è ricco, arroganti se povero, gente che né l’oriente né l’occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero; infine, dove fanno il deserto, dicono che è la pace.»
(traduzione di Mario Stefanoni)
Tutti gli articoli di QUASI di giugno sono dedicati al tema “Ogni ruolo è un gioco”. Abbiamo alcuni dubbi e, siccome ci chiediamo continuamente se non siano dettati dal nostro invecchiare un giorno dopo l’altro, ci facciamo guidare da qualcuno cui il millennial Tacito avrebbe potuto dire «Ok, boomer!»: Orazio.
«La Grecia conquistata conquistò il suo fiero vincitore introducendo le arti nel Lazio contadino: così si estinse il selvaggio ritmo saturnio e l’eleganza bandì la sua fastidiosa rozzezza.»
Nei nostri momenti di ottimismo, ci piace pensare che la cultura degli sconfitti, dei sottomessi, dei colonizzati bruci sotto la cenere e, lentamente, modifichi l’idea dominante. E alla fine tutto è di tutti e la grettezza non può avere la meglio.
Certo, le logiche del commercio appiattiscono tutto e amalgamano la diversità fino a renderla cremosa e indistinguibile dal resto. Sorseggi il tuo milkshake e godi di quell’impercettibile retrogusto speziato che ti fa sentire come se fossi dalla parte delle minoranze. Però, se non indossi i panni degli altri, se non ti appropri del loro apparire, del loro sentire, se non fai un esperimento mentale, insomma… come pensi di capire caratteristiche così tanto distanti da quello che senti, da quello che sei, da esserti aliene? Crediamo che l’appropriazione sia, necessariamente, non solo la chiave per scostare il velo di Maya, ma uno strumento potentissimo, forse il più potente che abbiamo, per sviluppare empatia. Dobbiamo appropriarci di caratteristiche culturali e ideali altrui, filtrandole attraverso la nostra individualità cresciuta e pasciuta dove la maggioranza sta, per immaginare cosa sentono le minoranze alle quali non apparteniamo: è un dovere morale.
Qualche giorno fa il nostro Francesco Pelosi, durante un incontro sulla critica del fumetto in cui era chiaramente fuori luogo e fuori tempo, ha detto che per lui «la critica è un’opera a sé». Ci sembra che questa cosa racconti molto bene il senso di QUASI, che nasce proprio per accumulare narrazioni che parlano dell’immaginario. Per raccontare le nostre storie, per costruire la nostra critica che – lo sai – ha forme assai diverse, tutti noi che facciamo questa rivista che non legge nessuno dobbiamo, continuamente, raccontarci, fingere, speculare, entrare in sintonia con altri, giocare ruoli che non ci appartengono…
Per tutto il mese di giugno QUASI si muove attorno a questa idea, scivolosa e rischiosissima. Faremo del nostro meglio, ma come diceva Valentina Lotti, la scimmia blu, anche lei un po’ fuori luogo nello stesso incontro cui partecipava Francesco: «La critica non serve mica a fare amicizia».