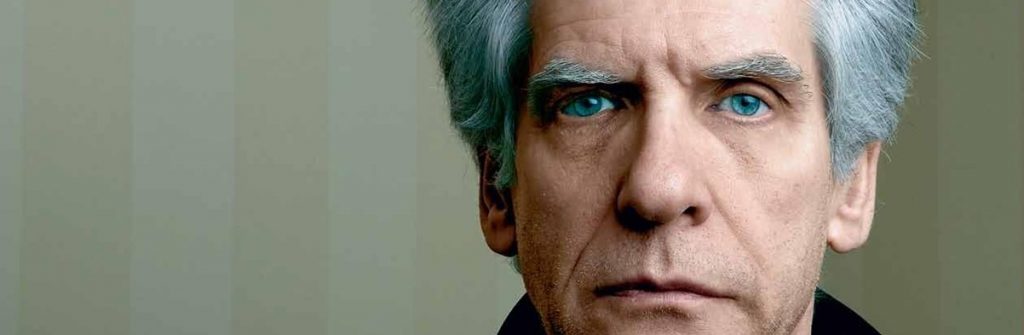Prima della pausa estiva di QUASI voglio dare ascolto alla tentazione che mi spinge a toccare temi abbastanza essenziali e notoriamente irrisolti e irrisolvibili, a meno che non siate scrittori torinesi con annessa scuola di scrittura e arti performative. Tanto, non per farvi un torto, non mi legge nessuno.
E quindi, per la rubrica che potevamo chiamare anche Il Ripostiglio del Bassista o Thoughts of a dry brain in a dry season, vado a recuperarvi, rigorosamente sul filo della memoria, un menu degustazione con abbinamenti proposti dalla cucina.
[Mi stavo accingendo a scrivere quando, in un refolo di ozio affaticato (quella condizione in cui stai sabotando il tuo stesso riposo evitando di rilassarti in ragione dello scrolling continuo su un social network qualsiasi), mi sono imbattuto in uno di quegli assemblati di fai da te digitale che mettono insieme un aforisma e la foto di quello che si presume l’abbia pronunciato. Di solito non li leggo nemmeno, ma stavolta qualcosa ha attirato la mia attenzione in modo piuttosto deciso. Si faceva il nome di Tom Waits. E allora sono andato a vedere un po’ meglio, intanto cercando di capire se il detto riportato fosse effettivamente attribuibile a Waits e di individuare la fonte. Chissà perché ma sembra che a tutti piaccia un mondo fare un sito qualcosa-quote.com ma quasi mai ci si prende la briga di citare la fonte. Comunque, cerca di qui, filtra di là, arrivo a un’intervista particolarmente golosa come setup, pubblicata su Vanity Fair del luglio 2001 – venti anni giusti giusti, con protagonisti Tom Waits (appunto, e veridicità della citazione confermata!) e J.T. Leroy. La storia del personaggio J.T. Leroy ha un profilo di interesse particolare: ai tempi di quell’intervista, la persona che hanno fatto incontrare a Waits tutto era fuorché l’autrice (Laura Albert) dei libri usciti a nome di J.T. Leroy. Insomma, hanno preso per il culo Tom, insieme a tutto il pubblico, e la persona con la parrucca e gli occhiali da sole (una certa Savannah Knoop, che in effetti era la cognata della Albert) che gli hanno fatto incontrare non era il/la fine autore/autrice a cui Waits rivolgeva il lapidario tributo di ammirazione cristallinamente contenuto nel suo esordio di intervista:
The world is a hellish place, and bad writing is destroying the quality of our suffering. It cheapens and degrades the human experience, when it should inspire and elevate. You are an exception.
Il tributo non andava diretto alla persona presente – non so perché la Albert abbia fatto quel che ha fatto. Stage fright, bisogno di attenzione e di affetto, guerrilla marketing, non saprei dire. Di certo quando ti nascondi dal pubblico ti nascondi e basta, non mandi un tuo surrogato in giro a fare il fenomeno e amicizia con le star – ma comunque sia quello che Waits ha detto resta bello pesante. C’è una qualità nel soffrire che può venire degradata, trivializzata e distrutta dalla cattiva scrittura. Me lo sono segnato…]
Wow. Credo di aver fatto la digressione tra parentesi quadre più lunga di tutta la mia breve carriera di contributore di QUASI. Comunque, oggi volevo parlarvi della mia storia con La Via dello Zen di Alan Watts e della musica che mi ci viene da associarvi. Quindi: che rumore fa un prezioso aforisma tributato a un’impostora? (tranquilli, si può fare, anche se ero dubbioso anche io e ho controllato con la Crusca, dice che è meglio se finisce in –tora e non in -trice)
Il libro l’aveva comprato mia sorella, anche se non so poi più bene se nel contesto di qualche corso universitario o meno. Passarono anni prima che ci mettessi le grinfie sopra ma quando avvenne fu un passaggio abbastanza sensazionale. Non ho mai letto le opere di D.T. Suzuki, uno dei grandi traghettatori culturali verso l’Occidente di pensiero e filosofia giapponesi e orientale, mi sono fermato a questo inglese trapiantato negli Stati Uniti dal 1938 che ha rimesso insieme questo excursus coltissimo ma estremamente leggibile e piacevole. Come sempre, vale la regola della cialtronaggine del bassista da salotto – l’opera di Watts è degli anni ’50, potrebbe anche essere superata in vari modi, non saprei dire, nondimeno ha svolto sicuramente un ruolo di ponte, di stele di Rosetta, verso un mondo di esperienza culturale e filosofica millenaria con cui noi occidentali si aveva poca familiarità. Chissà, magari nelle epoche andate, asceti da una parte, esploratori dall’altra, si sono trovati, hanno provato a scambiarsi qualcosa e certi semi hanno viaggiato lungo le vie dei carovanieri. Non so. Più che la comunanza oggi può, secondo me, una salutare estraneità aiutare a svellere le nostre teste dalla matrice di simulacri folli in cui si trovano intrappolate. Speranze di successo, sia chiaro, quasi nulle. Il satori non è niente di speciale ma non per questo arriva facile, tutt’altro.
Perché facciamo quello che facciamo? Cosa vogliamo ottenere? Come si raggiunge una pace interiore, una felicità, addirittura? E ancora, che è pure peggio, cosa è giusto? cosa è sbagliato?
Se nelle logiche occidentali la coerenza, almeno una coerenza di facciata, è considerata un valore assoluto, nei percorsi orientali (anche se non esattamente quelli mainstream) la contraddizione e il paradosso irrisolvibile sono ingredienti assai comuni. La genealogia del discorso zen è strettamente legata ai suoi ascendenti taoisti da un lato e induisti dall’altro, passando, ovviamente, per la linea evolutiva del buddhismo che si espande verso il Tibet e verso la Cina. Quando da westerners leggiamo di questi argomenti una prima sensazione è quella di stare venendo presi in giro – ma non siamo solo noi. Difatti quando l’imperatore Wu di Liang, monarca vissuto a cavallo tra il V e il VI secolo, protettore delle arti, promotore del confucianesimo e del buddismo, chiese a Bodhidharma quali meriti si fosse guadagnato con tutta una serie di azioni in favore del buddismo e della sua pratica, quello rispose:
Assolutamente nessun merito!
A quel punto Wu volle vederci un po’ più chiaro, era comprensibilmente confuso, e chiese
«Ma allora, qual è il primo principio della sacra dottrina?»
Bodhidharma rispose: «È semplicemente il vuoto: niente di sacro.»
«Chi sei dunque tu», disse l’imperatore, «che mi stai dinanzi?»
«Non lo so.»

Ce l’hanno un po’ tutti nel mondo, immagino, questa mania dell’identità, però noi occidentali ci nuotiamo dentro come pesci rossi autoimprigionatisi nella boccia. Tanto che poi facciamo un casino della madonna quando dobbiamo discutere di come si normino le devianze anche solo onomastiche o estetiche dalle determinanti di quella supposta identità. Bodhidharma, la cui unica testimonianza storica che lo riguardi lo identifica come un «persiano dagli occhi blu» in visita a un monastero cinese, non sapeva. Da noi abbiamo avuto Socrate ma sarà che quando la roba ti arriva, alle medie, al liceo, veicolata dal libro di testo, ti scivola addosso tranquillamente. Anche lui sapeva di non sapere. Ma riconducevamo quel sapere a un ambito che surrettiziamente immaginavamo scientifico o, almeno, logico.
Da quella conversazione non proprio felice con l’imperatore prende il via il percorso di instaurazione di una sorta di patriarcato del buddhismo (in trasferta in Cina, per ora, più tardi – qualche secolo dopo – arriverà anche, multivariato, in Giappone) con una linea di successori di Bodhidharma, regolarmente installata a colpi di illuminazioni subitanee innescate dalle domande giuste fatte dal patriarca precedente. Come agiografia la trovo più simpatica e stimolante di una fatta di santi scotennati, decapitati, graticolati o comunque malamente trucidati. Questione di gusti, ma fate un po’ voi.
Tra gli aneddoti di subitanea illuminazione più belli c’è quello di Tao-hsin, più o meno leggendario quarto patriarca, nel momento del suo approccio a quello che sarebbe stato il suo predecessore, Seng-ts’an:
«Qual è il metodo di liberazione?»
«Chi ti tiene prigioniero?» replicò Seng-ts’an.
«Nessuno mi tiene prigioniero.»
«Perché allora», domandò Seng-ts’an, «dovresti cercare liberazione?»
Il libro ci conduce poi, procedendo anche cronologicamente, verso figure e storie meno avvolte nel leggendario, seguendo il percorso che porta, infine, alla linea giapponese del buddismo zen, una linea comunque piuttosto articolata, alimentata già da orientamenti diversi nati già nel corso del VII e VIII secolo. Una delle opere più citate diviene quindi lo Zenrin-kushū, una antologia di precetti, oltre cinquemila, utilizzata in particolare dalla scuola Rinzai. Il paradosso è ormai affinato, lucidato e tagliente come una lama di Masamune:
Non puoi ottenerlo pensandoci;
Non puoi ottenerlo non pensandoci.
Non è da oggi, o da ieri, nella società industriale e post-industriale che il desiderio e la logica dello sforzo per ottenere i suoi oggetti sono le forze motrici più insistenti e imperiose per l’agire e il pensare degli umani. Accadeva anche allora, a molti secoli e molte civilizzazioni di distanza. Quella interpretazione basata sul merito, sulla disciplina come valore assoluto, su una rettitudine fatta di abnegazione prima che di altro. Tutto questo è già accaduto e continua ad accadere, anche dentro la nostra testaccia (nella mia almeno) quando andiamo in cerca di categorie come il giusto e il buono. L’esperienza del denudamento della vita non la vuole fare nessuno, forse non sappiamo neppure come si fa, e poi abbiamo così tanti argomenti sovrastrutturali per spendere vite intere a parlare delle apparentemente infinite guarnizioni sovraimposte a quella nudità senza appello. Spetta a Ikkyu, uno veramente poco ortodosso, incline al bere, osteggiatore del celibato in quanto estimatore dell’eros, notevole piantagrane e attaccabrighe, aver fissato bene il concetto in una poesia:
Noi mangiamo, espelliamo, dormiamo, e ci leviamo;
Questo è il nostro mondo.
Tutto quel che dopo ci resta da fare –
È di morire.

Noi moderni, a inquinare il tutto, ci abbiamo messo il lavoro come scopo dell’esistenza, rendendoci ulteriormente miserabili e allontanandoci ancora di più da una dimensione naturale dell’esistere. La contemplazione della natura non può prescindere dalla nudità esposta dai versi di Ikkyu – senza di essa anche il lirismo che crediamo di ricavare dalla lettura della dimensione naturalistica degli haiku, sarebbe mera affettazione. Però, sai com’è, a nessuno piace ricordare che non siamo così diversi da organismi filtratori attaccati a uno scoglio, tubi digerenti motivati dalla digestione. Pare brutto. La «natura umana» deve avere la sua dignità – sarà in nome di questa dignità che siamo divenuti, oltre che tubi digerenti, tubi desideranti. Un’antica poesia cinese, ricordata da Watts, racconta una dinamica che ho incontrato decine, se non centinaia di volte, nella mia esistenza:
Il Monte Lu in fitta pioggia; il Fiume Che in alta marea.
Prima di andarci, l’acuto desiderio non mi faceva dormire!
Io andai e tornai… Non era nulla di speciale:
Il Monte Lu in fitta pioggia; il Fiume Che in alta marea.
Troppe volte ci sono stati troppi Monti Lu e Fiumi Che. Alla fine non erano niente di speciale, ma non era neppure colpa loro. D’altro canto non è che facendone a meno si sarebbe fatta un’esperienza più piena e autentica. In qualche modo ci si deve passare.
È qui che si innesta il complemento musicale che ho in mente per l’opera di Watts, anzi, per gli argomenti di quell’opera. Ma più della musica in sé vale il suo autore. Leonard Cohen, il quale, a detta di amici un po’ più stagionati di me (che già sono un po’ stagionato io), era ottimo per svuotare le piste delle sale da ballo degli anni Settanta: un certo senso di sfiga e depressione, unito alle luci brute di fine serata, svolgeva alla perfezione il suo ruolo di disgorgante di avventori e avventrici. Non che non fosse un artista vero, no, però non era ancora diventato – né forse sapeva che lo sarebbe diventato, né forse lo desiderava (appunto), almeno non quanto essere un grande scrittore – il vecchio saggio venuto dal monastero Zen a riprendere la strada della tournée mondiale quasi permanente, fino alla fine della sua vita. L’evento opportuno fu che la manager, mentre lui era via al monastero di Mt. Baldy, in California, gli aveva sifonato via tutti i risparmi.
C’è un’intervista, fatta a Cohen dalla giornalista svedese Stina Lundberg Dabrowski, non quella del 2001 a Parigi ma quella del 1997 a Mt. Baldy, quella che non si trova più su nessuna piattaforma di streaming. Per qualche ragione, utente bannato, un bot a caccia di violazioni di copyright, un ripensamento, quell’intervista non si trova più. Però mi sono preso qualche appunto finché ho potuto.

Ricordo un Cohen rilassato, con degli occhiali fumé e una mezza bicchierata di whisky, ma anche vestito da monaco, a fare da cicerone negli spazi del monastero, la cucina, la mensa, la sala di meditazione, gli esterni. Se ne stava lassù dal ’94, e ci sarebbe rimasto per altri due anni. Non so come la vedesse lui, però guardando alla cronologia della sua biografia, quel periodo appare come uno spartiacque importante, non tanto in termini di discontinuità, quando di approfondimento di certi percorsi. In particolare, la conclusione è la più notevole: anni di tour globale e tre album, uno ogni due anni, tra il 2012 e il 2016, prima della morte, a cui si deve aggiungere anche una pubblicazione postuma, curata, per non dire assemblata, dal figlio Adam.
A ogni modo, la giornalista svedese, a un certo punto, gli chiede del suo stile di vita e di cosa animasse la sua esistenza, cosa le desse forma e sostanza:
LC: «[…] wine, women, songs, money, career, drugs, art, every kind of extravagance, every kind of restraint.»
SLD: «And what helped?»
LC: «Everything helped in its way in the sense that it said: “this doesn’t work”. I think that the greatest help you can get from anything is to find out that it doesn’t work.
Because nothing works.
Nothing in this human realm is meant to work.
So, once you can deeply appreciate that, for one thing, the mind of compassion grows, and you understand what everybody’s up against [se ricordo bene…].
I remember reading some works of Simone Weil […] and she said there’s only one question worth asking anybody and that question is: “what are you going through?”»
Niente funziona. E forse la cosa migliore è veramente arrivare ad apprezzare la cosa. Certo, forse la si apprezza meglio, una tale inanità, dopo averci fatto il bagno dentro, ripetutamente, affogandoci quasi. Sicuramente meglio che stando in un 9-to-5 di manica larga, senza molto da dire, senza spunti particolari, prendendo in prestito obiettivi da un canovaccio che non si sa più neppure chi l’abbia definito.
Però è quello che tocca a tutti, e ognuno si porta dietro un guscio con dentro tanti pezzi e storie nei quali non importa più neppure credere o riconoscervisi. In un modo quieto e tutto sommato conciliante fanno parte dell’identità, anche quando non c’entrano moltissimo agli occhi dell’osservatore da una certa distanza. Per questo trovo che You Want It Darker del 2016 sia il lavoro in cui una comprensione di marca zen, che probabilmente non è riuscita a essere una illuminazione piena, si esprime in modo più compiuto – pure se all’interno di una poetica di sapore prettamente religioso, di religiosità ebraica, ma non solo, di militanza, di una fede, un po’ corrosa ma ancora desiderosa di parlare, nell’amore. È anche la condizione di malattia (il cancro stava via via riscuotendo un pedaggio sempre più alto) a creare una situazione di limitazione e costrizione che la voce dell’autore è però ben addestrata ad affrontare. Quel che ne viene fuori è un congedo austero e partecipato allo stesso tempo, severo e caloroso, ieratico e dimesso, se possibile. C’è il divino, ma non cozza con tutto il resto, è uno di quegli elementi genuini, custoditi e mostrati senza clamore – e probabilmente è anche una necessità artistica, credo di avere sentito dire a Nick Cave che, anche se non ti piace, il «Dio» torna utile come soggetto fuori campo al quale rivolgerti. Il nulla, «assolutamente nulla», il vuoto dei precetti zen, delle poesie taoiste, è ben più difficile da affrontare.
Difatti, l’interlocuzione verso il dio è un fatto assolutamente personale nel pezzo che dà il titolo all’album. È nelle strofe che sono contenute le misure del vivere nel piano di esistenza degli umani e non viene lasciata molta speranza, il «tu» del titolo investe tutti, ma ritorna anche sul soggetto, a cogliere e ricordare lo straniamento essenziale che pervade chi sperimenta l’insensata violenza che pare governare le vicende delle società umane:
They’re lining up the prisoners
And the guards are taking aim
I struggled with some demons
They were middle class and tame
I didn’t know I had permission
To murder and to maim
You want it darker
E così, su un arco temporale di circa un ventennio, si è venuto a comporre questo abbinamento imprevisto, tra un saggio su cui non avrei immaginato che musica piazzare e un modo di fare e scrivere musica che sembra nascere dalle stesse fonti di quella sapienza così poco decifrabile.
Il libro di questo mese è La Via dello Zen, di Alan Watts, e l’edizione su cui avevo messo le mani era degli anni ’90, con questa copertina, più o meno 250 pagine, Feltrinelli
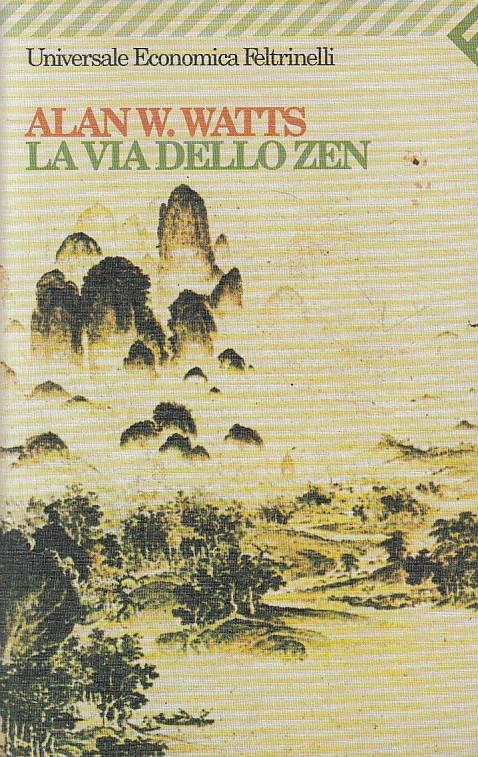
La musica, invece, è quella di You Want It Darker, Leonard Cohen, Columbia Records, 2016

[Una ulteriore nota paradossale e assai discorde la possiamo trovare anche nella storia del fondatore e abate di Mt. Baldy, il roshi Sasaki, venuto dal Giappone nel ’62 a portare lo zen Rinzai agli americani, morto a centosette anni, caduto in disgrazia per l’accumulo di un po’ troppe accuse di inappropriatezze e molestie sessuali, raggranellate nel corso della maggior parte della sua carriera, come una commissione indipendente buddista ha appurato nel 2013. Se non ricordo male, nell’intervista che cito, o forse in un’altra che ricordo malamente, Cohen già definisce Sasaki «a naughty boy», ma non so se fosse solo questione di Ballantine o la nozione di altro.]
È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.