Vagando per l’enciclopedia di Babele sparpagliata là fuori oltre il pertugio digitale del modem, di solito in cerca di ispirazioni, conferme, confutazioni e para-puntelli per gli argomenti che snocciolo qui su QUASI, mi è capitato di imbattermi in una classificazione delle teorie filosofiche sull’ontologia dello spazio e del tempo – un argomento con il quale mi era solo venuto fatto di scherzare in pensieri silenziosi, mai espressi fuori dalla capoccia. Ho fatto qualche timido accenno qui, in precedenza. A grandi linee ci sono tre macro-scenari: il presentismo, l’eternalismo, la growing block theory. Si gioca così: ci si chiede cosa è reale e quando lo è – facendolo si accarezza la freccia del tempo e si marcano idealmente gli spazi immensi del prima, del dopo e dell’adesso con il crisma della realtà. È reale tutto, tutto c’è anche se l’abbiamo sperimentato o ancora dobbiamo incontrarlo (per non parlare dell’adesso), oppure, no, è reale solo il momento presente, quello che quando tenti di fermarlo è già stato sostituito da una sua versione solitamente sconfortantemente simile, o, forse, c’è un blocco di realtà che si accumula via via che i presenti già spesi si impilano dietro a quello appena acceso, incessantemente.
Ora vado a stuzzicare un altro concetto, uno che qualcuno ha preso e lanciato oltre la dimensione planetaria, per fare l’ipotesi – non vi nascondo, inquietante – che l’evoluzione, almeno finché restiamo in parti dell’universo dove l’insieme di leggi naturali sono le stesse di quelle a cui sottostiamo qui, tenda a produrre pattern similari, potenzialmente anche in altri sistemi planetari, questa idea che trovo etichettata come convergent evolution, estendendolo fino a dove non si riesce ancora a vedere (ma sapere che riusciamo a rilevare esopianeti e a trarre inferenze su quanto sono grandi, densi, caldi o freddi, è abbastanza impressionante). Per dire che la natura potrebbe riproporre il formato umano in modo tendenzialmente sistematico, nello stesso modo in cui, per esempio, espone in momenti diversi della storia biologica il ricorso a forme di locomozione (chi vola, chi nuota, chi striscia) che usano morfologie comuni, in assenza della benché minima parentela.
C’è un prima, c’è forse anche un altrove. A volte non troppo più rarefatti della memoria di sé, almeno della mia.
Che la realtà di quel tempo sia ancora qui con noi o meno, Marguerite Yourcenar ha impiegato vari anni per ideare e scrivere Mémoires d’Hadrien: dal ’24 al ’29 per pensarci, dal ’34 al ’37 per stendere varie bozze, dal ’48 al ’51 per finirlo e pubblicarlo. Ora, Marguerite aveva una manciata di nomi e una altrettanto manciata di cognomi, era figlia di un borghesone francese e di una aristocratica belga (perita di setticemia dieci giorni dopo il parto della figlia) quindi, probabilmente, non aveva un problema di conti di economia domestica da far quadrare e cinque lustri per portare a conclusione un capolavoro ci stanno tutti, no? Non so se ho già usato questo aneddoto, per pigrizia e per trasparenza (80% della prima) non andrò a controllare, ma penso sempre a quell’incontro tra Leonard Cohen e Bob Dylan dove i due si raccontano come hanno lavorato sui rispettivi brani per cui si stanno facendo gli apprezzamenti del caso e viene fuori che Dylan per scrivere Like a Woman ci ha messo quindici minuti e Cohen, per Hallelujah, due anni (che poi erano sette – credo che ci sia una varietà caleidoscopica di versioni di questo incontro: cambia il brano di Dylan e gli anni che Cohen impiega a scrivere Hallelujah, ma il senso è sempre quello, minuti versus anni. Qui ho usato gli ingredienti contenuti nel racconto che ne fa Adam Cohen). Cohen, per me, è come Céline: creare è un processo doloroso, richiede un lavoro di lima e altri arnesi senza troppa anestesia – non riesco a comprendere la velocità, mi fa pensare alla sicumera di un buona la prima troppo baldanzoso. La capisco quando sei Dostoevskij e stai per perdere i diritti su tutte le tue opere e allora tiri fuori Il Giocatore in meno di un mese. In realtà hai lavorato a quell’opera anche da prima, quando non la stavi scrivendo…

Ma, come al solito, divago… Yourcenar, donna, emancipata, bisessuale, ci porta un uomo, Adriano, ricostruendolo come avviene per le rovine rimesse insieme nei parchi archeologici e nei musei, dove il più è materiale contemporaneo che tiene insieme, con criterio, sia detto, quelle quattro breccole sopravvissute a quasi due millenni di decadimento e spoliazione, utilizzando le magre fonti disponibili, la Historia Augusta, repertorio biografico che copre il periodo dal regno di Adriano fino a quasi la fine del III secolo, e l’opera di Cassio Dione, storico prolifico la cui opera ci è giunta abbastanza completa solo per il periodo dal 65 al 12 avanti Cristo. Il resto, breccole.
Il pensiero sulle teorie filosofiche del tempo era evidentemente ozioso ma non ho potuto fare a meno di immaginare le opzioni in competizione: a seconda di come starebbero le cose, esisterebbe solo l’Adriano della Yourcenar, catturato nei libri, quando li leggiamo, qui e ora, oppure l’Adriano uomo e quello personaggio, destinati però, ahimè, a non incontrarsi mai. Un po’ come noi e gli altri umani potenzialmente germogliati chissà dove in questa o nelle innumerevoli altre galassie di questo universo (attualmente si stima che ce ne siano da uno a qualche centinaio di miliardi).

I presupposti di un eccezionalismo sono evidenti nella scelta di utilizzare come protagonista uno che è così primus tra tutti da non avere più ormai pares da tanto tempo – la retorica della propaganda augustea è ormai svanita, evaporata, il principato è l’Impero, punto. Il fatto che l’uomo abbia un potere illimitato e le possibilità materiali di dar seguito a qualunque suo arbitrio non fa che rendere la riflessione esistenziale che dà sostanza a tutto nell’opera ancora più verticale e insuperabile: neppure all’uomo più potente del mondo è garantito alcunché in termini di felicità o anche solo di conseguimento di uno stato di saggezza e rettitudine. Il percorso verso il potere è segnato dalla violenza, fisica e politica, dalla manovra e dall’eliminazione degli avversari. La strada dell’amore è pavimentata col brecciolino della perdita che si infila dappertutto nei calzari. L’amore per le arti salva solo in parte perché è alimentato dalla vanità e dalla brama di avere. L’ingiustizia si annida in tutti i nostri atti, l’aspirazione per la pace incontra sempre almeno una incomprensione o una indisponibilità.
Sono stato a Villa Adriana a Tivoli – per capire meglio l’impressione che sto cercando di trasmettervi è opportuno guardare ai tunnel sotto la struttura, quelli dove si muoveva il personale di servizio, perlopiù composto da schiavi, per muovere gli approvvigionamenti, i materiali, per curare la manutenzione di tutto l’armamentario idraulico e termale. Sopra, strutture idilliache, o solenni, o tutt’e due, per il sollazzo del princeps o per la magnificenza dell’impero, o tutt’e due. Sotto, le torme di servitori si affannano avanti e indietro nei corridoi malamente illuminati dalla luce delle torce. È vero, un barlume di welfare li vede gratificati dell’uso di terme a loro dedicate – un elemento culturale che i secoli successivi non sarebbero riusciti a sostenere (le opere idrauliche, le soluzioni di scienza delle costruzioni, i fondi – tutto sarebbe regredito), nondimeno il mondo dei bisogni e dei sogni dell’uomo che abita sopra la superficie è mostruosamente dispari rispetto a quello degli altri.
Ecco, se c’è una trappola, in opere come i Mémoires, è quella dell’identificazione. Almeno quella in via esclusiva: noi lettori siamo Adriano solo nella misura in cui siamo umani – per il resto siamo gli altri, mi dispiace. Ci piace giocare a essere gli imperatori, ma come dice Don Bastiano, non siamo padroni di un cazzo. Il problema del controllo è il refrain costante che borbotta come un motore di vecchio frigorifero dietro alle domande essenziali sulla felicità, l’amore e compagnia bella. Puoi fare quello che vuoi ma Antinoo affoga nel Nilo, non c’è via d’uscita. Nel frattempo continuerai a commettere torti e ingiustizie per cui andrai impunito perché sei l’imperatore – avrai il lusso di osservare il tuo declino e di poterti permettere la riflessione con cui chiudi la narrazione, quell’entrare nella morte a occhi aperti. Dignificante, austero, quasi coraggioso. Uno si dimentica chi è e pensa che vorrebbe essere così. Yourcenar crea una voce magistrale, c’è poco da fare. Sono sicuro che riesce a piacere anche agli omofobi più viscerali, ed è tutto dire. Fa leva sulle nostre aspirazioni imperiali, sul nostro essere kings e queens of our castles. Ci dimentichiamo di quelli nei tunnel. Che poi siamo sempre noi, almeno per la maggior parte.

A proposito di tunnel, non fa male una visita anche ai sotterranei del Colosseo. Anche lì, il mondo di sopra e il mondo di sotto. In quest’ultimo, buio, torce, animali feroci e scenografie spinte nell’arena a forza di braccia che facevano muovere le decine di montacarichi sottostanti. Non riesco a immaginare il clamore e le puzze di un tale ambiente. Quello che mi viene in mente è che nei tunnel le condizioni sono migliorate, ma restiamo quelli nel tunnel, oltretutto, spesso, nel bel mezzo di interregni e vuoti di potere. Nel tunnel di oggi, quindi, frequentemente, il casino lo fanno i suoi abitatori per carenza di informazioni, di decisioni, di responsabilità. Questo spiega, con la solita cialtroneria di chi scrive qui, perché in superficie non ci siano più templi e costruzioni rivestiti di marmi scintillanti e pietre pregiate: sotto si sta un po’ meglio ma non si produce più in quel modo spietato che porta a riuscire a costruire regge sfavillanti che riescono a lasciar traccia di sé dopo due millenni. Non che questo sia un proposito degno, sia chiaro, voglio solo rimarcare la differenza con i nostri manufatti in cemento, destinati a sbriciolarsi dopo qualche decennio, almeno secondo quei documentari un po’ apocalittici che giocano a immaginare l’improvvisa scomparsa dell’uomo (a proposito, ne fanno ancora? Non ne vedo da un pezzo, ma gli è anche che mancano le occasioni).
Adriano viaggia in ogni dove nel suo impero, assapora il potere e le sue sfumature, per decenni, ma, in ultima analisi finisce per lamentare la perdita dell’amato e la caducità dell’esistere. Patientia diviene la parola d’ordine per un epilogo in cui riconoscersi, appunto, a occhi aperti. Ma tra lui e noi lettori c’è la differenza che c’è tra il marchese del Grillo e il gruppo di popolani che irride, anche se fino a un momento prima stava facendo bisboccia con loro. Per noi, sapere a cosa e perché applicare un concetto di patientia non è così semplice e, difatti, molte delle voci dei sopportanti nella mia esperienza evocano immagini spiccatamente anali (farsi il culo, farsi fare il culo, prenderla nel culo, un culo così, me lo hanno fatto così) per definire la natura del discorso negoziale, specie quello lavorativo, sottolineando il conseguimento di una certa desensibilizzazione, esorcizzando al contempo la nozione del piacere. Ma nessuno parla volentieri di pazienza, la nozione la si riserva più alla consanguineità, i problemi che danno i figli, quelli che danno i genitori.
La monumentalità del discorso dell’Adriano yourcenariano porta con sé un lavoro di pulizia assimilabile a quello di un bagno termale classico – scrostando certi ingredienti più triviali, come quelli che sostanziano l’esistenza di noialtri nel tunnel, aumenta un nitore che rende la messa a nudo, esistenziale e psicologica, sia più netta, stilisticamente e contenutisticamente, che più pietosa. Alla fine, è la storia di un grand’uomo, raccontata da lui stesso medesimo. Da questo punto di vista, probabilmente, siamo agli antipodi del K. del Prozess di Kafka, che non saprà mai di quali crimini è stato accusato e per i quali sconta una pena capitale eseguita oltretutto grottescamente, con sufficienza e sdegno, provando nel frattempo la certezza di una vergogna che gli sarebbe sopravvissuta. Può aprire gli occhi quanto vuole, continuerà a non capire, all’infinito.
È sicuramente passato molto tempo da quando ho letto le Memorie, la prima volta deve essere stato negli anni ’90, la seconda più o meno un decennio fa, ma oggi, portandomi a seguire l’uso invalso di questa rubrica, l’accostamento musicale che mi viene da fare emerge con un impulso molto spontaneo. Per me, la capacità di evocare un livello di introspezione in una cornice raffinata, classica ma anche sperimentale, appartiene senza dubbio ai dEUS. Riguardo alla band ci sono posizioni un po’ rigoriste che dicono che dopo l’album Ideal Crash lo spirito sperimentale dei primi lavori sarebbe stato abbandonato o sconfessato. Non so dirlo, né mi interessa particolarmente – in ogni caso, scelgo di segnalare una antologia, l’unica fin qui pubblicata, Selected Songs 1994-2014, per chi si trovasse nella condizione di iniziare a conoscerli.
Le cose più recenti ritengo che portino con sé un livello di maturità effettivo, tangibile. C’è un percorso di costruzione di un tono stilistico assolutamente distintivo di qualità dei suoni, degli arrangiamenti, delle armonie e delle singole parti, della carica esecutiva dal vivo (altissima), che continua nel tempo. Da Pocket Revolution (2005) a Following Sea (2012) c’è una seconda fase della storia del gruppo che continua a livelli alti, altissimi, ancorché diversi. Ci sono tanti brani da tenere presenti, da Bad Timing e Nothing Really Ends, passando per The Architect e Slow, fino a Quatre Mains e One Thing About Waves – uno spleen elegante pervade tutto senza mai essere moscio o melenso, c’è del vigore che si fa sentire, e non ci si annoia.
In questo improbabile sommelieraggio letterattura-musica mi sento di proporvi questo accostamento.
Per congedarmi, prima che torni l’aquila del Caucaso del lunedì, sceglierei Bad Timing, sette minuti e sette secondi, un formato decisamente poco radiofonico per quello che fu l’ultimo singolo estratto da Pocket Revolution. Chissà cosa facevano nei passaggi radiofonici, non è un pezzo che puoi sfumare ai soliti tre minuti e mezzo…
Oggi abbiamo scomodato:
- Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano, Einaudi 1992, 347 pp.
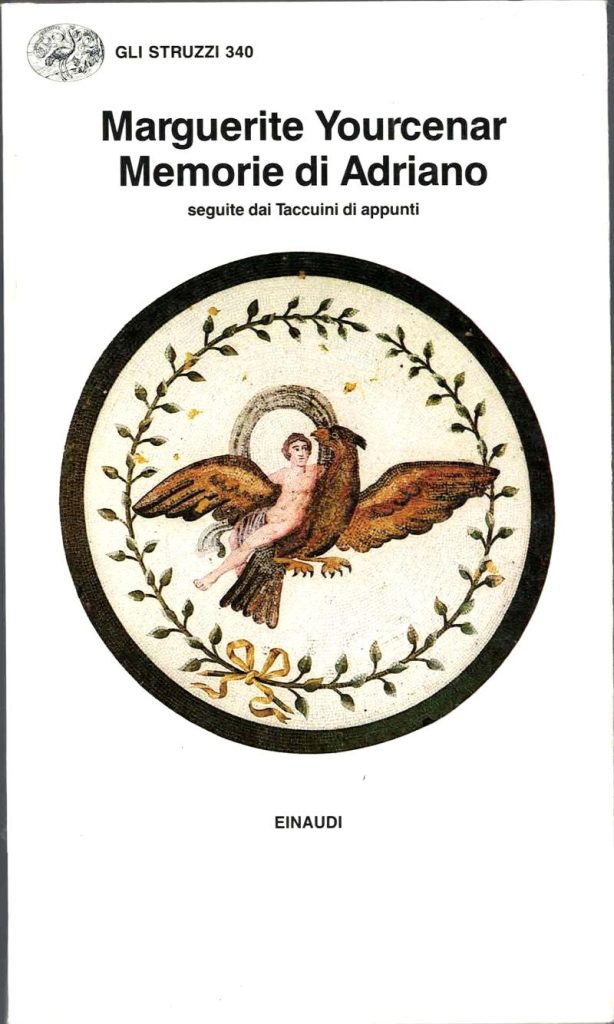
- dEUS, Selected Songs 1994-2014, 2 CD, Play It Again Sam, 2014

È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.



