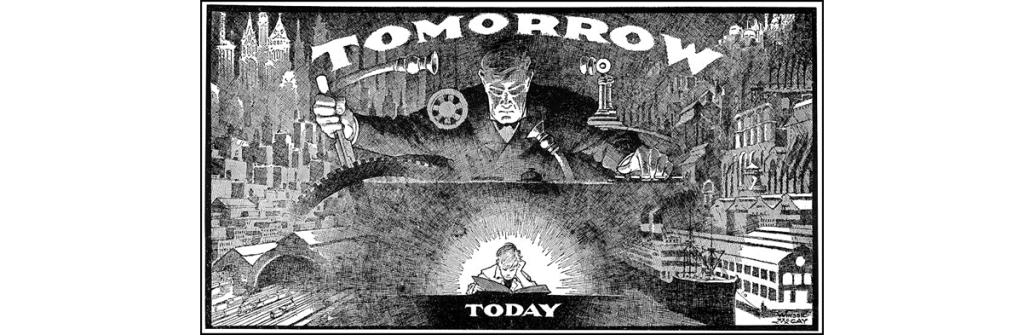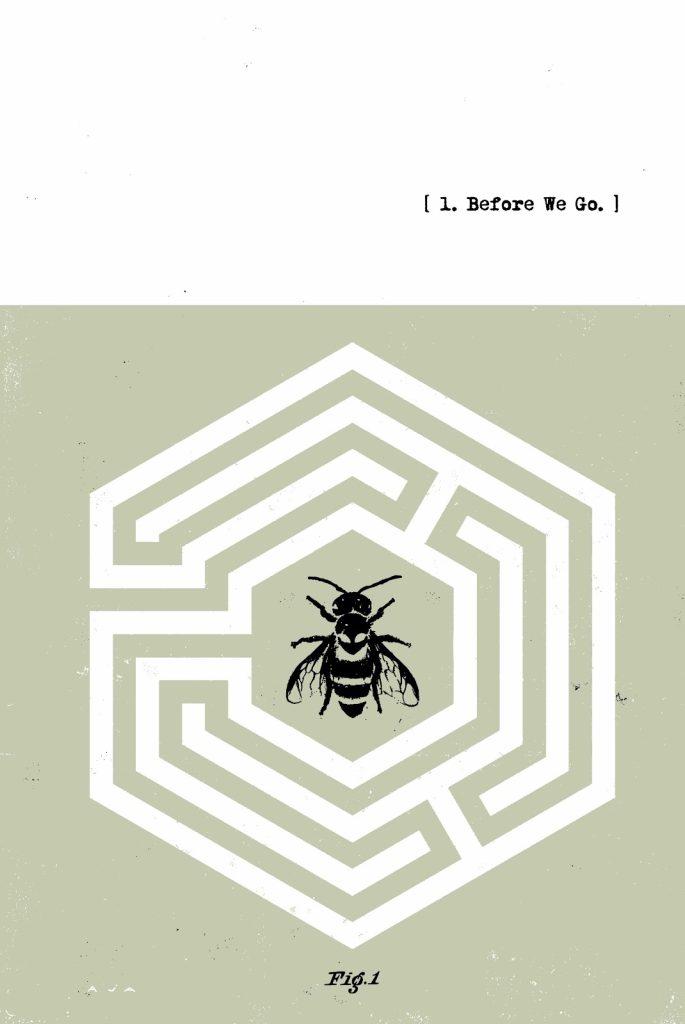
Cosa è una distopia l’abbiamo scoperto quando frequentavamo le medie. Tra il 1980 e il 1981, leggevamo con devozione i fascicoli della “Grande Enciclopedia della Fantascienza” che, a cadenza settimanale, ci introducevano ai nodi tematici della letteratura di genere. Ogni settimana una scheda con un’infilata di riassunti di romanzi, film, telefilm e fumetti, qualche articolo ben fatto, un sacco di immagini, e un racconto, spesso divertente. Muovendoci tra quelle pagine, con la precisione e la puntualità che si riesce ad avere solo a dodici anni, abbiamo maturato devozioni di cui ancora non ci siamo liberati e abbiamo scoperto sottogeneri, discipline, istanze e movimenti.
Viene ancora da lì la nostra idea di cosa siano l’heroic fantasy, la cibernetica, l’hard science fiction e i new mutants.
Viene sempre da lì il nostro amore per le distopie.
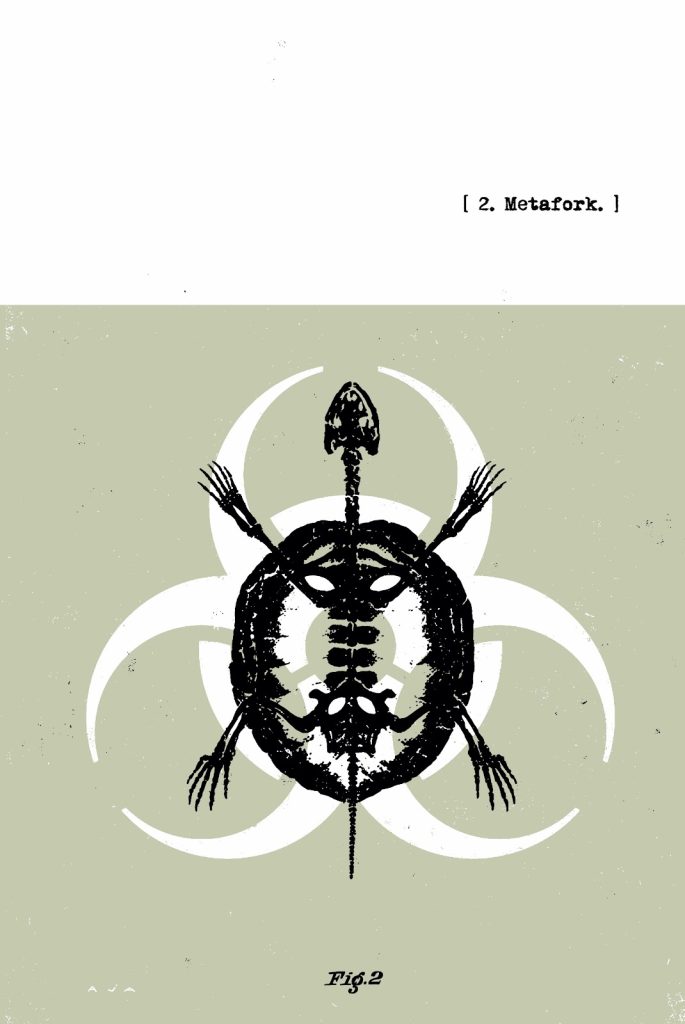
Un mondo molto simile al nostro nel quale qualcosa è andata peggio. Un sistema politico oppressivo, una catastrofe naturale, una tecnologia possibile sfuggita al controllo, l’esaurirsi delle risorse naturali, la desertificazione o la glaciazione, una pandemia… Poi, mentre ti godi la vicenda narrata, indignandoti per quello che accade, ti rendi conto che il mondo di cui stai leggendo assomiglia tantissimo al tuo e che, se non proprio tutto, qualcosa è andata storto davvero. Distopia è solo un altro nome del realismo.
Che bello quando la fantascienza ci mostrava un mondo disperato, criticando quello in cui vivevamo e offrendoci uno spiraglio di speranza nel quale, combattendo, avremmo potuto infilarci. Un ideale per il quale lottare, gridando slogan che avevamo imparato nei romanzi, nei film e nei fumetti.
Qualcosa è andato storto.

L’anno che si è appena concluso non è stato solo difficile. È stato come vivere in una distopia. Ma era tutto vero, sempre che “vero”, per noi lettori di fantascienza, significhi qualcosa. C’è tutto: la pandemia, il coprifuoco, la totalnotte, un manipolo di tecnici che prende il sopravvento sulla vita e la burocratizza, la paura degli altri, Loro, il sistema politico oppressivo nelle mani di una cricca di criminali, un popolo imbelle, incapace di ribellarsi.
Non ci stiamo ribellando.
Eppure gli slogan li conosciamo tutti… Li abbiamo imparati leggendo distopie.
Sul finire dello scorso anno, è uscito The Seeds, un fumetto distopico costruito molto bene dalle persone molto giuste.
Tre miti: Ann Nocenti alla sceneggiatura (proprio lei, quella che è riuscita nell’impresa impossibile di non farci rimpiangere Frank Miller sulle pagine di Daredevil), David Aja ai disegni (lo spagnolo che ha messo in pagina due cicli straordinari di Iron Fist e Hawkeye) e l’editor Karen Berger (si è inventata la linea Vertigo – Swamp Thing, Hellblazer, Sandman, Preacher… – e questo dovrebbe bastare).
Una confezione meravigliosa: carta ad alta grammatura, legatura solida per un brossurato con bandelle che esprime sontuosità, stampa ottima, bicromia virata al verde che ha il sapore di quando Drawn&Quarterly contendeva a Fantagraphics il titolo di miglior casa editrice del fumetto nordamericano.
Insomma una bomba.
E leggendolo ci siamo divertiti un sacco, dribblando tra le corpose dosi retorica e di impegno sociale distribuite in ogni pagina. Ogni scambio di battute, uno slogan. La nostra triste condizione contemporanea travestita da finzione distopica: proprio quello che cercavamo.

Il primo degli slogan sotto cui muovere la nostra ribellione è gridato nel titolo, The Seeds. Poi, l’epigrafe chiarisce:
«Hanno cercato di seppellirci. Non sapevano che noi eravamo semi.»
(proverbio messicano)
Wah! Che slogan potente! Un proverbio, poi. Saggezza popolare.
Lo cerchiamo in rete, per poterlo dire in spagnolo. Senti un po’ qui:
«Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas».
Sotterrati in casa da quasi due anni, vorremmo crescere, sbocciare, fiorire.
Purtroppo siamo solo degli illusi: la distopia non è realismo.
Accetteremo, domani, un sistema di regole più stringente di quello odierno.