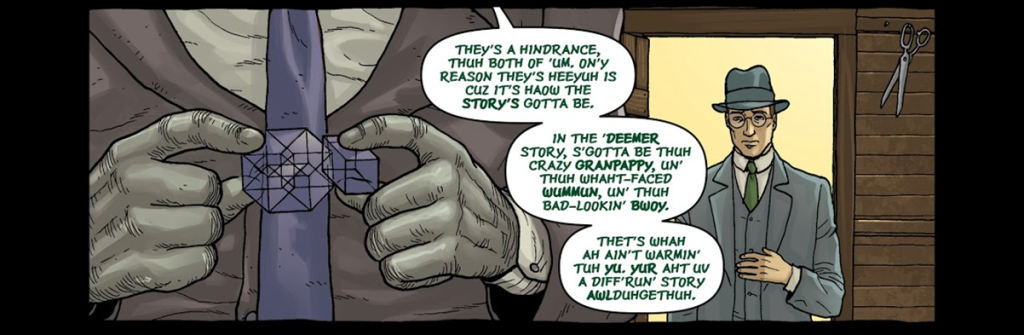di Giovanni Russo
Il presupposto è che ho fatto una cazzata. Ho commentato un post su Facebook sui Måneskin, cedendo alla tentazione del cazzeggio solo perché ne conoscevo l’autore (ciao Michele) e qualcosa, nell’articolo postato e nei commenti successivi, non mi quadrava. Il tema è la più classica delle polemiche social: ma i Måneskin sono rock o no?
Come è giusto, tutti dicono la loro. Le critiche dei puristi sono ingenerose e non tengono conto di un contesto di pop commerciale a confronto del quale i Måneskin sono grasso che cola; dall’altra parte, chi attacca gli hater in base alla motivazione che «è giusto che la musica dei giovani non piaccia agli adulti» incappa nello spettacolare controsenso di criticare chi, in base al suo stesso schema, fa solo quel che ci si aspetta che faccia.

A me incuriosivano soprattutto i sottintesi della domanda, che riassumerei nell’assunto per cui «il rock è una musica da giovani».
Empiricamente è vero: il rock è stato una componente fondamentale nell’ascesa dei “giovani” come gruppo sociale autonomo, con agenda e valori diversi da quelli degli adulti. Ancora oggi la musica popolare, di qualunque tipo, è in gran parte fruita dalle giovani generazioni. Ed è vero anche che funziona come un imprinting, vera fucina di boomer, se è corretto lo studio, nel quale sono incappato facendo qualche ricerca, in base al quale le persone preferiscono invariabilmente il genere musicale che era in voga quando avevano fra i ventitré e i venticinque anni.
Un sospetto maligno che viene – poiché, da ex-giovani, sappiamo bene che la “ribellione” rock era quanto meno ambigua – è che siamo oggi molto ben disposti a un distanziamento condiscendente, che rinsalda l’accostamento fra quella musica e un’inevitabile (e rimpianta) fase di “idealismo” giovanile.
Ma al di là dell’evidenza empirica e di facili illazioni, perché mai il rock dovrebbe essere intrinsecamente “per giovani”? Per la sua ritmica aggressiva? Perché i movimenti sfrenati del rock’n roll lo rendono un ballo dionisiaco che rimanda al sesso? Perché i testi sono spesso ingenui, quando non imbarazzanti?
Se volete ho un bel po’ di altre generalizzazioni del genere.
Il rock è per maschi e il pop per femmine.
Il jazz è per hipster con la pipa in radica.
Il country è per redneck e nazisti dell’Illinois.
La musica classica è per parrucconi di una ex élite finalmente decaduta.
È possibile che il discorso si riduca così spesso a capire “di” chi è, “per” chi è un prodotto culturale? Quante volte abbiamo sentito discorsi simili sui fumetti, e quante volte abbiamo alzato gli occhi al cielo?
La questione non riguarda nello specifico il rock: è di metodo e non è di merito. A sprezzo del ridicolo la affronto in questi termini, per come mi sembra.
Comincio da me. Ricordo com’è andata. Come per tutti quelli cresciuti in era pre-Internet, la conoscenza della musica è passata da pratiche condivise: i dischi, le TV musicali, un po’ di radio, le cassette scambiate fra amici. Se eri fra quelli per cui contava l’aspetto rituale (a me non interessava), c’erano i concerti. Per i più esigenti c’erano le riviste, ma io avevo interessi più pressanti e non sono mai arrivato a tanto. In ogni caso, la principale differenza rispetto a oggi era una scarsità di accesso alla musica così marcata che implicava, quasi inevitabilmente, l’addentrarsi nella materia il minimo indispensabile per sentirsi a posto coi propri gusti e non sfigurare nella cerchia dei pari.
Col tempo ho iniziato a trovare esperienze più gratificanti (anche musicali) altrove, e gradualmente, senza cesure nette, ho smesso di ascoltare musica rock. Sono tornato a interessarmene, al rock e a quel che nel frattempo era diventato, solo assai più tardi, essenzialmente per togliermi un dubbio di rilevanza che la frequentazione di altri ambiti di ultra-nicchia (tipo l’animazione d’autore) aveva reso sistematico. Quello che trovai mi stupì molto. Non solo l’accesso di colpo non era più un problema, non solo c’erano mappe molto più ampie ed evolute che mi fecero tornare la voglia di esplorare, ma trovai, nell’ecosistema rock, rappresentate in forma plastica delle stratificazioni che non ho ancora visto così chiaramente altrove (e decisamente non nel fumetto), che sono diventate la base per una specie di modello pseudo-teorico a cui faccio riferimento per descrivere alcune dinamiche nell’ambito della cultura di massa.
Il fenomeno di base è molto comune, con Internet che evidentemente è solo più efficace a evidenziare e sedimentare gli strati; ed è quello banale per cui, quando in un ambito le esperienze cominciano ad accumularsi e a entrare in stretta relazione fra loro, a quel punto nasce una “cultura”, specifica e autonoma. È stato così anche per il rock: oltre e sopra le nicchie identitarie, che si sono succedute e affiancate in una logica spesso competitiva (fra di loro, prima ancora che coi “matusa”), si è creato un pubblico di ascoltatori esperti, non certo di primo pelo e dotato di buona cultura musicale, che si è fatto cronista e interprete della nuova “cultura rock”. Non so quanto le riviste del passato ambissero a un tale sguardo unitario, ma il carattere collaborativo ed “unificante” di molte esperienze online va in quella direzione.

Il modello, dunque, è quello del panino. Nella fetta di sotto, ben spessa, succede quasi tutto: c’è la produzione e il consumo, ci sono i target e i bisogni, ci sono i fandom e le loro infinite pratiche di appropriazione. Nella fetta di sopra, molto sottile, c’è una cultura umanistica che studia linguaggi e processi da una posizione di presunta neutralità, facendosi scudo del canone, distillato nei secoli, dalle arti di più antica tradizione e ponendo così uno standard irraggiungibile per chiunque; in mezzo al panino, con percolazioni da sopra e da sotto, stanno esperti e cultori, gli unici che davvero si sporcano le mani provando a mappare influenze, ad argomentare rilevanze.
Da cosa si riconosce un autentico strato di mezzo rispetto ai normali “media di settore”, che di solito sguazzano felici e autoreferenziali nello strato di sotto? Un po’ di criteri: ampiezza di visione; approccio interpretativo al presente, unito all’ambizione di sistematizzazione storica del passato; superamento delle dinamiche identitarie; capacità di creare connessioni col resto della cultura. Non dico che tutti i progetti online sulla musica siano così; ma i migliori sì, in Italia come all’estero.
L’emergere, grazie a Internet, delle più diverse pratiche partecipative nell’ambito del fandom è fenomeno sotto gli occhi di tutti e già ampiamente studiato, ma l’aggregarsi di comunità di esperti è molto meno focalizzato, quasi che i due fenomeni siano la stessa cosa (e magari, agli occhi di un sociologo, lo sono). E no, Wikipedia non fa testo, visto che ha assunto la stessa avversione al giudizio della cultura accademica di cui mima l’approccio. Resta la curiosità di cosa potrebbe accadere con progetti online di lungo respiro, e mi spiacerà non essere in giro, fra un secolo o giù di lì, per vedere cosa sarà successo. Forse, passata la sbornia social, l’utopia del cyberspazio tornerà a proporre la suggestione di una grande unificazione della cultura, un po’ come la si attende in fisica, fatta di costruzioni capaci di reciproca interrelazione e basate su esperienze, giudizi e percorsi umani, non solo su informazioni fintamente “oggettive”.
Comunque. Le nostre chiacchiere sui Måneskin stanno tranquillamente nella fetta di sotto del panino. La valutazione sulla validità e rilevanza della loro proposta nell’ambito della cultura musicale avverrà nello strato di mezzo e in base a parametri essenzialmente musicali, indipendentemente dalla loro età, dalla loro attitude, dal loro look, dalla banalità o meno dei loro testi, dalla ricezione identitaria della loro musica nella comunità dei giovanissimi, dalle condizioni più o meno industriali, o più o meno “autentiche”, in cui essa è nata.
Il tema posto dallo strato di mezzo del panino è quello classico della ricontestualizzazione dell’arte.
Personalmente, credo nell’arte come forma di espressione di una verità umana. Credo, per questo, che sia essenzialmente traducibile. Anche solo con un’infarinatura di contesto, è possibile avviarsi in esplorazione e godere di esperienze fondamentali provenienti da forme espressive lontanissime nel tempo e nello spazio. Ogni opera d’arte capace di durata cambia statuto innumerevoli volte: il contesto originario si perde o è accessibile solo agli storici, mentre l’opera continua a vivere in nuovi ambiti, recepita, valorizzata e problematizzata in mille modi diversi, anche antitetici a quelli originali. A ben vedere ogni singola, personalissima esperienza di ricezione è una ricontestualizzazione autonoma e non discutibile.
Il cambiamento di orizzonte interpretativo dell’arte del passato è oggi un dato acquisito, per noi completamente trasparente. Non ce ne accorgiamo perché è già avvenuto, e non è toccata a noi la fatica del distacco. Oggi è scontato che si possa apprezzare l’architettura musulmana senza capire una sillaba della calligrafia araba di cui è ricoperta; che si apprezzi l’opera lirica come musica colta a dispetto delle sue origini popolari e del sentimentalismo di molti suoi testi; che si apprezzino le statue antiche come bianche astrazioni marmoree, pur sapendo che erano colorate e che forse, col gusto odierno, le riterremmo pacchiane; che si apprezzi laicamente la musica sacra, pur sapendo perché è stata composta; che si apprezzi la poesia giapponese, pur non essendo raffinati nobili di corte che poetavano alla luna.
Non vedo perché questo distacco debba valere solo retrospettivamente. Non vedo perché, nel confrontarsi con la cultura di oggi, si debba dare tutto questo peso a un contesto che già domani sarà superato. Con tutto il rispetto per i sociologi della cultura, credo che le condizioni di produzione e i bisogni a cui soddisfa un prodotto culturale, mediati da dinamiche di mercato (uh, che paura), non siano quasi mai l’aspetto più interessante. Molto più interessante è capire, azzardando e argomentando il giudizio, se in un certo ambito, per una serie di circostanze che sarà certamente meritorio studiare, accanto alla miriade di mistificazioni consolatorie che costituiscono il rumore di fondo dell’industria culturale, si cominci a dire qualcosa di vagamente rilevante.
In conclusione, se è lecito complimentarsi coi Måneskin per il successo del loro Teatro d’ira, è comprensibile che la comunità musicofila saluti con molto maggior entusiasmo il similmente titolato Ira, notevole ultimo album di Iosonouncane – tanto per restare in Italia – che pesca a piene mani dal rock come da mille altre cose (ascoltatelo, merita). Il tutto per arrivare all’unica conclusione che davvero mi interessa: c’è della musica fantastica in giro, lasciarla ai giovani sarebbe un peccato.