Amo crogiolarmi nelle banalità. Per esempio, qualche volta, mi piace ricordare che la parola “fumetto” si riferisce alla nuvoletta che contiene le parole.
Nei rari articoli sul fumetto che leggevo da bambino, cercando di capire perché quelle storie mi piacessero così tanto, accanto ai messaggi tranquillizzanti che dicevano che, in fondo, quella roba non poteva fare troppo male, veniva spiegato con pedanteria un tantino eccessiva che quella parola, “fumetto”, faceva riferimento alla piccola nuvola di fumo che esce dalla bocca dei personaggi ed entro la quale sono scritte le parole.
Il linguista Mario Alinei, in un libro che si è nascosto tra le mensole, spiegava con chiarezza come l’uomo abbia dato forma sonora al proprio respirare, costruendo le parole. Quel libro non lo trovo più: faceva finta di essere un dizionario, era bello e spiegava bene un sacco di cose. Se fossi in te, di uno così disordinato da perdere un libro che considera fondamentale, non mi fiderei: è chiaro che quel ricordo potrei anche essermelo inventato.
Mi limito a trovare commovente quella descrizione, infissa tra i miei ricordi, di corde vocali che vibrano grazie alla respirazione, che è l’essenza stessa del nostro essere vivi, e risuonano nella cassa armonica del nostro corpo, diventando parola, linguaggio, comunicazione. Il fumetto, inteso come nuvoletta, non riporta solo il discorso diretto dei personaggi: è l’espressione più forte del loro essere vivi quando si agitano sulla carta.

Potrei sbagliarmi, ma mi pare che in nessuna altra lingua quell’elemento, importantissimo e fondante, qualifichi, fin dal nome, questo modo del racconto. Nelle parole che ogni lingua usa per indicare il fumetto si trovano tracce della comicità, della vignetta, della striscia o della sequenza disegnata, del formato di pubblicazione, dell’immagine divertente, o, addirittura, di quella specifica testata che, per importanza e diffusione, ha polarizzato su di sé il senso stesso del fumetto.
A me la parola “fumetto” piace tantissimo e trovo insopportabile il farfugliare nobilitante che tende a riempirci la bocca di “letteratura disegnata” e “graphic novel”. Nonostante l’amore che muovo verso quel lemma (che si porta dietro effluvi di pastis e brodo di pesce), mi è chiaro quanto il suo attribuire centralità alle parole sia rischioso. Quell’oggetto evanescente, più leggero dell’aria, che galleggia sulla testa dei personaggi, dovrebbe farci capire che quelli sono vivi.
Camminiamo tra gli umani, li sentiamo parlare, vociare, schiamazzare, ma non ci balza mai in mente l’idea malsana di ascoltarli tutti. Siamo selettivi: non vogliamo impazzire.
Lo avevano capito bene José Muñoz e Carlos Sampayo che riempivano i loro bar di balloon incongrui e, proprio per questo, indispensabili a percepire «il rumore della realtà» che sempre si agita sullo sfondo.
Lo avevano capito bene i fondatori del “Corriere dei Piccoli” quando, all’inizio del secolo scorso, decisero di rimuovere i balloon per sostituirli con versetti in rima da mettere sotto il disegno, ché il sangue non si mescolasse.
Eppure ci sono persone che, addirittura, leggono le parole nei fumetti, tributando a esse una rilevanza anche maggiore di quella che attribuiscono a tutto ciò che viene rappresentato sulla pagina.
Quasi vent’anni fa, a Lucca, dopo aver chiacchierato di forme e formati del fumetto con Igort, Diana Schutz e Fausta Orecchio, mi sono fermato a parlare proprio con Fausta di un libro che mi pareva innestarsi bene nel progetto della sua casa editrice, Orecchio Acerbo. Le mostravo The Grasshopper And the Ant, un volume quadrotto, firmato da Harvey Kurtzman, pubblicato qualche tempo prima negli Stati Uniti. Denis Kitchen, l’editore, aveva preso un breve fumetto apparso nel maggio del 1960 sulla rivista “Esquire” e lo aveva scomposto in quadretti. In ogni pagina una singola vignetta, per raccontare la nota favole della cicala e della formica di Esopo. La cosa straordinaria era che, nonostante quell’arbitrio, il racconto messo in pagina da Kurtzman continuava a funzionare. Anzi, grazie a quella scomposizione, quel fumetto assumeva un inaspettato ritmo da picture book nel quale le variazioni cromatiche e stagionali scelte dall’autore scandivano perfettamente l’incedere dell’inverno assassino. Fausta aveva guardato il libro con interesse, mi aveva chiesto di tradurglielo dall’inglese e lo aveva trovato interessante. Aveva aggiunto: «Però ci vorrebbe un bel lettering tipografico, ché questa cosa, fatta a mano, non si può guardare».
Conosco la storia di Fausta. È l’unica persona che io abbia mai incontrato capace di riconoscere qualsiasi carattere tipografico abbia usato anche una volta sola, con un’occhiata, senza esitazione. Una sera, a cena, mi ha raccontato come si è affinato quello sguardo: una storia di formazione professionale che mi ha scatenato ammirazione. Capisco perfettamente perché avrebbe voluto un carattere riconoscibile, e so che avrebbe scelto con studiata precisione quello che meglio si sarebbe accostato a quei disegni. Eppure, in quel momento, la volontà di rimuovere le parole vergate a mano da Kurtzman, con un segno sghembo e inclinato in perfetta sintonia con i disegni, mi aveva scatenato un fremito di paura.

David Mazzucchelli è l’autore del più bel manuale di lettering che io abbia mai visto. Si chiama Asterios Polyp ed è un bel fumetto e anche un bel trattato teorico sulla forma del fumetto. Un libro curatissimo che riesce a darti piacere quando lo sollevi, ne soppesi la carta, valuti le qualità cartotecniche. Poi lo guardi, lo sfogli e scopri che non si fa neanche troppe menate: lo leggi, ti diverti, ti resta dentro. Ogni personaggio messo in pagina da Mazzucchelli ha la sua voce. Un carattere disegnato, dentro i balloon, appositamente per quel personaggio – anche quando deve apparire soltanto per pochi quadretti – che ne dice le qualità, la presenza e, appunto, il carattere.
Rendere riconoscibile un personaggio è un bel casino. Bisogna capire come si veste, come si muove, come tiene un calice di vino, come bacia e come apre una porta. Siccome i fumettisti devono anche vivere, di solito si fanno pochi problemi e il tipo che deve apparire in un’avventura diversa ogni mese lo si distingue dagli altri perché ha le orecchie rotonde, perché ha una grossa “S” sul petto o perché indossa sempre una camicia rossa con i polsini risvoltati sulle maniche della giacca nera.
I possessori delle voci di Asterios Polyp sono sempre riconoscibili. Anche quando cambiano abito, parlano fuori campo, vengono sintetizzati nei poligoni colorati che li compongono: hanno una voce; sono vivi.
Quella del lettering è una battaglia importante. I fumetti che amiamo di più mostrano un’assoluta sintonia tra le parole e le immagini. Le parole, sulla pagina del fumetto, sono disegni a loro volta. Sono segni così riconoscibili che, qualche volta, raccontano la voce del padrone.
Faccio un esempio semplice.
È appena uscito il quarantesimo “Dylan Dog Color Fest”. Si tratta del nuovo fascicolo di una collana trimestrale dedicata alle storie strane e colorate del personaggio inventato da Tiziano Sclavi. Su quelle pagine si alternano autori che, di solito, non si muovono in prossimità del personaggio. Negli albi di quella collana, abbiamo visto avvicendarsi Giorgio Cavazzano, Vanna Vinci, Aldo Di Gennaro, Enrique Breccia, Angel Lito Fernandez, Alfonso Font, Akab, Silvia Ziche e via così… Storie di Dylan Dog che trattano il personaggio con affetto e, pur giocando con i suoi cliché anche pesantemente (come accade nel fascicolo in cui si alternano Ausonia, Marco Galli e Akab), non si allontanano mai dal canone.
Il quarantesimo numero sembra un inspiegabile e improvviso colpo di testa dei curatori della collana. Vengono chiamati a confrontarsi con il personaggio Officina Infernale, Spugna e Jacopo Starace. I primi due soprattutto sembrano indifferenti alle regole con cui l’azienda protegge le proprie properties e, consapevoli di giocare con un frantume di immaginario condiviso da almeno quattro generazioni, decidono di metterne a nudo gli ingranaggi e farlo proprio.
Il loro Dylan Dog non è canonico. È un Dylan Dog personalissimo e disturbante. E proprio per questo divertentissimo.
Sergio Bonelli editore è un marchio solido e attentissimo alle tradizioni. Così tanto attento da sfiorare, in molte occasioni, un approccio talmente conservatore da sentire di reazione.
Nella sua storia ha tollerato innumerevoli atti di libertà improvvisa, dai “Protagonisti” a “Un uomo, un’avventura”, a “Zagor” e “Mister No”, a Bonelli-Dargaud e “Orient Express”, a “Bella e Bronco”, fino a “Ken Parker”, “Dylan Dog” e “Gea”.
Ma proteggere la tradizione significa anche proteggere i propri possedimenti.
La minaccia mossa verso Dylan Dog da parte di due autori che si prendono troppe libertà merita che la proprietà mostri la propria presenza. Con forza e irruenza.
Innanzi tutto, non è possibile che un messaggio così eversivo viaggi da solo. L’inventore e proprietario del personaggio fa sentire la sua voce nella colonna riservata all’editoriale. Ed è un evento straordinario.
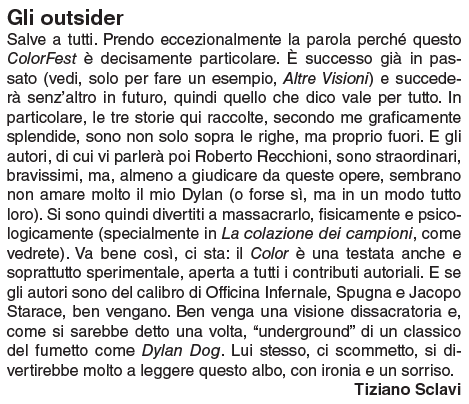
Questi fumetti «sono non solo sopra le righe, ma proprio fuori» e gli autori, a detta di Sclavi, non hanno rielaborato un mito «si sono divertiti a massacrarlo, fisicamente e psicologicamente». È, questa di Sclavi, una posizione estremamente rivendicativa: mostrando di tollerare «una versione dissacratoria», rimarca la proprietà di quello che definisce «il mio Dylan».
Lo preoccupa particolarmente La colazione dei campioni, il fumetto firmato da Officina Infernale. E proprio contro quello scatena il secondo, e più invasivo, meccanismo di controllo.

Officina Infernale è un autore estremamente prolifico che lavora, a colpi di cut-up e decontestualizzazione incongrua, sul nostro immaginario visivo. Trascorre gran parte del suo tempo alla ricerca di immagini – iconiche o disturbanti, riconoscibili o oscene – da rielaborare nelle sue costruzioni narrative. Su queste appoggia racconti, spesso in soggettiva, all’incrocio tra la rinascita dei supereroi degli anni Ottanta e il flusso di coscienza. Le parole, nei suoi fumetti, sono scritte con font che richiamano le macchine da scrivere, le titolatrici, le etichettatrici a rilievo…
Le poche parole che vediamo scritte da lui sulle pagine di “Dylan Dog Color Fest” omaggiano il lavoro di Jamie Reid quando inventava quella combinazione di lettere ritagliate dai giornali e gettate quasi a caso sulle copertine dei dischi e creava l’immagine più riconoscibile del punk inglese.
Quel lettering era inaccettabile. Dylan Dog, anche quando è scritto e disegnato da Officina Infernale, parla in balloon perfettamente ellittici con caratteri rotondi e gentili, molto leggibili.
Quasi a dire che le sue parole, il suo fiato e, di conseguenza, la sua vita appartengono a Tiziano Sclavi e, per qualche tempo ancora, a Sergio Bonelli Editore.

Scrive e parla, da almeno un quarto di secolo e quasi mai a sproposito, di fumetto e illustrazione . Ha imparato a districarsi nella vita, a colpi di karate, crescendo al Lazzaretto di Senago. Nonostante non viva più al Lazzaretto ha mantenuto il pessimo carattere e frequenta ancora gente poco raccomandabile, tipo Boris, con il quale, dopo una serata di quelle che non ti ricordi come sono cominciate, ha deciso di prendersi cura di (Quasi).



