Qualche settimana fa si è tenuta la prima edizione del Baba Jaga Fest, un’operazione lodevole, per raffinatezza delle proposte e cura critica, che si articola intorno a una visione precisa di fumetto:
interiore, come punto di partenza per l’analisi creativa del mondo là fuori, non autoreferenziale;
sperimentale, nella pacatezza dell’esplorazione meditata, composta;
armonioso, di un equilibrio dinamico tra forme, tratti, pennellate, colori, tecniche.
Una materia che, a tentare di descrivere, si fa subito peccato: perché è come cercare di spiegare un’anima, un’intuizione di consonanze tra senso e segno, una sfumatura, un gusto. Sull’intelligenza organizzativa, che è evidente, non mi dilungo: ci sono andata, ho visto la mostra, ho ascoltato molte impressioni positive sugli incontri e sui workshop che si sono tenuti nel corso dell’evento, ho imparato un modo di accostarsi al fumetto, di capirlo e di diffonderlo con consapevolezza.
[per sapere chi ha orchestrato il tutto: vai QUI e scorri verso il basso fino alla voce “un progetto”]

In questa occasione, ho avuto la possibilità di conoscere e intervistare Eliana Albertini, che esponeva diversi suoi lavori, un ciclo in linea con il tema principale del festival: storie e disegni dall’Europa Orientale. Eliana ha declinato questo spunto nel senso di vedute di non luoghi turistici ispirati a rappresentazioni promozionali della Jugoslavia degli anni Novanta (come brochure, cartoline, locandine), realizzate con tecniche varie (tempera, pastelli e acquerelli principalmente). Queste opere sono state accostate, in contrappunto dialettico molto calzante, agli altrettanto pregevoli quadri e tavole di Maurizio Lacavalla. Di entrambi, oltre alla scelta dell’immaginario, interessante di per sé, perché ancora emergente, nel panorama del graphic novel, fumetto d’autore/trice/tor*, illustrazione, tavola di stampo quotidiano, peregrinazioni interiori a fumetti (questo tipo di fumetto e dintorni è rappresentato con finezza dalle proposte di Risma Bookshop, al Pigneto), mi colpisce la gestione del vuoto e del silenzio, il ritmo meditativo, l’attenzione all’oggetto, la sua interazione con i viventi, la sua capacità di determinare situazioni, scatenare fantasie, plasmare le nostre vite. Questo aspetto è stato valorizzato con acume dagli allestitori, che hanno progettato un percorso espositivo – con esiti di profondità immersiva – orientato a un tipo preciso di design di interni: una dimensione un po’ troppo impersonale per essere spazio domestico, e un po’ troppo fuori moda per arredare le hall minimaliste degli hotel di oggi. Dell’attenzione a questi e altri cronotopi non visti, ma a qualche livello impigliati nel nostro nervo ottico, introiettati chissà quando, ma già sostituiti da nuovi e più smaglianti prodotti e consumi, ho chiacchierato un po’ con Eliana.
Esco ora, molto ammirata, dalla stanza che ospita la tua mostra. Sembra di entrare in una dimensione parallela, di percorrere immagini dimenticate. Vuoi raccontarmi com’è nato il tuo interesse per le rappresentazioni turistiche dell’Ex Jugoslavia?
È sempre stata un’attrazione, sia per questo tipo di immagini, sia per quel tipo di luoghi, che ho anche visitato in occasione di un viaggio nell’Ex Jugoslavia, qualche anno fa. Ho messo insieme le due cose: l’Ex-Jugoslavia e i non luoghi. L’hotel è un non luogo, perché è un crocevia di persone. La Jugoslavia è un luogo che non esiste più. Questo mix di sensazioni mi ha portata a dire: ok, mi piacerebbe lavorare a un progetto di questo tipo. Due quadri esistevano già, sono di un paio di anni fa. Ho ripreso questa idea quando Alessio [Trabacchini, sapiente direttore artistico del festival, n.d.r.] mi ha proposto di partecipare al festival. Mi è venuto spontaneo tornare a ragionarci: ero presa da un’opera completamente diversa, che non sarebbe stata in linea con il festival. Questi non luoghi per me sono richiami naturali, fanno parte di una ricerca personale, che conduco autonomamente. Il Baba Jaga Fest mi ha dato la possibilità di unire un’espressione che sento istintiva al progetto di esposizione. È la prima volta che espongo quadri e non lavori legati al fumetto.
Anche perché l’immagine dipinta è un genere a se stante. Il fumetto è un altro medium, che risponde a esigenze diverse, ha un altro tipo di circolazione. Immagino che quando fai un fumetto, rifletti sulla sua fruizione, pensi ai lettori, a dove, come e quando lo leggeranno. Il rapporto che lo spettatore stabilisce con il quadro può essere anche molto diverso da quello che si instaura tra lettore e libro a fumetti. Penso che sia importante che gli autori di fumetti continuino a sperimentare e misurarsi con generi diversi. Che ne dici?
Sì, ero proprio in una fase di sperimentazione. Anche l’ultimo libro che ho fatto [Anche le cose hanno bisogno, Rizzoli Lizard, 2022, n.d.r.] ho usato un sacco di tecniche, c’è molta pittura lì dentro. Ogni tanto mi piace inserire la pittura nel fumetto. Poi, non ho una tecnica preferita. Ammiro chi ha il suo stile assodato e super riconoscibile, però io non ce la farei.

Credo che tu riesca a essere riconoscibile anche quando sperimenti con tecniche diverse. È lì che emerge la capacità dell’autore. Non necessariamente nel personaggio sempre uguale, che ripete le stesse dinamiche: un tipo di fumetto necessario nel panorama di oggi, che comunque ha le sue esigenze. Tu, però, fai qualcosa di diverso: mi sembra che tu faccia piuttosto parte di quella generazione di autori che decisi a esplorare le potenzialità espressive del graphic novel. Ti ritrovi?
Sì, il fumetto mi serve per esprimermi, non seguo un filo: vado dove mi porta, lo uso come strumento mio per capirmi, per guardarmi dentro. Fare fumetto per me è un processo introspettivo, un’indagine su me stessa, come fanno molti. Fare un quadro è più semplice, uno sfogo, liberare la mente. Dipingere è un gesto meccanico, anche perché copio i soggetti. Nei quadri esposti qui c’è stata una ricerca precedente, nel selezionare immagini, modificarle – ho usato campiture piatte, le ho un po’ reinterpretate – però poi nel momento in cui dipingo sospendo tutto, metto su la musica, mi distendo. Nel fumetto, se devo disegnare una tavola, ho uno storyboard da seguire, mantengo una concentrazione diversa. La tavola poi può cambiare, mentre la stai facendo pensi che forse la storia dovrebbe prendere una piega diversa, intervieni, devi ragionarci. Fare un dipinto per me è una catarsi, un atto liberatorio.
È bellissimo ascoltarti, sei molto consapevole di quello che fai. Si vede che è una ricerca che porti avanti da anni. Ora ne hai trenta, com’è la tua vita di fumettista trentenne?
Sì, ho sempre disegnato. Sono cose che so istintivamente. E poi sono contentissima dei miei trent’anni! Li ho festeggiati in un centro anziani, a Bologna… sai quelli con le bocce, il ristorante, la sala biliardo. È stato fantastico, non ho dovuto prenotare niente, semplicemente siamo andati lì e ci hanno dato da mangiare e da bere, siamo stati benissimo. Eravamo in mezzo a questi signori che stavano lì, guardavano la partita.
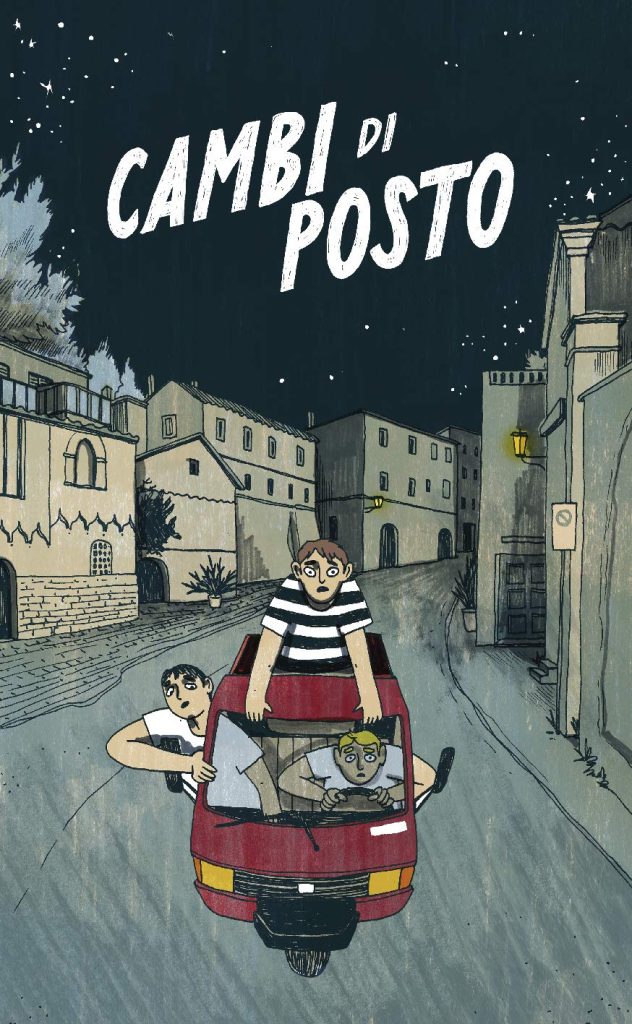
Questo ci riporta proprio ai temi che tu tratti, a quello che ti piace ritrarre. Tendi a cercare situazioni dimesse, di provincia. Anche la tua mostra, Hotel Jugoslavia, è molto vicina a questo interesse. C’è un rapporto diretto tra i non luoghi dei tuoi quadri e la provincia dei tuoi fumetti. Nel momento in cui ti misuri con te stessa, la tua ambientazione ideale, o quella che esplori di più, è la provincia. Giusto?
Sì, anche quando sono in una città, frequento i baretti di provincia. Mi ricordano le mie origini, dove sono nata e cresciuta. È quello che conosco e io mi sento di raccontare solo quello che conosco. Malibù (BeccoGiallo, 2019) ha proprio il luogo come protagonista, e Anche le cose hanno bisogno è ambientato in una provincia. Se penso a una scena, mi viene naturale collocarla in questa dimensione, con quello sfondo, anche se ormai sto a Bologna da un po’ di anni. Dovrei vivere a Bologna per trent’anni prima di riuscire ad ambientare una storia lì. Ho bisogno di conoscere molto bene una cosa per poterne parlare, di osservarla per un po’. Ho un attaccamento per un certo tipo di provincia, cioè la provincia di pianura. È una zona con dinamiche sociali sue, che poi si ritrovano in tante parti d’Italia, anche perché, per la maggior parte, l’Italia è provincia. Forse è per questo che in tanti si ritrovano in quello che racconto. Parlo di quelle cose perché mi viene naturale, se mi mettessi a raccontare di cose che non so, il risultato sarebbe posticcio, inefficace. Quello da cui vengo è un tipo particolare di provincia, perché è a metà tra due regioni, il Veneto e l’Emilia-Romagna. A livello identitario è un bel casino, perché è terra di confine, non sai mai quello che sei veramente!
Poi per te la provincia non è solo un’ambientazione. Anche la tua tecnica di racconto risponde alla resa della provincia, di quello che succede lì. Storie sospese che non sono mai paradigmatiche, con una scansione schematica, una struttura impostata, ma piuttosto fotografano momenti indefiniti.
Sì, non c’è mai una trama vera e propria, uno sviluppo classico. Cerco di rendere la dispersione che caratterizza la provincia: la provincia è dispersiva, il suo paesaggio è dispersivo, i suoi personaggi sono schegge impazzite. Sono cresciuta osservando queste cose. Poi in Accademia ci hanno anche insegnato la struttura, come si costruisce una storia. Però non mi ritrovavo granché, inizialmente ho pensato: il fumetto non fa per me, questo modo di raccontare una storia non mi appartiene.
Invece…
Ha cominciato a piacermi quando sono andata a pescare nelle mie cose, nella mia esperienza, costruendo le storie nel mio modo, senza una vera e propria trama, facendo interagire certi elementi.
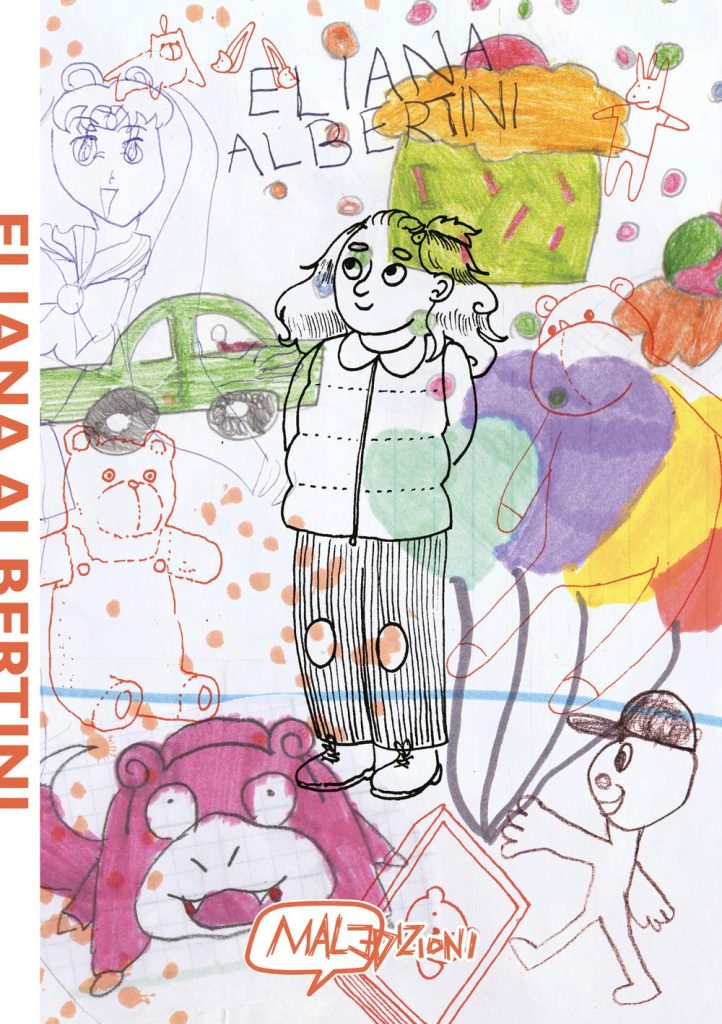
Infatti, è importante conoscere la struttura, per sapere cosa si aspettano i lettori, cosa piace ai critici, etc. Poi un autore declina la struttura a suo piacimento, ci gioca, la tradisce, oppure la sceglie come modo principale per raccontare, mantenendola salda, come cornice per sperimentare con altri aspetti che si possono collocare lì dentro, per esempio il disegno e il montaggio, etc. Tu invece la scomponi, la frantumi.
Io mi sento molto più a mio agio in narrazioni che non hanno un inizio, uno svolgimento e una fine. Nell’impostazione classica mi sento di poter sbagliare in ogni momento. Se qualcuno mi fa notare che le mie storie non hanno un finale, io mi sento molto tranquilla nel rispondere che la realtà è così, non ha una struttura, la vita non procede mai in modo organizzato, specialmente in provincia. Quindi non mi sento mai di avere sbagliato, anche se non rispetto una forma. Lo troverei forse un po’ pretenzioso, sarebbe una forzatura cercare di rendere un ambiente di provincia attraverso una parabola ben definita.
Infatti, l’ambiente si compone di tante cose diverse, è attraversato da una complessità di vettori, traiettorie, rapporti che si intrecciano. Nelle tue storie si legge e si vede un’Italia alternativa, molto diversa dallo sguardo consumistico, stereotipico con cui spesso è raccontata.
Sì, io cerco di fare l’anti-cartolina, non mi interessa comporre una visione glam, estetizzante. Ci siamo abituati, ma è come nascondere la polvere sotto il tappeto. Quando cerco di raccontare io non voglio neanche proporre una critica socioculturale definita. Semplicemente cerco di rendere la vita come la vedo, senza filtri diversi dal mio sguardo. La prospettiva che mi sembra più adatta per raccontare la complessità è quella di sospendere il giudizio, di diventare semplicemente un punto di osservazione. Questo mi è sempre interessato, anche quando guardo un film o leggo un romanzo.
Esatto, i due modi di raccontare l’Italia alla fine sono sempre: «Oh che bello!», oppure «Oddio che schifo!» Che bel panorama, ma che popolo orrendo, o ridicolo, o sfigato (etc.). La complessità delle tue storie ribalta questa concezione.
Sì, l’Italia stereotipata è sempre frutto di una visione che estremizza. Io mi sento semplicemente di dire: questo è quello che ho visto, che ho sentito, vedete voi che farvene, come/se giudicarlo. Anche in Malibù, non volevo necessariamente tracciare una critica. Io mi sento parte di questi personaggi, è l’esposizione di questo senso di appartenenza che rende la narrazione efficace. A nostro modo facciamo tutti un po’ schifo o siamo tutte persone incredibili: cerco di esprimere queste contraddizioni, mi è sempre piaciuto esplorare personaggi non lineari, perché nessuno lo è. Per questo puoi trovare personaggi stratificati, a tratti belli e a tratti rivoltanti. È giusto ricordarsi che a volte facciamo un po’ schifo, è liberatorio. Mi piace inserire questo aspetto, nelle persone che ritraggo e racconto… non mi va neanche di dire personaggi, perché è gente che potrei effettivamente incontrare per strada.

Forse tu non esalti l’aspetto della critica sociale puntando il dito, ma si evince dalla lettura, dal modo in cui resti aderente alla tua visione della realtà, senza tracciare un giudizio. Questo rifiuto del giudizio si rispecchia anche nel modo in cui ti orienti alla cultura materiale, concentrandoti sulla rappresentazione degli oggetti. Gli oggetti sono i protagonisti, sin dal titolo, di Anche le cose hanno bisogno. Qui ti muovi tra tre cose: ambienti, personaggi, oggetti. Studi le interazioni tra questi tre elementi. Com’è nata l’idea di partire dall’oggetto, o anche dall’ossessione per gli oggetti che ha la protagonista? Di nuovo, non c’è una critica sociale sviluppata distesamente, ma la sensazione che io ho avvertito leggendolo è: noi siamo pieni di questa roba, questa roba ci sta ammazzando e questa è una delle storie possibili che si snodano intorno a questo aspetto della contemporaneità.
L’idea mi è venuta durante il primo lockdown. All’epoca si passeggiava tanto nei dintorni delle proprie case. Camminando mi accorgevo di tutte queste cose lasciate per terra dalle persone. Ho iniziato a fotografarle, a collezionarle, in un certo senso. Sentivo di avere qualcosa da dire sugli oggetti. La protagonista è un pretesto per parlare di questi oggetti, per permettermi di rappresentare le cose che volevo disegnare. Ho pensato a come potesse essere questo personaggio e mi è sembrato più sensato scegliere una spazzina, che sta in mezzo a queste cose tutto il tempo. Sicuramente non sarebbe stato un personaggio canonico, ma un po’ strano, come gli oggetti che raccoglie: una femminilità alternativa, non vista, non raccontata. Ho una fascinazione per tutte le riflessioni che possono stare dietro gli oggetti. Gli oggetti sono cose non vive, ma condizionano la nostra vita, formano le persone: alla fine siamo quello che possediamo ed è inevitabile in questo tipo di società, io ci sono dentro fino al collo. Ho cercato di usare questo spunto creativamente, e devo dire che prima di fare il libro non ho riflettuto così tanto. Ci rifletto ora, a posteriori: queste riflessioni sono un po’ come il bozzetto di un disegno che hai già fatto in definitivo. È stato un lavoro molto libero: non ho fatto storyboard, è stato tutto molto spontaneo, proprio come la storia raccontata nel libro. La protagonista cammina senza riferimenti e io ho lavorato senza darmi riferimenti precisi, al di là del tema degli oggetti. Si è costruito da solo, senza che io stessi tanto a pensarci.
E ne è uscito un ritratto femminile molto sui generis, insolito. Tante fumettiste donne, tante autrici di oggi, della nostra generazione, partono dall’auto-narrazione, sentendo il bisogno di raccontarsi come donne, dopo secoli di storia femminile invisibile e taciuta: quella che è stata, ma anche quella che abbiamo studiato, perché nel canone degli studi ci sono pochissime artiste, letterate, registe e così via, e questo chiaramente ha le sue radici storiche in una mancata presenza delle donne in vari aspetti della società. Questo dato è oggetto di molte indagini, sia dal punto di vista critico che creativo, e l’auto-racconto a fumetti del sé femminile è uno degli strumenti per farlo. Mi sembra che tu preferisca trasferire il tuo auto-racconto negli ambienti e negli oggetti, piuttosto di scegliere una alter-ego, come invece fanno tante altre autrici. È un’operazione molto interessante e molto diversa rispetto a quello che si vede normalmente. Ci sono artiste bravissime che partono dal sé, mentre il tuo io si è distribuito sulla cultura degli artefatti: architetture, oggetti, il loro rapporto con le persone, con la natura, con il paesaggio, città, cittadine. Che ne pensi?
Sono d’accordo, io ho pensato molto spesso che se io sono come sono – il mio carattere, la mia personalità – molto di me deriva da dove sono nata. Questo l’ho capito quando me ne sono andata dalla mia città di origine, mettendo in discussione il mio senso di appartenenza. Il tipo di introspezione che porto avanti nei miei lavori è il racconto di me stessa attraverso il luogo, perché una parte di me si identifica ancora molto in quello, a volte mi crogiolo anche in questa dimensione. La sento vicina, mi piace, la rivendico, o comunque sono molto serena con le mie origini. Fare storie legate a quei posti è un po’ come mettere in ordine il mio rapporto con le origini: il conflitto c’è e c’è stato, tutti noi lo attraversiamo. Quante volte abbiamo pensato: «me ne vado di qui, perché qui non c’è niente, non ci sono le possibilità per diventare quello che voglio». Ho avuto bisogno di scrivere queste storie per mettere a posto questo sentimento ambivalente nei confronti della mia provenienza.

Anche se tu non parti necessariamente dalla narrazione personale e femminile, quando hai cercato tuoi simili per fondare un collettivo, come Blanca, hai comunque scelto delle donne.
È stato abbastanza naturale: ci siamo trovate, eravamo in corso insieme in Accademia. Non ci conoscevamo bene all’inizio, ma ci piacevano le stesse cose, cercavamo uno stile simile, anche se chiaramente è sempre tutto in divenire. Bologna pullula di collettivi di fumettisti e così abbiamo pensato di fondarne uno anche noi. All’inizio eravamo io, Irene [Coletto, n.d.r.], Martina [Tonello, n.d.r.], poi abbiamo invitato anche Noemi [Vola, n.d.r], e ha accettato. Così siamo partite. Non avevamo un’idea precisa, ma ci interessava un target: vedevamo che il fumetto per bambini era poco rappresentato nei collettivi bolognesi e nelle autoproduzioni, che tendenzialmente si rivolgevano a un pubblico di adulti. Andava molto l’introspezione nel fumetto, c’era molta sperimentazione, ma, in fondo, su un tipo di storia comune a tanti autori. Così abbiamo pensato di fare fumetti per bambini, anche per il fatto che all’Accademia avevamo seguito il corso di Storia dell’illustrazione e ci aveva affascinate tutto il mondo del “Corrierino”: storie divertenti, ma in cui ai bambini non si nascondeva nulla, cosa che invece adesso si fa tantissimo. Nei fumetti per bambini di oggi non si può parlare della morte, per esempio. Ci siamo dette: non c’è più una rivista per bambini che non sia patinata, censurata, che non nasconda quella che è la vita vera. Quindi abbiamo voluto provare a fare quello. Stavamo tutte cercando la nostra strada e ci è servito moltissimo, perché è stata la cosa che ci ha fatto girare i festival, qualcosa che potevamo fare al di là dell’Accademia. Abbiamo imparato molto: a collaborare, a curare l’aspetto editoriale, la distribuzione, etc. Ci è servito come punto di partenza delle nostre cose. Era molto femminile, questa cosa era molto evidenziata: eravamo quattro ragazze, ma non necessariamente volevamo mettere a tema la femminilità. Abbiamo chiamato anche dei ragazzi in un numero, per avere tanti punti di vista diversi.
Al di là del “Corriere dei Piccoli”, cosa ti piace leggere e guardare?
Come forse dicono tanti fumettisti, non leggo tantissimi fumetti. Leggo tanta narrativa, mi piacciono molto gli scrittori americani, soprattutto Don DeLillo e Philip Roth. Anche perché allestiscono anche loro storie in provincia, i grandi spazi delle periferie dell’entroterra americano, da riempire. Quando non c’è niente, c’è tutto da raccontare: cade una foglia da un albero e puoi raccontare quello. Certe cose in un posto del genere fanno più notizia rispetto ad altri posti, una città dove succede di tutto e tutto è un po’ caotico. Sento l’immaginario della provincia americana molto simile al contesto da dove provengo. In Malibù faccio molto riferimento ad America oggi, sia l’adattamento di Robert Altman (1993), che i racconti di Raymond Carver, tra cui quello che dà il titolo al film: queste storie sconnesse tra di loro, che si intersecano casualmente. Di fumetti, uno che mi ha molto ispirato è Beverly di Nick Drnaso (2016). Spesso i miei fumetti sono abbinati a quelli di Miguel Vila [Padovaland, Canicola, 2020 e Fiordilatte, Canicola, 2021 n.d.r.], per il tema, anche se la prospettiva è diversissima: io da dentro e lui da fuori, perché alla provincia veneta lui è arrivato come forestiero, mentre io ci sono nata. Siamo anche molto diversi per il disegno, ed è un confronto che mi piace molto, è sempre interessante. Un altro autore di fumetti che ammiro molto è Paolo Cattaneo, sono stata contentissima quando la Rizzoli mi ha chiamata per il libro, perché avevano appena pubblicato Non mi posso lamentare (2019).




