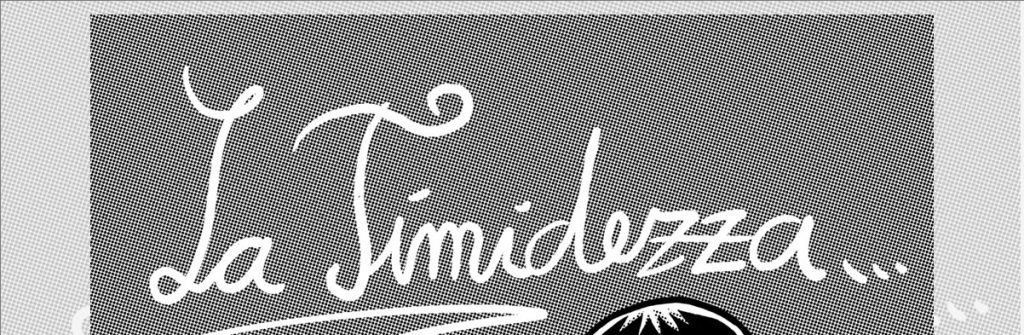L’ipotesi di ricordare qualcuno che non si è conosciuto, in persona o in opere, non può riuscire ad apparire particolarmente elegante. Figuriamoci poi tessere panegirici, saremmo sotto la tenda da circo di una ipocrisia della peggiore specie. Certo, va detto che scrivere necrologi non è da tutti, in un mondo editoriale dove probabilmente ci sono tanti coccodrilli precotti e surgelati, pronti da passare al microonde per sbatterli lestamente in pubblicazione.
Va detto anche che i necrologi sono a tutti gli effetti un genere letterario a sé stante e non sono certo per tutti – e va anche considerato che possono diventare una sorta di arma spietata, di strumento termonucleare che non si dovrebbe usare mai ma che a volte viene invece impiegato con una magistralità tale che lo scempio della vittima appare pienamente giustificato, e mi riferisco alle occasioni prettamente politiche, perché gli attori di quell’agone inevitabilmente si consegnano al diritto dell’opinione pubblica di giudicarli. In questo filone la tradizione americana del commento politico ha prodotto esempi preclari, come il necrologio di William Jennings Bryan scritto da H.L. Mencken e pubblicato nel 1925 sul “Baltimore Evening Sun”, oppure il capitolo 666 di Better Than Sex di Hunter S. Thompson, aggiunto in extremis, proprio subito prima dell’uscita del libro, nell’aprile 1994, per ricordare opportunamente Nixon.
Potremmo usare questi due testi per fare una riflessione sugli effetti malefici del potere e in particolare su quello stadio di corruzione finale della memoria che spesso viene operato subito dopo la dipartita di certi personaggi. Non è opportuno portarlo fin dove si potrebbe, però, non stavolta – per ragioni che saranno evidenti tra poco. Ma è uno spunto che facilmente potrebbe tornare a riproporsi.
Bryan è stato una figura decisamente influente lungo vari decenni di vicende politiche americane, un politico di carriera, con convinzioni che definiremmo populiste che lo condussero a essere anche un innovatore in materia di tecniche da campagna elettorale, con una sensibilità decisamente in linea con i tratti della società mediatica in pieno sviluppo (per esempio, lo stump speech, il discorsetto standard da ripetere pari pari a ogni sosta nelle tappe di una campagna elettorale – qualcosa che il pubblico ha imparato non solo a tollerare ma ad attendersi). Tre volte candidato alla presidenza e tre volte sconfitto, segretario di Stato sotto Woodrow Wilson, dimissionario in disaccordo con quest’ultimo per la reazione troppo veemente verso la Germania per l’affondamento del Lusitania, opportunista voltagabbana sul proibizionismo, razzista sostenitore della segregazione razziale, evangelico negatore dell’evoluzionismo, fino al punto di non considerare l’umano un mammifero. Mencken ci dice che l’uomo che ricorda è quello delle sue ultime settimane ma ci restituisce anche giudizi complessivi sul valore della persona – «He was ignorant, bigoted, self-seeking, blatant and dishonest […] deluded by a childish theology, full of an almost pathological hatred of all learning, all human dignity, all beauty, all fine and noble things». Fast forward quasi cento anni e… chi ci ricorda?
Voglio dire, probabilmente a Mencken Bryan non piaceva anche per ragioni che non confessa ma è estremamente lucido nell’individuare un pericolo che si è poi puntualmente, grottescamente e tragicamente concretizzato:
«The job before democracy is to get rid of such canaille. If it fails, they will devour it»
E infatti si è andati esattamente in quella direzione, quella della canaglia.
Sull’asprezza dei suoi stessi toni si interroga, quasi settant’anni più tardi, Hunter Thompson, mentre scrive un pezzo che porta a livelli ancora più compiuti e completi il vetriolo dell’invettiva. Certo, la potenza di fuoco richiesta è anche più alta nel suo caso, perché il bersaglio, Nixon, alla presidenza c’era invece arrivato, uscendone anzitempo indecorosamente in un quadro oggettivamente criminale. Vi rimando a quelle nove pagine, leggetele, perché non sono solo un violentissimo ed esilarante roast post-mortem, sono molto di più, anche se non credo possano smuovere un solo cervello bollito tra quelli degli agiografi o degli adepti. Ma non è quello lo scopo. Era cercare di farci ragionare su cosa vuol dire quando un presidente dice «se il presidente fa così, allora non può essere illegale». E hai voglia a dire che sono loro, i tontoloni di oltre oceano, lo sapete bene che questo mantra è diventato rapidamente il credo e la para-ideologia che da noi hanno sostituito (ma neanche del tutto, ovviamente) i ridicoli parafernalia del ventennio. Tutto si tiene, il viaggio verso l’entropia finale non è una simpatica scampagnata, è un ingorgo che promette singulti malthusiani, di sempre maggiore indecenza e di sempre maggior potere distruttivo.
Ma non è il caso di spingersi oltre su questo percorso, come dicevo, qui e ora, in questo mese su QUASI. Perché, per fortuna, la memoria non richiama un politico o un personaggio pubblico controverso (nel senso di detestabile). Resta però la questione della non conoscenza, perché Tuono Pettinato non lo conoscevo, né come persona né come autore, e posso presentarmi in questa occasione solo a mani vuote (o ingombre dei soliti ceppi, come avete potuto vedere dai paragrafi precedenti).
Non posso portare qui né un ricordo né una percezione, però, dalla prima volta in cui l’ho sentito nominare, ho saputo immediatamente dove avesse preso il suo nom de plume.
A Jorge Luis Borges non si può non riconoscere un certo tipo di ecumenismo – arduo, di marca cosmopolita ma fortemente esoterica, improntata al preziosismo, ma pur sempre ecumenismo – con un livello di erudizione che ci getta di sana pianta in una oscurità nella quale restiamo meravigliati e rattrappiti a chiederci quale e quanta della bibliografia che puntualmente cita sia vera piuttosto che inventata. Come se questo potesse fare veramente una differenza.
Quello che ci ammannisce Borges non può che essere un racconto. Troppa densità, troppo nitore, troppo buio, troppa ineluttabilità, troppa varietà, troppo tutto insieme per rimettere tutto in un romanzo. Non reggerebbe, avrebbe il peso specifico di una stella di neutroni. Le storie non hanno quasi mai bisogno di dialoghi, sono raccontate da narratori assoluti (la voce del protagonista, quella di un anonimo storico) ma dalla conoscenza imperfetta. Non serviranno duecento pagine, qualche decina al più. Sono più componimenti poetici intrecciati su un damascato di ricercatezze e trompe l’oeil, senza soluzione di continuità.
E quando, nella raccolta Finzioni, si arriva all’universalmente arcifamoso La Biblioteca di Babele, non si può non notare come il narratore sia un uomo della Biblioteca che ha rinunciato a ricercare il libro dei libri, il catalogo dei cataloghi o l’unica sala dalla forma diversa che avrebbero, ciascuno, se esistessero, il crisma del divino (stavolta forse è possibile acquietare, almeno un poco, la sete feroce che induce uno Zahir…), votandosi ad amministrare il gruppo di sale esagonali che gli è stato assegnato. E che tra tutti i libri che esse contengono, il migliore si intitola Tuono Pettinato.
Chissà, magari era solo l’adynaton che suonava bene all’uomo che l’ha scelto come nome da battaglia di penna. Oppure a volte basta la sola musicalità a spiegare molte cose, senza la necessità di chiamare in causa letture troppo complicate. Però, pur non sapendo proprio niente, la tentazione di fare l’ipotesi che una scelta del genere avesse più livelli e più sfaccettature viene facile. E scegliere di pescare in Borges somiglia a criptare la spiegazione di quali livelli e sfaccettature con un algoritmo a base di quella moltitudine di specchi e riflessi che l’argentino sapeva mettere a disposizione sua propria e del lettore.
La scelta di quello pseudonimo da parte di qualcuno mi dice qualcosa, mi fa pensare, me la fa mettere in relazione con l’essenziale riflessione borgesiana su storia e progresso (intrinsecamente illusorio). Borges si considerava un conservatore, un’etichetta che non mi piace, mi sa di irrealistica rivolta contro il secondo principio della termodinamica, ma credo che la sua fosse più consapevolezza di una impossibilità materiale del progresso unita a un sincero disgusto per tutte le ideologie che trituravano (e triturano) l’individuo in nome di una delle varie plebee divinità collettive. Come Mencken e Thompson, Borges sapeva bene che le dittature odiano l’intelligenza e lo spirito. Ma potrebbe anche essere, come ipotizzavano alcuni a Tlön, che il tempo stesso non è che non esista, è che sarebbe già tutto trascorso e che la nostra esperienza della vita non sarebbe che un riflesso di quel tempo (un replay, verrebbe da dire a me). Senza una minima fiducia in un futuro reale è chiaro che è un onere insostenibile professarsi progressisti.
Chissà se l’intenzione era anche confonderci un po’, incutere del timore tonitruante, ma con una capigliatura ordinata (anche solo in senso metaforico) e rassicurante. Non ho elementi, non saprei dire. Il libro, nel racconto di Borges è anche il migliore, pure se in un contesto limitato, un gruppo di esagoni, non tutta la Biblioteca. Chissà se anche questa era un’aspirazione dell’uomo, essere un migliore, non in assoluto ma per qualcuno, da qualche parte, dentro qualcosa, ancorché limitato.
Così, in questo mese di giugno scorrono le memorie dei miei compagni di redazione e di altri ancora che portano le loro voci proprio per ricordare Tuono Pettinato e la sensazione che irradia da tutte queste tessere di mosaico è che l’uomo fosse il possessore di una ricchezza multiforme, seria e giocosa, oracolare e tenera, di quelle che rendono qualcuno il commensale che vorresti incontrare per caso o l’amico che non vuoi perdere.
Nei toni, qui intorno, c’è un senso di perdita incomparabile. Mencken diceva che diventiamo sentimentali riguardo ai morti – in questo caso credo che il sentimento fosse ben radicato verso il vivo, senza alcuna necessità di posticce esaltazioni una volta che se ne fosse andato.
Il senso di mancanza è forte e non sorprende. Lo ispirano quelli che sono tuoni e pettinati, c’è poco da fare, non importa se in uno o in molti esagoni. Vi faccio un esempio: Borges meriterebbe un recupero più accurato da parte mia – perché anche se non ricordo quel che ha scritto, quel materiale è comunque divenuto un libro di sabbia interiore – mi prendo l’impegno di riuscirci, prima o poi, ma riprendere in mano Finzioni mi ha consentito di incontrare nuovamente un altro di loro, Franco Lucentini. La potrete prendere come una divagazione oziosa e magari poco rispettosa, ho iniziato parlando di necrologi spietati di politici deprecabili, finisco comunque trattando di qualcun altro, non si presenta bene, ma vi assicuro che non è così.
Al termine dell’edizione Einaudi del 1995 così annota:
«Quando uscì nei Gettoni Einaudi trent’anni fa, questa traduzione – la prima in italiano di un’opera di Borges, sollevò obiezioni come troppo letterale, troppo spagnoleggiante. Rivedendola ora non ho mancato di apportarvi ritocchi qua e là, per aumentarne la letteralità e i presunti spagnolismi. Non sono responsabile, invece, delle correzioni in buon italiano che ne hanno afflitto la ristampa presso un altro editore, in una recente raccolta di tutte le opere di Borges.»
Mi ero ripromesso di placare la lamentazione che, ne sono consapevole, costituisce la banda portante di quel che scrivo qui – ci sono riuscito solo in parte, lo strazio e il grande scempio dell’esistenza ad opera degli esistenti stessi gridano un richiamo sempre troppo forte, le loro troppe ramificazioni richiedono di non essere ignorate. Chiamatela ossessione ma ritengo che sia, almeno per me (voi fate come ritenete vi sia più congeniale) prassi doverosa, per non passare quietamente dalla parte dei massacratori. Ma, almeno in parte, ho trovato un momento di requie grazie al tentativo di leggere, appena, lo pseudonimo di un uomo che non ho conosciuto né nella vita né sulla carta e con il quale l’unico punto di contatto noto è la lettura di almeno un racconto di un argentino divenuto cieco, morto in Svizzera ormai molti anni fa.
È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.