Ricordo che pioveva, e che per qualche motivo non avevo preso il motorino e per questo motivo me la sarei beccata tutta. Ricordo la corsa verso casa, che poi, diciamo i brevi scatti che mi permette il mio fiato proverbialmente corto, da una tenda da sole alla chioma di un albero, dalla pensilina di un distributore all’androne di un bar chiuso. E bum bum bum il cuore. Avevo un tesoro sotto la maglia. Neuromante, di William Gibson, in quella versione dell’Editrice Nord con quella specie di ritratto di Che Guevara blu elettrico e verde acido su sfondo rosso scuro. L’avevo appena comprato, a dirla tutta ero uscito proprio per quello, dopo averlo ordinato qualche giorno prima in libreria, e volevo portarmelo a casa possibilmente prima che diventasse una polpetta di cellulosa e inchiostro. Il che m’è per lo più riuscito, pur essendo rincasato zuppo come il pulcino che ero, con i capelli lunghi incollati alla faccia e un gilet di jeans della Energie pieno di toppe assurde abbinate a cazzo di cane che ad andarci in giro sembravo una crisi d’identità ambulante.
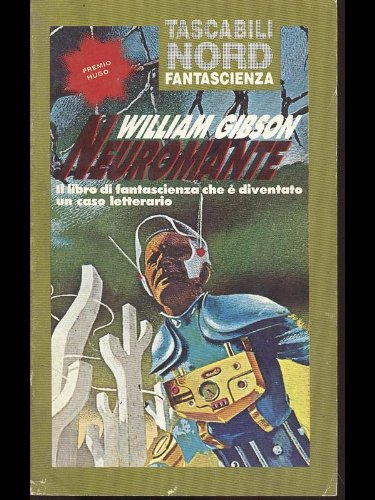
L’avrei portato a lungo con me, Neuromante, fagocitato alla prima lettura ma riletto all’infinito, poche pagine per volta, perennemente sotto la sella dello scooter al punto che puzzava un po’ di olio motore a dirla tutta, ma anche questo a modo suo faceva molto cyberpunk. Eccola, la parola. M’innamorai del gioco di ruolo della Stratelibri, per l’appunto Cyberpunk 2020 (duemilaventi, capito? Roba che ai tempi era il futuro, mica adesso che s’è fatto lontano nello specchietto retrovisore e tutto sommato meno male visto quella robetta lì della pandemia ma pure il fatto che è mancato mio nonno, insomma diciamolo che ho visto anni migliori), che mi ha aperto quel mondo lì. La notte che bruciammo Chrome, che pure ho consumato tipo che ci ho lasciato il sangue dei polpastrelli sulle pagine, e l’antologia Strani Attrattori, che a sua volta mi ha aperto quel sottomondo che è la Shake, realtà assurda quanto avantissimo nell’editoria, e tanta altra roba. Il punto è che il Cyberpunk per me rappresenta l’entrata nell’adolescenza, quel periodo in cui vai al liceo e un mondo che non è più casa tua, letteralmente una granata a frammentazione carica di stimoli, ti scoppia in faccia. Le due cose per me si sovrappongono, proprio per motivi biografici.
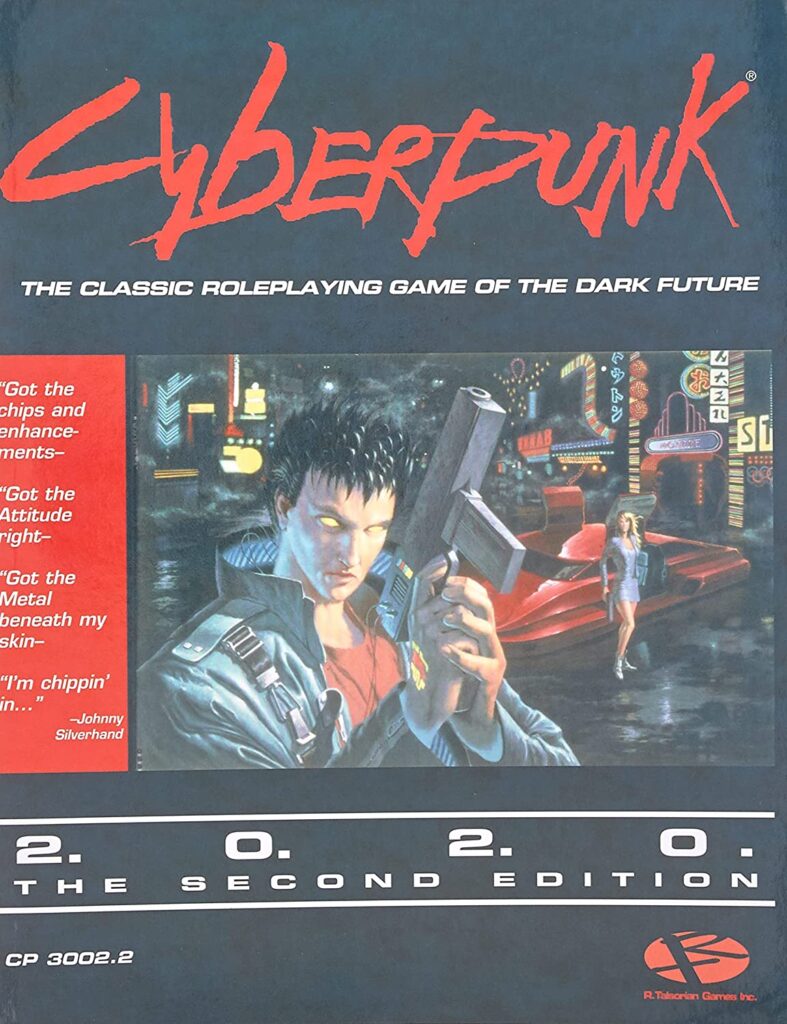
C’erano soluzioni narrative che a quindici o sedici anni mi facevano morire, come quella di integrare il corpo umano con oggettistica e tecnologia stilosissima tipo gli occhiali a specchio incastonati nel cranio e i rasoi sotto le unghie, ma anche la rete e gli hacker che si collegano con uno spinotto nel cervello, io me la immaginavo molto geometrica e pixellosa, a metà tra un romanzo di Daniel Galouye e i primi tentativi un po’ patetici di CGI, tutto rigorosamente in grafica vettoriale. Anche la mia immaginazione non ha retto al tempo. E poi c’era la cyberpsicosi, un concetto creato dagli autori del gioco di ruolo (2020… ancora mi piega dal ridere ‘sta cosa…) per limitare i power players. In poche parole, per ogni impianto cibernetico che metti al tuo personaggio tiri dei dadi e sottrai dei punti. Meno ne hai più sei vicino allo sbrocco. Quando vai a secco, dai di testa, mandano una squadra di commandos a smontarti a fucilate e qualcuno ti raccoglie con un cucchiaino. E qui tutto si connette con la bombetta che ha sganciato Netflix.

Cyberpunk: Edgerunners. Una serie che mi sono guardato così, «Meh, vediamo un po’ ma non ci credo granché». E invece boom. Lo spirito di quando sono stato paracadutato nell’adolescenza è tutto lì. Un ragazzo in fondo alla catena alimentare che si riempie di ferraglia cibernetica per uscire dalla sua sfigatissima condizione correndo sul filo del rasoio in una serie di missioni al limite del suicida con una banda di disperati come lui, sempre più letale e sempre meno umano a ogni impianto. L’adrenalina, la critica sociale, il mondo senza pietà e quegli adorabili sfigati senza speranza che rifiutano categoricamente di mollare, Night City, la megalopoli stile Blade Runner sotto anfetamina che non dorme mai, il profumo di Akira. Tutto lì, spremuto in una serie anime carica a pallettoni che mi ha sparato in faccia il ragazzino che ero e che mi fa chiedere quanto ne è ancora rimasto, rispondendomi che, in realtà, è più di quanto pensassi e non avrei risposto uguale in altre fasi della mia vita, ma in questa sì. Perché alla fine, dopo qualche annetto, con te stesso fai un po’ pace, tanto ti sembra di esserti mosso che alla fine scopri che quel che conta è rimasto sempre lì e tutto sommato non è male. Come uno che si piglia la cyberpsicosi ma sotto sotto è sempre lui, e qualcuno arriva in tempo per smontargli di dosso la ferraglia e recuperare quel che di buono andava salvato. A volte va così, è una fase, poi tutto passa, anzi, torna.

Stefano Tevini e l’Onorevole Beniamino Malacarne sono un reboot del classico Dottor Jekyll e Mister Hyde ma, invece di seguire il trend contemporaneo dell’inclusività, deviano dal canone nel fatto di essere ambedue dei fetenti. Nati entrambi nel 1981, uno è una specie di scrittore (romanzi, fumetti, articoli, quella roba lì), l’altro è un lottatore di wrestling. Tevini ti parlerà di fumetti, fantastico e simili, Malacarne di Wrestling (oltre a occuparsi della gestione operativa dei reclami e soprattutto di chi li esprime).



