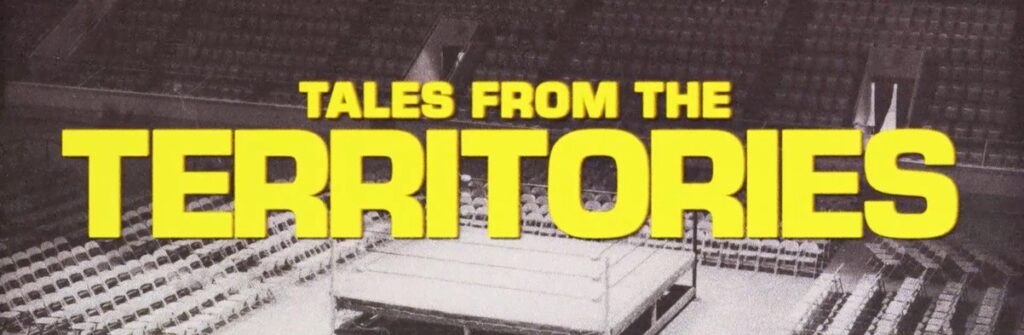Colpisce che una serie di conclusioni riguardo alle difficoltà che hanno, e che continuano ad avere, le organizzazioni in questa epoca informatizzata e, più o meno, digitalizzata, siano state tratte in un periodo storico nel quale i computer non avevano ancora conquistato la dimensione personale e domestica degli individui e delle famiglie. I computer erano oggetti da sicurezza nazionale e, in seguito, solo da azienda, anche se ci arriveranno gradualmente e abbastanza di pari passo con l’evoluzione del concetto di personal computer. In pratica, tra anni ’50 e ’60, il periodo a cui mi sto riferendo, si continuava a lavorare con macchine da scrivere, carte carbone, matite copiative (anche il fax raggiunge un livello di disponibilità generale solo a metà degli anni ’70). In quei due decenni vengono pubblicati studi e sanciti principi che, un po’ sorprendentemente un po’ no, continuano a dimostrare una tenace validità ancora oggi.
Quello che mi viene in mente stamani è la legge di Parkinson, definita come tale dall’incipit di un saggio, pubblicato sull’Economist nel 1955, a firma di Cyril Northcote Parkinson, uno storico britannico specializzato in storia navale ma che divenne, non intenzionalmente, come spesso accade, una celebrità e un pensatore di riferimento nelle teorie del management e della pubblica amministrazione. Sai che palle, vero? Un po’, però, se avrete la pazienza di seguirmi, sono ragionevolmente sicuro di riuscire a mostrarvi il terrore in una manciata di coriandoli grigi, ricavati, probabilmente, da fotocopie troppo scure o stampe su carta riciclata.
La legge eponima dice: «il lavoro si espande fino a occupare tutto il tempo disponibile».

Che c’entra con il procrastinare? State calmini ancora un po’, sarà più chiaro tra qualche paragrafo.
In pratica, un’organizzazione stabilita e nominalmente orientata verso degli obiettivi, tenderà, invece di raggiungere tali obiettivi nel modo più economico possibile, a privilegiare il «riempimento» dei tempi definiti (a prescindere dalla sensatezza) per raggiungerli. Il contenitore non è funzionale a veicolare il contenuto, è vero il contrario. Posti dei confini, lo spazio al loro interno viene popolato da materiale definibile come «lavoro». Interi business di servizi professionali si basano su questa concezione distorta e non si intravede una via d’uscita.
Una simile posizione è fatta della stessa materia del procrastinare, solo che opera en travesti, finge di essere impegnatissima, fa tardi, ogni giorno, aggiunge all’orario canonico di lavoro un’ora, due ore, sconfina nei fine settimana, ma, in ultima analisi, non si preoccupa veramente di arrivare a un risultato, non più di quanto ha a cuore sudare copiosamente lungo il percorso, mostrando una sofferenza che dovrebbe valere come patente di valore in corso d’opera.
Il procrastinatore privilegia una incompiutezza in nome, spesso, del timore di una inadeguatezza che percepisce come approdo pressoché certo, ma nel fermarsi, nel rendersi inerte, non reattivo, sperimenta anche un ritmo diverso, in parte esercita una rivolta contro un dettame che non riconosce come proprio. In qualche modo il suo rinviare, per quanto primariamente autolesionista, è sia illusoriamente protettivo, rispetto a istanze perfezioniste che finirebbero cocentemente ferite laddove il compimento, il risultato, fosse deludente (come del resto atteso), sia inconsapevolmente affermativo, perché riduce l’importanza di qualcosa, togliendolo dal tavolo, dal piano, dal programma. Dicendoci, senza dircelo, che è rinunciabile. Non così importante, in fin dei conti.
Il procrastinatore ci sta male, a volte malissimo, perché mente e quel che rinvia in realtà rappresenta comunque qualcosa di importante per lui. Sminuirlo, gettarselo alle spalle, è un modo per smarcarsi, ma è una recita alla quale il soggetto stesso non crede e tutti vedono che è angustiato e perseguitato peggio di un Oreste alle prese con le Erinni. La procrastinazione più terribile del procrastinatore è costituita, difatti, dal rinvio perenne del momento (immaginato come materialmente non configurabile) in cui le paure potranno essere affrontate. Ma siccome un tale affrontamento si alimenta, meglio che di qualsiasi altra cosa, di azione e di risultato – il procrastinatore, quasi certamente, continuerà a procrastinare.
Nelle organizzazioni, invece, bestie tanto acefale quanto pluricefale, la paura, il terrore, è quello di farsi cogliere a non fare niente. Posto che molte persone hanno una predilezione (e un effettivo talento, migliore di quello che hanno tutti quelli che pensano di essere bravi ma fanno solo casino) per fare effettivamente niente, va anche riconosciuto che sono molto rari i casi in cui questo niente è schietto, mero, non complicato da finzioni. I tempi, le deadline, le milestone, diventano legge e religione, anche se non si sa bene come sono stati definiti – a volte sulla base delle esperienze pregresse, a volte di mera autorità, perché così si vuole ai piani dei consigli di amministrazione. Quello che è certo è che, dato un certo tempo, quello sarà riempito da lavoro e, anzi, le risorse disponibili saranno via via sempre più insufficienti. Obiettivo e mezzi per raggiungerlo si invertono con grande facilità in questa società capitalista aziendalista e non è facile ribaltare gli equilibri – si può immaginare di riuscirci quando si riparte dal prato verde ma la coazione a ripetere è preponderante e le startup diventano rapidamente scimmiottamenti di modelli già visti e rivisti, solo un po’ più agili, finché non terminano i soldi.
In entrambi i casi gli obiettivi e le finalità finiscono postergati rispetto ad altri valori. E non facciamoci trarre in inganno da quelle situazioni nella quali, nei contesti aziendali, vengono imposti tempi «sfidanti» (come piace, al giorno d’oggi, tradurre «challenging»). Anche quello non è un atteggiamento amorevole verso l’obiettivo – lo sminuisce, lo relega a feticcio scontato, non si vuole sapere quali siano i suoi effettivi requisiti di realizzazione, diventa un checcivuole? e non si va oltre.
La realizzazione, per gli esseri umani, è un po’ come la qualità per il René Ferretti della serie Boris. Quando non ci sei tagliato non ci sei tagliato, meglio se lasci perdere. E se non hai mai provato veramente ad arrivarci, diventi via via sempre più anchilosato – abiterai da un’altra parte, ma sarai in abbondante compagnia, sempreché la cosa ti faccia piacere.
Per quanto mi riguarda, sono stato un discreto procrastinatore – e avrei tutto il talento per poterlo essere ancora, ma ho bevuto, credo inavvertitamente, dalla fonte del compimento e sono riuscito ad accettare di finire, di tanto in tanto, qualcosa, arrivando pure a prenderci gusto. Ma non è che sia una conquista facile o da dare per scontata, è sempre una battaglia, toujours le même commencement, come dice un bel pezzo dei dEUS di qualche anno fa (dieci, ormai).
Questo perenne andare avanti è estenuante – il procrastinatore tenta, invano, di opporsi all’incedere inevitabile dell’entropia, rimandare a domani, e al domani di domani, potrebbe far immaginare la possibilità di conservare l’oggi, con tutto quel che contiene, facendolo semplicemente scivolare di una casella in avanti sul calendario. Ma, ovviamente, non è così, e ciò che rinvii a domani si avvicina di un giorno in più a una sua più o meno naturale scadenza. Il procrastinatore che smette di fare il procrastinatore senza passare all’estremo opposto (il fanatico dell’azione) potrebbe quindi portarsi dietro questa consapevolezza, lucida e corretta, di non essere, in fin dei conti, l’attore potenziale di chissà quale cambiamento. Le cose tendono ad andare, in gran parte, per conto proprio, e a volte è importante saper aspettare, rinviando il confronto. La storia non avrà assegnato loro la palma dei condottieri più rinomati, ma da Quinto Fabio Massimo Verrucoso a Kutuzov, in diversi hanno costruito il proprio successo sul rinvio e sull’evitamento.
Ma diventa sempre troppo facile, appoggiarsi a quel relativo, innocuo, piccolo smottamento in avanti – è così che una varietà di aspetti, dalle cose che volevi fare a quelle che volevano farti fare, rimane indietro, sospeso sine die, senza una particolare ragione (la mancanza di tempo è sicuramente alimentata dall’altro fenomeno descritto oggi, la legge di Parkinson, ma non è sufficiente a spiegare e rendere ammissibile una procrastinazione totale) e quello iato tra quello che avrebbe potuto essere ma che non sarà oggi, diventa architrave dell’identità, come accade ai ritardatari. Se iniziassero ad arrivare in orario non sarebbero più loro, ma d’altro canto la puntualità è sempre lì, accessibile, a portata di mano.
Si tratta di dire «no» a qualcosa, a qualcuno – con forza massima, perché arrivare a dire «ci pensiamo domani» significa che l’azione ve la potete dimenticare, cara grazia se arriviamo a pensare, domani, forse. Non sarà il massimo della soddisfazione ma può diventare una sistemazione comoda. Ti fermi a bordo strada, non vai più avanti, e nel farlo ti imbozzolisci in questa specie di immutabilità che sembra voler trovare un modo per vincere quello scorrere perenne del fiume di Eraclito e del fiume della Nueva refutaciòn del tiempo di Borges, ma non stai facendo niente di diverso da chiudere gli occhi, mentre la corrente ti sta portando via.

Però quel «no» non è un male assoluto, lo è relativamente alla postergazione degli interessi (attivi) del soggetto, ma potrebbe anche essere, come si diceva, un precedente, un sintomo utile per leggere nell’individuo una inclinazione a non accorrere di gran lena a riempire il tempo di lavoro. Gli sforzi valgono perché il tempo in cui profonderli è sempre poco – sforzarsi per riempire il tempo (per riempirlo di lavoro) è, evidentemente, una bestemmia, ma è quel che facciamo in prevalenza, specie quando entriamo in contatto gli uni con gli altri con tutti i nostri bei discorsi.
La musica, a tarda sera, dopo giornate così, riempite, farcite come tacchini da Thanksgiving¸ costa un sacco di fatica, non sapete quante volte una partitura o un esercizio finiscono alla settimana successiva, a volte più oltre, o quante volte lo studio di variazioni su un’armonia diventi una sfacchinata mentale. Eppure, se mi volto un poco indietro, nonostante lo scarso, scarsissimo tempo a disposizione, sono migliorato in modo marcato, anche rispetto a quando, ragazzino, di tempo ne avevo ben di più. È per quello che vi dico che c’è una differenza abissale tra chi si muove lentamente perché ha un po’ di zavorra addosso e chi non si muove per niente, pur essendo abbastanza libero da fardelli. Quello è, probabilmente, il male più insidioso per il procrastinatore – non muovendosi, non incorre neppure nei ritorni della serendipità, gioca il più possibile sui terreni della familiarità, ma, così facendo, attutisce e ottunde la disponibilità al nuovo, un ragionevole timore di mosse azzardate passa alla lupara bianca le speranze di cambiare, la sicurezza viene conseguita al prezzo della rimozione del progredire.
Ciò detto, la musica resta un buon serbatoio di metafore, perché quelli che non vanno a tempo e corrono, tentando di anticipare in continuazione, scambiando l’enfasi dell’interpretazione con un «accelerando» sono proprio insopportabili. Lì, non sono ammessi ritardi o anticipi oltre margini molto ristretti ma è un mondo con regole e proporzioni molto chiare, quindi le metafore lasciano, appunto, il tempo che trovano.
Un po’ di pause, ecco cosa ci vorrebbe. La pausa è parte del tessuto, non è rinviare, è stare zitti o fermi quando serve, quando è funzionale al racconto in musica. Dovrebbe valere anche nel resto della vita, ma sembra un concetto che non ha speranze di attecchire. Hanno provato a sostituirlo con idee tipo «vacanza», ma non siamo neanche vicini a quello che dovrebbe essere.
Queste giornate troppo piene.
È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.