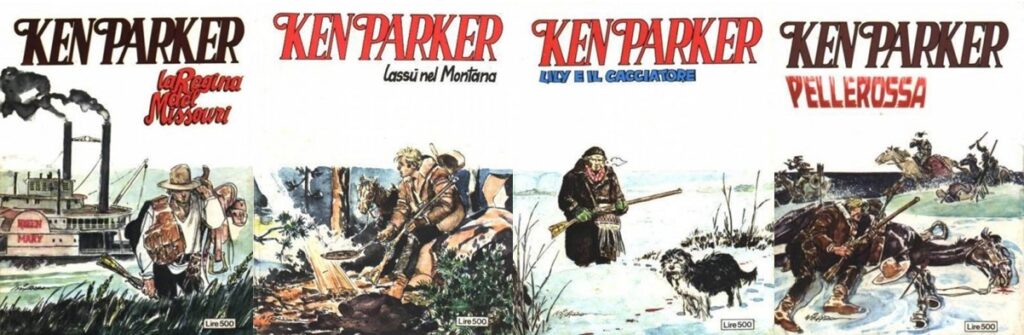Porco diavolo! Anzi, diavolo porco, come dico dai tempi del liceo. E più o meno a quegli anni dovrò tornare, ma prima come da tradizione di QUASI do uno sguardo ai dodici mesi appena volati via. Non ho certo intenzione di annoiarti con un resoconto del mio 2022, mi limito a citare due momenti. Ai primi di luglio il mio corpo mi presenta per l’ennesima volta il conto: il cuore e la schiena in particolare dicono alla mia mente, che proprio non ne vorrebbe sapere, di fermarsi. Niente più calcio per un po’, anzi forse per sempre. Queste due parole mi distruggono, mi corrodono settimana dopo settimana e, durante i Mondiali, esplodo. Non ce la faccio più, non riesco a guardare e basta. Mi dico che, appena arrivano le feste, do la disponibilità per giocare almeno una partita. Così, il secondo momento arriva proprio allo scadere: il 27 dicembre, con la schiena in fiamme ma imbottito di arnica e ibuprofene, torno in campo per una partitella tra amici, con la speranza che loro siano un po’ appesantiti dalle fette di pandoro e di panettone, dai cotechini e dalle lenticchie.
Il messaggio dell’amico che organizza il calcetto è chiaro: «Porta una maglia bianca o chiara». Io, che da quando avevo dieci anni sono un appassionato di maglie da calcio, ho l’imbarazzo della scelta, perché nell’armadio possiedo tante casacche, tra cui diverse magliette bianche o chiare con stampati sul retro i numeri e i nomi dei miei calciatori preferiti. Invece, scelgo l’anonimato: la maglia bianca da trasferta del Manchester United, stagione 2002-2003. Sai, torno a calciare dopo cinque mesi, meglio mantenere un basso profilo. La partita va benone, soprattutto se penso che l’obiettivo era “solo” uscire, al termine dell’ora di gioco, sulle mie gambe. Corro, segno un paio di gol e una volta soltanto mi sembra di svenire.
Ti dicevo del liceo. Dopo la scuola media, durante la quale i manga ambientati nel rettangolo verde come Capitan Tsubasa, Striker Jin e Hungry Heart avevano alimentato le speranze, capii che il sogno di diventare un calciatore professionista doveva restare nel cassetto e il cassetto chiuso a chiave, a mille mandate proprio. Non c’entravano gli infortuni e i problemi di salute, quelli sarebbero arrivati in seguito. No, zero alibi: ero e sono scarso. Semplicemente scarso. Inoltre, all’epoca in cui dovevo dimostrare di valere qualcosa non ne ero capace, ancora prima di indossare gli scarpini, perché io stesso mi mettevo addosso una pressione insostenibile, oltreché del tutto immotivata, che mi paralizzava. Oggi credo che sarebbe un po’ diverso. Da sette anni riesco a giocare con la mente sgombra, grazie a un lavoro psicologico che incidentalmente ha toccato anche il calcio, ma che ho fatto quando ho iniziato a stare male sul serio. Troppo tardi, però. Per amor di verità e di vanità, mi preme comunque sottolineare che so stare in campo e che me la cavo un po’ dappertutto. Purtroppo senza eccellere.

Quando frequentavo le superiori, i miei idoli erano i numeri dieci, i fantasisti, i trequartisti, le mezze punte e quei funamboli che partono dalla linea laterale per accentrarsi e disegnare traiettorie incredibili con i piedi fatati, che scagliano in rete palloni su palloni. Infatti, quando andavo agli allenamenti e giocavo con gli amici per strada e nel campetto del prete, indossavo a rotazione le maglie di Ronaldinho, Baggio, Del Piero, Totti e Ibrahimović. Le eccezioni erano rappresentate da Cristiano Ronaldo e Beckham, due numeri sette dall’evoluzione opposta nel corso della carriera: il primo si è trasformato in un bomber capace di frantumare e riscrivere ogni record, mentre il secondo si è abbassato e accentrato, trasformandosi in una saggia mezzala dal lancio illuminante. Sì, lo ammetto, a volte mettevo la maglia di Gattuso, quella blu dei Mondiali 2006, e randellavo qualche avversario, ma era proprio uno strappo alla regola in segno di riconoscenza verso il simbolo di una squadra che mi aveva regalato una delle emozioni più forti e belle della vita.
Crescendo, durante il grigiore universitario, le prime difficoltà. Di conseguenza, le partite e i tornei da centravanti, senza svariare sul fronte offensivo ma con un raggio d’azione ridotto, pochi scatti e la costante necessità di farmi trovare nel posto giusto al momento giusto. Dal numero dieci al nove, da Ronaldinho a Icardi come punto di riferimento. O il “vecchio” Luca Toni. O Fernando Torres che, poverino, era spesso ai box e doveva dosare ogni goccia di sudore per non rompersi qualcosa. La maglia nera del Niño Torres la sfoggiavo con orgoglio, appena possibile.
Come lui, mi ritrovai anch’io fermo ai box. Un anno senza pallone, solo fisioterapia e la maledetta ginnastica quotidiana, sempre sul pezzo e mai uno sgarro, per provare a tornare non dico in forma ma almeno a correre senza sentire dolore. Fortunatamente raggiunsi il mio obiettivo e mi scoprii all’improvviso piuttosto veloce. A quella epifania il mio immaginario calcistico ricominciò a mutare, per motivi puramente economici non assecondato dall’acquisto di magliette di calciatori. In ogni caso, basta trequartisti: solo giocatori veloci, saette che calpestano le corsie laterali con l’impellenza di crossare al centro per gli attaccanti o rientrare a piede invertito per calciare in porta, magari con l’ormai inflazionato tiro a giro. Un periodo d’oro. Solo in campo, però, perché poi a casa era un delirio. Tre giorni di dolore per un’ora di gioco.

Altro giro, altra corsa alle maglie, stavolta sì. Più invecchio, più arretro. Da centravanti a centrocampista, prima in fascia e poi leggermente più al centro; da centrocampista a terzino, per dare una mano al difensore centrale e ogni tanto, con un moto di orgoglio, ripartire con un’accelerazione capace di riportarmi in vita; infine, difensore centrale io stesso o ultimo, come si dice nel calcio a cinque. La vittoria dell’Italia agli Europei ha fatto sì che mi decidessi a comprare la casacca di Bonucci. Per non farmi mancare nulla, già che c’ero, ho messo nell’armadio anche quella di Van Dijk. Nella mia mente, queste scelte hanno un significato ben preciso. Leonardo e Virgil sono sì guardiani della loro porta, ma sono anche calciatori dai piedi buoni e in grado di leggere il gioco prima di tanti compagni in posizione più avanzata. Non solo disintegrano la fame di gloria degli avversari, in più con i loro tocchi raffinati accendono la luce. Brutti, sporchi e cattivi, conservano la scintilla creatrice. Per me, nel mio piccolo piccolissimo, quelle due maglie sono la metafora del mio tentativo di non arrendermi, di non far vincere il corpo sul sentimento. Più vado avanti con l’età, più arretro in campo, ma non rinuncio. Se disgraziatamente dovessi ritrovarmi a giocare in porta, lo farei con il nome e il numero di Éderson, un portiere bravissimo con i piedi. In fondo c’è un fantasista anche in Bonucci, Van Dijk e nello stesso Ederson, non solo in Ronaldinho e Totti. C’è un fantasista chiuso nel mio cassetto, che non posso più aprire. Ma non vuol dire che non possa ricordarlo.
Sognava di diventare un calciatore professionista, ma a sedici anni si è svegliato e l’incubo è cominciato. Continua ad amare il calcio tanto quanto ama leggere fumetti di tutti i tipi. Cerca di sbarcare il lunario, scrive per QUASI e Lo Spazio Bianco, parla per il podcast hipsterisminerd e per LSB Live.