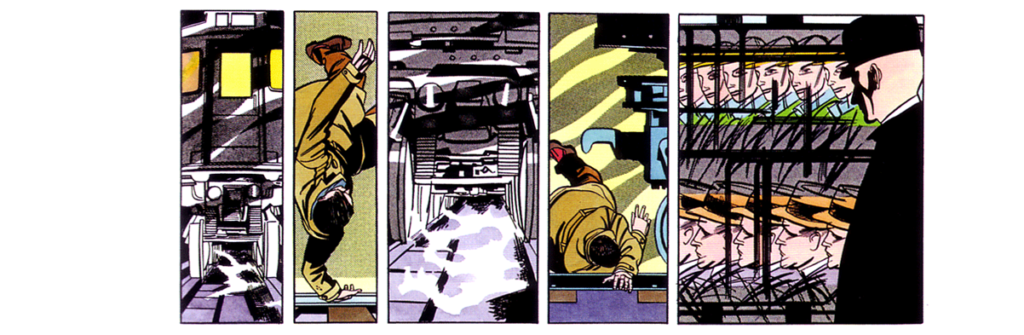Negli ultimi giorni ho visto di fila quattro film recenti di cui, per un motivo o per l’altro, si è molto discusso. Li ho trovati tutti belli, alcuni addirittura bellissimi, ma la cosa che mi ha colpito di più è stata la profonda differenza di opinioni a riguardo che ho riscontrato nelle persone che mi sono vicine o addirittura nell’opinione pubblica generale. Parlerò in breve di ognuno, giusto per mettere in luce gli aspetti che me li hanno fatti trovare importanti. Film da vedere, insomma.

Barbie (Greta Gerwig, 2023)
Qui arrivo tardi perché me l’ero perso al cinema (sono fra quelli che sono andati a vedere Oppenheimer, oltretutto rimanendone tremendamente deluso: non ho proprio capito per quale motivo Nolan abbia girato un trailer di tre ore). Comunque Barbie l’ho trovato un film godibile, non il capolavoro che viene sbandierato qua e là, ma nemmeno il contrario. Ciò che mi ha colpito sono le critiche che gli sono state mosse, soprattutto dal mondo maschile. Per me è tutto molto realistico: moltissimi uomini che conosco si comportano esattamente come i vari Ken della pellicola. Macchine, macchine grosse, commenti ossessivi sulle donne, sullo sport e poi ancora macchine e macchine grosse (cavalli no, ma son convinto che se abitassi in certe zone dell’America, anche quelli non mancherebbero). La scena notturna sulla spiaggia, con i Ken che fanno la serenata alle Barbie, cantandogli la loro lunghissima canzone, mi ha poi tirato in ballo direttamente: ho fatto una cosa del genere decine di volte. Ma non per questo mi son sentito minacciato né vilipeso. Semplicemente, quella scena fa ridere perché è vera. Magari mette in imbarazzo (è auspicabile che lo faccia) e da qualche parte, in un cubicolo scuro dell’animo chiamato orgoglio, può anche far male (e pure questo, sarebbe davvero necessario, quindi per fortuna che lo fa). Come ogni altro tipo di satira e di denuncia è necessaria, un necessario anticorpo contro le brutture della nostra specie. Ma siamo d’accordo: i Ken non sarebbero Ken se non reagissero così.

Babylon (Damien Chazelle, 2022)
Se la performance di Margot Robbie non mi ha particolarmente impressionato in Barbie, lo ha fatto invece in questa pellicola ultra-bistrattata di Damien Chazelle. Se nel film di Gerwig, l’attrice ha dato un’interpretazione nella media (che comunque, per quel che la riguarda, è sempre molto alta), qui mi pare si sia davvero superata, riuscendo a mettere da parte la sua naturale avvenenza e sensualità, in favore di una sciatteria che di quell’avvenenza e sensualità sono l’imitazione, come il personaggio che interpreta richiede. Davvero notevole. Il film poi mi ha tenuto appiccicato allo schermo per le prime due ore, deludendomi però nel finale. Peccato, perché tre quarti di pellicola sono davvero splendidi. Forse, ciò che mi ha esaltato è il fatto che Babylon non è altro che la messa in scena di Hollywood Babylonia di Kenneth Anger (anche se non ho letto nessuno in giro che nominasse quel libro parlandone), ovvero una sequela di orrori e gossip dal mondo dorato della Hollywood degli anni Trenta. Babylon cattura e mette in scena perfettamente quel mondo allucinante, estatico per chi lo viveva dall’interno e consolatorio e rassicurante per chi lo viveva da fuori, desiderando di farne parte. Il vortice di immagini, piani sequenza e montaggio serrati sulle patologie e le ansie della macchina produttiva dei sogni in celluloide è straordinario. Peccato per il finale, dove tutto viene smorzato da una sequela di banalità su quanto il cinema sia una “fabbrica dei sogni”. Se si fermava ad Anger invece che sconfinare in Spielberg (a proposito: The Fablesman con tutto il suo buonismo appiccicoso e retorico l’ho proprio detestato), sarebbe stato davvero un grande film.
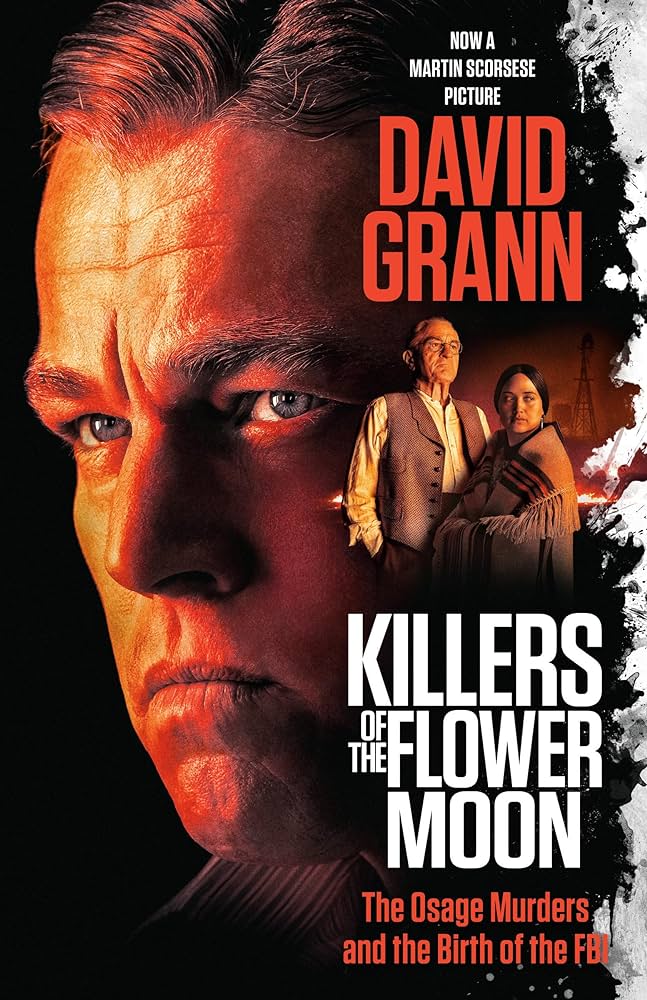
Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese, 2023)
Qui c’è davvero poco da dire. Era da almeno trent’anni (da Quei bravi ragazzi e L’età dell’innocenza) che Scorsese non faceva un film enorme come questo. Enorme in tutto, proprio. Per durata (tre ore e mezza, nota dolente forse, ma nemmeno troppo a conti fatti), per tematiche trattate, per scenografie e ambienti, per prove d’attore e in generale per come il cinema viene utilizzato. Quello che Scorsese non era mai riuscito a fare prima, era riempire di sentimento e emozione le sue storie di gangster. In The Killers of the Flowers Moon invece ci è riuscito. Forse anche per la presenza della protagonista femminile, Lily Gladstone, e per la sua interpretazione, ieratica e dolente, potentissima nei suoi sguardi e silenzi, o per il fatto che i protagonisti maschili, i “gangster”, sono veramente rappresentati come marci e meschini. Schifosi. È inutile, in film come Quei bravi ragazzi o Casinò, per quanto i personaggi di Robert De Niro e Joe Pesci siano effettivamente negativi, viene difficile non rimanerne affascinati. Pur sapendo che loro sono i “cattivi” e che fanno cose sbagliate, il carisma di quegli attori e il modo in cui sono stati scritti, non può che farteli amare e, alla fine, parteggiare per loro. La stessa cosa che succede con Il Padrino (a proposito: il modo in cui Il Padrino viene citato in Barbie è davvero da applausi a scena aperta), dove, pur deprecando le azioni di Al Pacino-Michael Corleone, alla fine si fa il tifo per lui. Qui invece è tutto diverso, finalmente. Il William “King” Hale interpretato da De Niro è proprio un figlio di puttana e basta, oltretutto orrendamente cattolico, di quel cattolicesimo marcio e paraculo che non ammette appello. E l’Ernest Burkhart di Leonardo Di Caprio, qui forse davvero nel ruolo più incredibile della sua carriera, è semplicemente un inetto. Non è un cattivo spietato ma buffo come in Django, non è una “simpatica canaglia” come in The Wolf of Wall Street (e anche lì’, per quanto quel film mi sia piaciuto, non ho mai sopportato il fatto che renda un eroe quello che è invece un criminale a tutti gli effetti, e della peggior specie) e non è nemmeno l’eroe indefesso di Gangs of New York o The Departed. Qui Di Caprio è un personaggio davvero complesso, fuori dagli schemi di ogni altro film hollywoodiano, e non si riesce mai a capire fino in fondo se sa quel che sta facendo, fingendo di non saperlo, o se davvero non si renda conto. Il confronto finale con Lilly Gladstone nelle aule di tribunale è davvero da urlo, tutto affidato ai loro volti più che alle parole. E gli ultimi venti minuti di film, con la ricostruzione di un programma radiofonico dal vivo dell’America degli anni Cinquanta, sono ancora più incredibili. Scorsese, dopo tre ore di scene lente e potenti, scandite da una colonna sonora quasi continua, tutta fatta di canzoni country-blues e canti dei Nativi (messa insieme da Robbie Robertson, scomparso prima che il film uscisse in sala, e a cui è dedicato) crea un finale anticlimatico, che riesce però a far esplodere tutta l’emozione, la rabbia e il dolore, che durante il resto del film si era accumulata. E la sua apparizione in camera, mentre legge una sorta di elegia per Mollie Kyle, alla fine strappa le lacrime.

Il ragazzo e l’airone (Hayao Miyazaki, 2023)
E voi come vivrete?, lo sappiamo, è questo il vero titolo dell’ultimo film di Hayao Miyazaki. Uno dei film più visti nei cinema italiani degli ultimi tempi e in contemporanea uno dei più criticati: «non si capisce niente», dice la maggior parte degli spettatori. È vero, non posso dire altrimenti: non si capisce niente. Ma, e mi perdoneranno i razionalisti più indefessi, allo stesso tempo si intuisce tutto (ma proprio tutto, eh). Il ragazzo e l’airone, insieme a Killers of the Flowers Moon, credo davvero sia fra i migliori film realizzati lo scorso anno e non solo. Questo di Miyazaki in particolare, per me, è in vetta. E per quanto riguarda il “senso” tanto ricercato nella sua trama, basterà riprendere in mano la raccolta delle fiabe italiane di Italo Calvino, o qualsiasi altra raccolta di fiabe della tradizione orale, da Perrault ai Grimm, per rendersi conto che Il ragazzo e l’airone parla lo stesso linguaggio. «È fatto di simboli», dice chi lo difende a spada tratta. Si, è vero, è fatto di simboli, ma ancora di più, è fatto come una fiaba. Quindi non solo di simboli, nel senso di un sistema preciso di corrispondenze comprensibile a chi ne ha dimestichezza (come magari potrebbe essere la simbologia della filosofia buddhista o zen), ma di assonanze tra i simboli. Assonanze e simboli che non rimandano a nessun sistema particolare, ma che ne coinvolgono molti diversi, anche arbitrari o scaturiti dall’onirico. Il linguaggio delle assonanze, delle filastrocche e delle storie senza direzione obbligata (prima che “Il viaggio dell’eroe” appiattisse tutto) è assimilabile a quello onirico, certo, ma non per questo è incomprensibile o per forza metaforico.
Come scrive benissimo Heinrich Zimmer nel suo saggio su fiabe e leggende, pubblicato nel 1957, Il re e il cadavere: «Il metodo – o piuttosto l’abitudine – di ridurre ciò che non ci è familiare a ciò che ci è ben noto è una vecchia, vecchissima strada che conduce alla frustrazione intellettuale. Il risultato è il dogmatismo sterilizzante, avviluppato strettamente all’autocompiacimento mentale, nella bolsa convinzione della propria superiorità. Tutte le volte che rifiutiamo di lasciarci sbilanciare (con le buone o con le cattive) da una nuova concezione rivelatrice rimbalzata dall’urto con un simbolo senza tempo fuori dalle profondità della nostra immaginazione, ci defraudiamo del frutto di un incontro con la saggezza dei millenni (…). È perché sono vive, perché possono risuscitare e avere una grande efficacia nell’ambito del destino umano – sempre rinnovata, imprevedibile eppure coerente – che le immagini del folklore e del mito resistono a tutti i nostri tentativi di sistematizzazione».
Affermare con rabbia che ne Il ragazzo e l’airone «non si capisce niente», è precisamente questo: una reazione frustrata a un tentativo di sistematizzazione fallito. Abbandonando invece la percezione all’«urto» delle sue immagini simboliche con la nostra coscienza, probabilmente se ne ricaverebbe un gran giovamento (quello almeno è ciò che ne ho ricavato io). Myazaki ha fatto un film fuori tempo, assolutamente non in senso nostalgico, ma fuori tempo rispetto alla modalità più in voga oggi di sistematizzazione e decrittazione di tutto ciò che vediamo secondo l’unica lente del razionale, bandendo dalla coscienza l’altra incredibile capacità esplorativa che abbiamo: l’intuito. Le fiabe parlano direttamente a quello e con quel linguaggio esprimono i loro simboli.
E voi come vivrete?, ci chiede allora Myazaki: vivrete in un mondo unicamente materialistico e razionale, o in un mondo che sa sposare l’incredibile ingegno scientifico umano con il suo straordinario intuito immaginativo? Il ragazzo e l’airone, ancor più che tutti gli altri suoi film, è scritto come una fiaba. E tanto dovrebbe bastarci per “capirlo” e goderne.
Scrive fumetti e scrive di fumetti, poi scrive anche canzoni e le canta, insieme a quelle degli altri che gli piacciono. Il suo sito è www.francescopelosi.it.