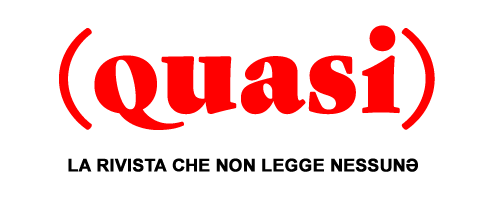Nelle puntate precedenti abbiamo visto, prima attraverso l’uso dei tempi narrativi e l’approccio alla magia, poi attraverso il confronto con la situazione coloniale, quanto Una Ballata del Mare Salato di Hugo Pratt e Argonauti del Pacifico Occidentale di Bronislaw Malinowski siano entrambi opere che si confrontano con l’incanto: ma che cos’è questo incanto?
Troppo abituati a utilizzare logica, verità e ragione, abbiamo perso cognizione di quanto invece siano fondamentali l’analogia, le credenze e la fede. Non fraintendetemi, i primi sono strumenti validissimi ma ci sono situazioni nella vita in cui questi smettono di funzionare: in guerra, di fronte a una malattia incurabile, sotto tortura o quando si seguono le esternazioni di Salvini – sono serio, non è una battuta!
In queste occasioni analogia, logica e fede diventano le uniche risorse per crearci, per “inventarci” dice Stefania Consigliere, una stabilità dentro un orizzonte senza garanzie. Questo è l’incanto. È talmente fondamentale che non possiamo farne a meno in quanto esseri umani. Impariamo a camminare muovendoci come fanno i grandi, lanciandoci nel vuoto credendo di poter fare come gli altri, fidandoci che qualcuno ci prenderà.

Persino Malinowski, impegnato nel disincantare il mondo dei trobriandesi, non può fare a meno di utilizzare l’analogia. Paragona i vaygu’a, gli oggetti che muovevano lo scambio kula da lui analizzato, coi gioielli della corona inglese. L’analogia però non è somiglianza una tra cose simili ma una somiglianza tra rapporti. Quindi il suo discorso è: come i gioielli della corona hanno un valore in quanto testimoni di una storia, quella dei regnanti che li hanno indossati, così i vaygu’a acquistano valore in quanto esito della storia di scambi a cui sono sottoposti. Ma questa analogia, nata con l’obiettivo di spiegare i comportamenti dei nativi, come tutte le analogie fa breccia anche al contrario: rivela quanto il valore di entrambi gli artefatti sia una costruzione e, quindi, quanto l’idea stessa di una superiorità occidentale sia traballante. È questo tipo di analogie a scatenare un’onda lunga che, senza negare il legame tra sapere e potere che l’antropologia intrattiene con il colonialismo, la porterà comunque ad essere la disciplina più pronta a criticarlo.
Perché la capacità più dirompente dell’incanto è proprio quella di immaginare un’alternativa di fronte a una situazione senza via d’uscita. Nel 1967, anno di pubblicazione di Una Ballata del Mare Salato, il premio Strega incorona Poveri ma Semplici di Anna Maria Ortese. È una storia d’amore immersa in un’atmosfera bohemien nella Milano degli anni successivi alla Liberazione. Se pochissimi tra i lettori di queste righe si ricordano o hanno mai sentito nominare Bettina, la protagonista del romanzo, e invece tutti sanno chi è Corto Maltese, che della Ballata non è nemmeno l’eroe, un motivo ci sarà. È l’appartenenza della Ballata a quella che Valerio Evangelisti ha chiamato paraletteratura a segnare la differenza – e per inciso: oggi più di ieri i fumetti sono una fetta fondamentale della paraletteratura che si consuma in questo paese.
Le opere culturalmente più “basse” cercano una presa diversa, sono costrette a confrontarsi con archetipi e tematiche di più ampio respiro. Pratt mette nel mirino direttamente colonialismo e guerra, non so se mi spiego: questo confronto col conflitto reale già sposta l’asse. Innesta un elemento sovversivo, refrattario, irriducibile al potere: è la possibilità stessa che tali narrazioni hanno di esplorare mondi alternativi a renderle meno addomesticabili. In parte è la naturale vocazione al coinvolgimento del lettore, che essendo perseguita a partire da un’opera di straniamento verso ciò che vive, gli regala una visione prospettica del reale. Necessariamente altra. E quel rifugio immaginario, lungi dall’essere solo un ripiego, attraverso il moto di deriva della narrazione gli permette di giungere ai limiti estremi di rottura della realtà anche quando quella realtà, in quel momento, non può essere cambiata.
La possibilità di un’alternativa, di un Altrove appunto, è ciò che rende grandi queste narrazioni, anche e soprattutto al di là delle intenzioni e dei rimossi degli stessi autori. La fondamentale adesione di Malinowski all’idea di un mondo diviso in razze o la fascinazione giovanile di Pratt per il fascismo non scalfiscono l’apertura al molteplice insita nelle loro opere. Beninteso, razzismo e fascismo sono pieni di incanto e testimoniano di quanto possa essere pericoloso l’incantamento quando è usato per mantenere il potere: soprattutto se confondiamo un unico incanto con tutti i mondi possibili di cui siamo capaci come esseri umani.

Cionondimeno Malinowski e Pratt covano in entrambe le opere un movimento involontario ma destinato a disinnescare le pretese totalizzanti di un dogma in favore di una complessità liberante. Tra le righe e le vignette di queste opere, anche dove ci siano germogli di fascinazione, o peggio di fascistizzazione, questi si danno già coi loro contrari: inestricabili come la zizzania evangelica.
Qui, come in altri casi, l’apertura al molteplice è la garanzia che siamo di fronte a “roba buona”.

è scrittore di mezza tacca, disegnatore a tempo perso e suonatore di citofoni (in cui fa le pernacchie prima di scappare) ma nella sua carriera vanta anche esperienze teatrali e cinematografiche poco riuscite, alcune brevi incursioni nel mimo e nel porno ne fanno un artista completo.
In preda ad una crisi di mezza età, senza i soldi per comprarsi la spider e troppo apatico per intraprendere la classica relazione con una ventenne, sceglie di prendersi una laurea in antropologia. Ma siccome a lezione si annoia infila le graphic novel dentro le sovracopertine dei libri di testo e alla fine, facendo confusione tra gli argomenti delle lezioni e quello che legge, inizia a scrivere cose strane che ancor più stranamente vengono pubblicate.