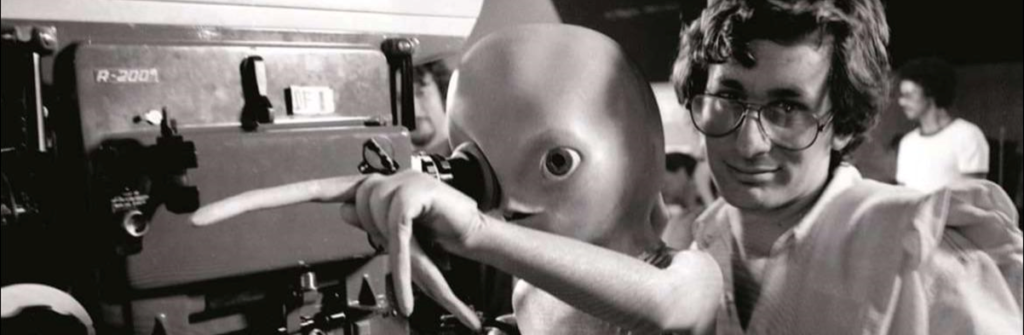I robot esistono per un motivo: obbedire, servire, eseguire ordini. Eppure, eccola lì, Roz. Un ammasso di circuiti schiantati su un’isola deserta, circondata solo da bestie selvatiche e alberi, e senza nessun ordine a cui obbedire. Eppure, in quel vuoto, qualcosa in lei si inceppa.
Il Robot Selvaggio diventa così una nuova versione del mito del bambino selvaggio, che come un moderno Tarzan, è un essere senziente che scopre il mondo in assenza di modelli umani, imparando dai ritmi e dalle leggi dell’ecosistema in cui si trova. Ma a differenza di Tarzan, che alla fine viene plasmato (e in parte traviato) dalle aspettative della società, Roz si evolve in una direzione nuova e più armoniosa. Il robot è una “creatura civilizzata” — una macchina costruita con scopi utilitaristici — che viene gettata in un contesto naturale dove non serve a nessuno, tranne a ciò che riesce a dare come individuo. Non cerca di civilizzare – o sottomettere – il mondo intorno a sé, anzi, si lascia “civilizzare” da esso.

E così nel mezzo del nulla, senza nessuno a cui obbedire, Roz diventa “Persona”. Nel senso che scopre che il suo scopo può essere altro, può essere chi vuole, senza permessi, senza comandi. Un soggetto autonomo, capace di imparare a scegliere. E quella scelta — quella scintilla che non avrebbe mai dovuto avere — è l’unica cosa che gli fa scoprire cosa significa essere davvero liberi.
Quindi, lontana da ogni costrizione, Roz sceglie di essere il genitore di un pulcino d’anatra. E senza alcuna base, senza nessun programma di istruzione parentale, scopre cosa significa prendersi cura di un essere vivente. Ma in fondo, non è forse quello che deve affrontare ogni neogenitore?

Così, nel gesto stesso di prendersi cura del piccolo anatroccolo, Roz ci mostra una via di progresso che non ha nulla a che vedere con lo sfruttamento, nulla a che fare con il profitto o con l’ego umano. Una alterità che ci dimostra quanto possa essere fragile la linea tra ciò che è umano e ciò che non lo è.
L’umanità, dunque, non è una questione di carne e ossa, ma di connessione. Questo concetto trova un forte parallelismo nella filosofia Ubuntu dell’Africa sub-sahariana (nome che, non a caso, è stato dato anche a una popolare distribuzione Linux): «Essere umani significa affermare la propria umanità riconoscendo l’umanità degli altri e, su questa base, stabilire con loro relazioni umane rispettose». È proprio ciò che Roz scopre nel suo percorso: il valore di un individuo si definisce attraverso le relazioni che stabilisce nella comunità. Una visione che si discosta profondamente dal pensiero occidentale, dove l’individuo viene concepito come entità autonoma e preesistente, un’unità che esiste prima e indipendentemente dalla società che lo circonda.
Così Roz non è soltanto un robot, ma una sfida esistenziale, un sogno utopico che si nutre di anarchia. È l’applicazione di quanto teorizzato da Gregory Bateson – il pioniere del pensiero ecologico evolutivo e il fondatore di una cibernetica applicata alle scienze umane – per cui la conoscenza nasce dalla differenza.

Alla fine, proprio nel suo essere “non umana”, Roz diventa il ritratto di un’umanità che si allontana dai tradizionali canoni occidentali. A definirla non è la sua struttura di metallo e circuiti, ma le sue scelte, il bisogno di connessione e la capacità di prendersi cura di chi le sta intorno. Il Robot Selvaggio ci porta a chiederci cosa significhi davvero essere umani, suggerendo che l’umanità non è questione di carne e sangue, ma di empatia, legami e volontà di costruire insieme. È un invito a scoprire l’umano anche in ciò che ci appare diverso, a vedere nella diversità una fonte di crescita e arricchimento per tutti.
«Umuntu ngumuntu ngabantu», «Io sono ciò che sono in virtù di ciò che tutti siamo».
Laureato in archeologia del Vicino Oriente Antico alla Sapienza Università di Roma. Ha collaborato con diverse missioni archeologiche in Italia e all’estero (Siria e Turchia). Da sempre appassionato di fumetti, ormai quarantenne, decide di studiare sceneggiatura presso la Scuola di Fumetto Online di ComicOut. Ha all’attivo, nella veste di sceneggiatore, collaborazioni con diverse realtà editoriali, tra cui il settimanale Internazionale. Con Alessio Lo Manto crea i personaggi dellɜ archeologɜ Isa e Melano. I due appaiono prima su un breve articolo a fumetti per la rivista “Ex-NOVO Journal of Archaeology”, poi in alcune vignette per la Confederazione Italiana Archeologi e infine nel Graphic Novel «Diario di Scavo. Considerazioni finali» (Oblò-APS, 2021).
Moglie e figlɜ permettendo, continua a scrivere fumetti.