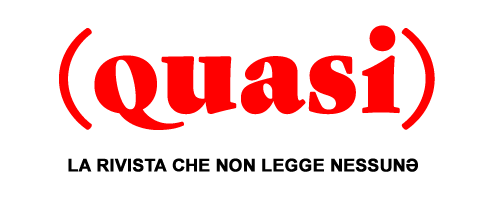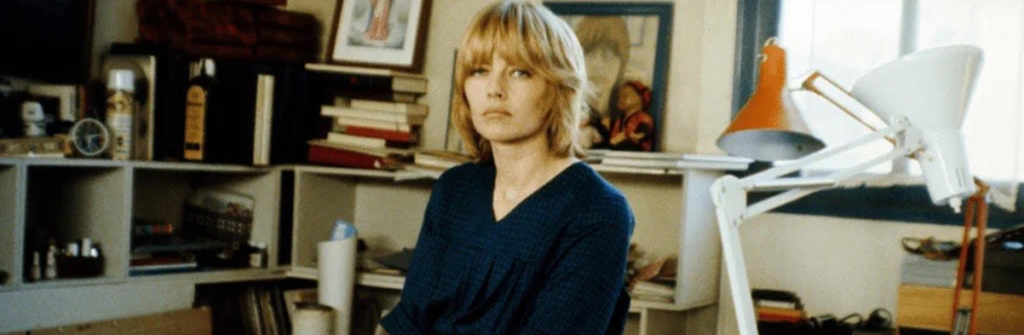Capitolo sesto – Le scarpe con cui presero Roma
Capitolo sesto di dodici. Dove ti racconto che scarpe avevano i soldati che presero Roma il 4 giugno del 1944, e perché Pietro Germi cominciò a girare commedie e Mario Monicelli smise di fare film con Totò.
Scartato alla leva del jet-set,
non piango ma compro le Clark’s
Francesco Guccini – Via Paolo Fabbri 43
In seguito all’offensiva dell’operazione Diadem, meglio nota come quarta battaglia di Montecassino, condotta dagli alleati tra l’11 e il 17 maggio del 1944, i tedeschi dovettero abbandonare la linea Gustav e ripiegare di 16 kilometri. Nel giro di una manciata di giorni, il 23 maggio, la 10° Armata della Wehrmacht fu nuovamente costretta a ritirarsi verso nordovest dalla fanteria canadese. Invece di tagliare la strada alla ritirata tedesca, la 5° Armata statunitense deviò verso Roma. In questo modo il feldmaresciallo Albert Kesserling riuscì ad attestare la sua armata, senza perdite, sulla linea Gotica, dove i tedeschi resistettero fino al 21 aprile 1945.
La guerra sarebbe durata praticamente ancora un anno, ma il 4 giugno 1944 la 5° Armata americana entrava trionfante nella capitale abbandonata dai tedeschi. Quel giorno Mario Monicelli si trova in via Barberini – poi ti dico come ci è arrivato – insieme a un suo amico giornalista e a un venditore ambulante. Fanno parte di una pattuglia di partigiani comandata dall’anarchico Comunardo Braccialarghe. Il CLN ha dato ordine che Roma, anche se è la capitale europea in cui la resistenza, per stessa ammissione di Kesserling, ha dato più filo da torcere alla Wehrmacht, non insorga. Quindi, da quando i nazisti hanno cominciato ad abbandonare la città, loro aspettano. Le ore passano. Poi, racconta Monicelli, cominciarono a sentire uno strano fruscio che arrivava da Termini. Quel fruscio, la cui intensità aumentava di minuto in minuto, era la camminata dei soldati della 5° Armata. Sfilarono davanti ai loro occhi e non finivano mai. Da mezzanotte alle due. E cavolo, dice Monicelli (in quel libro conversazione che già ti ho detto bellissimo: La commedia umana), quel fruscio che non dimenticheranno mai era il passo degli americani che calzavano le Clark’s. Ecco, ti ho già detto che Monicelli raccontava balle. Questa è una. I soldati della quinta armata non portavano le Clark’s, per il semplice motivo che quelle desert boot che sono praticamente le uniche scarpe che metto, Nathan Clark le presenta – contro il parere dei parenti ai vertici dell’azienda di famiglia fondata dal bisnonno James nel 1825 – alla Chicago Shoe Fair nel 1949 ed è solo l’anno dopo, quando Oscar Schoeffler editor di “Esquire” gli dedica un servizio sulla rivista, che diventano il prodotto iconico che tutti conosciamo. Nathan si era ispirato a delle scarpe militari, ma erano le polacchine che portavano le truppe coloniali inglesi in Africa settentrionale e che erano prodotte da un calzaturificio del Cairo. Non erano certo le calzature che portavano ai piedi i soldati della 5° armata nel fango di Cassino: quelli erano stivali alla caviglia, scamosciati ma protetti dalle ghette e di sicuro, con la loro suola a carro armato, sul pavè romano non frusciavano ma, più probabilmente, rimbombavano. L’unico Clark a entrare a Roma, alla testa e non ai piedi della 5° Armata, fu il generale Mark Wine Clark!

Comunque, al di là del fatto che stesse raccontando una frottola divertente o che non sapesse nulla della storia di quel modello di scarpe e le citasse per sentito dire, probabilmente le Clark’s Monicelli non le ha mai portate (e comunque è sintomatico che nello scontro televisivo arbitrato da Alberto Arbasino nel 1977 – si chiamava proprio Match – tra lui e Nanni Moretti le desert boot le calza il giovanissimo regista di Io sono un autarchico). Ma di che scarpe amasse portare Monicelli, non ci importa nulla. Il punto rilevante è che quando gli americani entrano a Roma, Monicelli era reduce dall’occupazione della Jugoslavia e da una lunga e anomala (così l’ha definita Callisto Cosulich) gavetta cinematografica.
Subito dopo l’esperienza come «assistente degli assistenti» sul set di Ballerine, Monicelli si trasferisce a Roma da solo, mentre la famiglia – terminata la parentesi milanese- si era trasferita nuovamente a Viareggio. Sono tempi in cui, soprattutto per effetto della politica propagandistica del regime, il cinema è molto considerato. Ma sono davvero pochi quelli che lo fanno. Se appena appena eri stato su un set, venivi ritenuto un esperto professionista.
Per questo Augusto Genina lo chiama come assistente per Lo Squadrone bianco. Si tratta di stare due mesi nel deserto libico, a settecento kilometri da Tripoli, circondati da arabi non proprio simpatizzanti nei confronti dei colonizzatori italiani. Monicelli ha poco più di vent’anni, quella per lui è un’avventura eccitante. Ma soprattutto formativa. Assistendo Genina, scopre che il regista non è necessariamente quella figura istrionica, umorale e impositiva che aveva conosciuto lavorando con Machaty, ma che può essere una persona umile, gentile, propositiva, capace di rispetto e empatia verso gli attori. Tempo dopo, quando vedrà i due film in sala, a poca distanza l’uno dall’altro, si renderà conto di come al supposto talento manifestato con arroganza non corrispondano necessariamente dei prodotti di qualità. Ballerine è un film mediocrissimo, mentre Lo squadrone bianco, al netto del suo carico ideologico, un film solido e ben girato.
L’anno dopo, per lo stesso motivo di Genina, Ermete Zacconi attore viareggino amico di famiglia, gli chiede di dirigere un film. A muovere Zacconi non era l’amore per il cinema in sé o per una storia in particolare, ma gli effetti di una strana legge fascista per la quale per ogni film italiano prodotto venivano elargiti i buoni per il doppiaggio di due film americani. A fronte di un risibile investimento per un lungometraggio diretto da un giovane e girato nella propria villa di Viareggio, il ritorno per il doppiaggio due film hollywoodiani era una cifra considerevole.
Così, nel 1937 – usando lo pseudonimo di Michele Badiek – Monicelli firma la sua prima regia. Di Pioggia d’Estate, lo dice lui stesso: per fortuna si sono perse tutte le copie.
Possiamo dire che proprio da questo moemnto comincia la sua vera carriera cinematografica. In questo periodo che va dal 1937 al luglio del ’43 e che potremmo definire come il “periodo fascista”, collabora come aiuto regista e sceneggiatore ad almeno 8 film. Ti dico subito che nessuno di essi merita qui menzione, tranne La donna è mobile di Mario Mattoli del 1942. Mica perché ti voglia convincere a vederlo, per carità: è robaccia inguardabile nonostante – o forse proprio a causa – del fatto che il soggeto sia di Marcello Marchesi (un autore che, a mio avviso, come quell’altro… coso… Ennio Flaiano, meriterebbe una sostanziale rivalutazione in senso svalutativo). Quindi, a meno che tu debba scrivere un’inutile tesi universitaria su Mattoli (da pubblicare magari poi nella noiosissima collana verde di saggi Marsilio) puoi evitarlo. No, il film è importante perché lavorando alla sceneggiatura Monicelli conosce e si lega di amicizia con – lui sì, un gigante – Stefano Vanzina, in arte Steno (anche se Steno firmerà solo il soggetto con Marchesi). Ne nascerà un sodalizio fondamentale per il cinema italiano, in particolare la commedia, dei primi dieci anni del dopoguerra. Dal 1949 al 1954 realizzeranno in tandem almeno quattro film di Totò e svariate commedie.
Ma torniamo all’inizio degli anni Quaranta. Tra un film e l’altro succede, purtroppo, che il 10 giugno 1940 l’Italia entri in guerra. Il 6 aprile del 1941 le forze dell’Asse invadono la Jugoslavia. Monicelli, arruolato tra i carristi, viene mandato a Zagabria. Poi, quando la guerra in Africa sta cominciando a volgere al peggio, viene richiamato a Napoli, dove tutti i mezzi corazzati dovrebbero imbarcarsi per la Libia come rinforzi contro l’avvanzata britannica.
Nel novembre del 1942 Erwin Rommel ha subito la seconda decisiva sconfitta a El Alamein. La resa dell’Asse in Africa è vicina. Avverrà nel maggio del 1943. Arrivare in Libia per un italiano, e arrendrsi agli alleati vorrebe dire aver finalmente finito di combattere. Poi dicono che nei campi di prigionia gli inglesi ti trattano bene, non è vero ma lo dicono, e ci si crede. Solo che il Mediterraneo è in mano alla flotta inglese. Imbarcarsi vorrebbe dire finire affondati e morire annegati. Monicelli si dà da fare per ritardare il più possibile la sua partenza. Lui racconta rendendosi indispensabile come magazziniere, le malelingue che spesso ci azzeccano, dicono invece che facesse la spia denunciando le reclute che di notte tornavano a dormire a casa.
Comunque sia, a incasinare ancora di più le cose arrivano il 25 luglio e l’8 settembre. Monicelli butta la divisa, infila abiti civili e lascia Napoli per tornare, a piedi a Roma. Qui ovviamente deve vivere in clandestinità. Tutto il mondo cinematografico romano si è dato alla macchia, i grandi registi come De Sica, Blasetti, Genina, o le grandi attrici e i grandi attori come Clara Calamai e Gino Cervi vivono al sicuro, in attesa di tempi più propizi. Se Monicelli fosse stato beccato, come disertore, finiva a combattere per la Repubblica di Salò, o peggio ancora – date le sue competenze cinematografiche – a Venezia a girare i film di Luisa Ferida e Osvaldo Valenti.

Così, mentre è in clandestinità, viene contattato da un gruppo di gappisti e aderisce alla Resistenza. Niente azioni di guerriglia ma compiti di poco conto, come trasportare messaggi o pacchi di stampa clandestina, comunque non privi di rischi e pericolo. Nel momento che i tedeschi lasciano la città ricevono l’ordine di attendere. Quando arrivano gli americani, loro sono ancora lì che aspettano, dove li abbiamo incontrati all’inizio del capitolo.
Tra il 1944 e il 1946 il cinema italiano è un cumulo di rovine. Cinecittà, che durante l’occupazione nazista era diventata un campo di prigionia, adesso è un campo per i profughi e gli sfollati. La pellicola scarseggia e non si trova nemmeno al mercato nero. Lo stesso giorno dell’entrta a Roma della 5° Armata, nelle strutture del Ministero della Cultura Popolare si era insediata la Psychological Warfare Branch, una divisione amministrativa che aveva il compito di assumere il controllo dei media italiani: stampa, radio, cinema. Tutti i film italiani già distribuiti o ancora in produzione, furono sequestrati. Questa situazione durò praticamente fino al primo gennaio 1946.
In mezzo a un tale disastro, Mario riceve da suo zio Arnoldo Mondadori una proposta allettante. Il periodico “I libri gialli” è in fase di ristrutturazione, dal 1946 diventerà “I Gialli Mondadori” e Arnoldo ha bisogno di qualcuno che lo diriga. Probabilmente lo avrebbe fatto Giorgio Monicelli, che era subentrato all’Anonima Periodici nel ruolo di Cesare Civita, ma come ex-combattente delle Brigate Garibaldi, il CLN lo aveva nominato questore di Varese e tornerà a tempo pieno all’editoria solo nel 1949 fondando e dirigendo la collana mondadoriana “Medusa”. Così Arnoldo si era rivolto a Mario, che dato lo stato di Cinecittà non aveva nulla da fare e stava quasi per accettare.
Ma succedono due cose. Roberto Rossellini, tra mille difficoltà, gira Roma città aperta dimostando soprattutto che si possono fare film anche senza teatri di posa, e ridando vita al cinema italiano. E Alessandro Blasetti proprio nel 1946 chiede a Mario di assistere Pietro Germi per il suo primo film. Queste due cose riaccendono in Monicelli l’antica passione. E poi beh… Quello che succede dopo te l’ho già raccontato!
Sul set di Il testimone nasce una grande amicizia. Monicelli collabora, in qualità di sceneggiatore, ad altri due film diretti da Germi: Gioventù perduta del 1947 e In nome della legge del 1949. Quando le loro strade professionali si separano – il severo impegno di Germi era una cifra stilistica in cui il cinico e dissacratorio Monicelli si trovava un po’ stretto – l’amicizia perdura. Al punto che, quando nel 1965 Germi perde la moglie e cade in una grave depressione chiede proprio a Monicelli di sostituirlo e girare lui Signore e signori. Monicelli gli rispose: «Ma cosa vuoi che sia una moglie morta? Un mese e il dolore passa. Questo film è tuo e lo devi fare tu!» E per quanto possa suonare appunto cinico, Monicelli aveva ragione. Germi lo girò e ne fece un grande film, che con le altre due commedie Divorzio all’italiana e Sedotta e abbandonata, forma una trilogia perfetta. Già, ma come mai l’impegnatissimo Germi era passato alla commedia?
A questo punto devo raccontarti un episodio rivelatore (come il cuore).
Siamo nella seconda metà degli anni Cinquanta. A un tavolo nel dehors della caffetteria Rosati, in Piazza del Popolo, sono seduti Monicelli, Alfredo Bini, Pietro Germi e Federico Fellini. Discutono della possibilità di unirsi per creare una società di produzione. A un certo punto Monicelli – scherzando, ma forse neanche tanto – dice a Germi: «Però tu devi piantarla di fare quei film terrificanti, con Raf Vallone inquadrato dal basso e tutte quelle donne vestite di nero. Altrimenti ci mandi in fallimento.» «Solo se tu la smetti di fare quelle stronzate con Totò!» In un lampo la discussione trascende in rissa. Pugni sul tavolo e male parole. Poi Germi si alza rovesciando la sedia e si allontana per Piazza del popolo continuando a lanciare improperi in direzione di Monicelli. Non preoccuparti, restarono amici. Però c’è da notare una cosa: Germi cominciò a girare commedie (e realizzò tre capolavori consecutivi), Monicelli chiuse con i film di Totò (nel 1955 gira Totò e Carolina – film comunque atipico nella filmografia del comico napoletano – e poi basta: intendiamoci, basta film DI Totò, che con il Principe De Curtis, a parte il cameo dei Soliti Ignoti, Monicelli lavorerà ancora in Risate di gioia ) e nel 1958 realizzo quel gioiello assoluto che è I soliti Ignoti.
Bene, finalmente ci siamo. Terminato il poco riuscito Alfredo Alfredo, Germi si mette al lavoro su un progetto che cova da tempo e al quale è molto affezionato. Come ti ho detto nel capitolo precedente, nell’autunno del 1974 scopre che – a causa di cirrosi epatica da cui è affetto da tempo – non gli resta molto da vivere. Il nuovo progetto è in fase avanzata di lavorazione, così chiede all’amico di sempre di portarlo a termine al posto suo. Monicelli questa volta non può e non vuole dir di no. Chiede a Germi solo una cosa: il permesso di spostare l’ambientazione del film da Bologna, dove l’aveva pensata Germi, a Firenze. Germi accetta senza riserve. Non riesce a partecipare ai sopralluoghi, ma non perde un provino per la scelta degli attori e dà, al proposito, indicazioni precise (fu lui, per esempio, a volere fortemente Duilio Del Prete per la parte del Necchi). Per la fine di novembre tutto è pronto. Il 4 dicembre la troupe parte per Firenze, le riprese devono cominciare il 5. Rimasto solo, Pietro si spegne. Tre mesi prima aveva compiuto sessant’anni.

Non fa un cazzo da anni, ma è invecchiato lo stesso. Vive a Milano, e non potrebbe farlo in nessun’altra città italiana. Legge e parla di fumetti dal 1972 (anno in cui ancora non sapeva leggere). Ha una cattiva reputazione, ma non per merito suo. Ama e praticava la boxe, poi si è rotto. Beve tanto in compagnia di gente poco raccomandabile, tipo Paolo con il quale – per colpa di una di quelle bevute – si è ritrovato a curare QUASI.