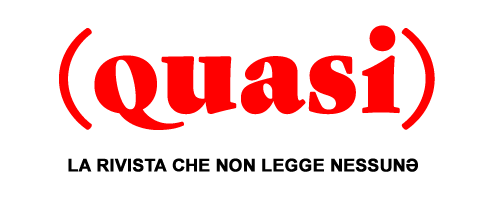La parafrasi del tempo
«Nella narrativa di consumo c’è qualcosa che, dal punto di vista artistico è ammirevole ma raro come i denti di una gallina: lo scrittore che può costruire trame con un’inventiva forsennata e, al contempo, creare personaggi che suscitano l’interesse del lettore. Detta diversamente, lo scrittore capace di trasformare la narrativa di consumo in un manufatto prezioso che costringe il lettore a non smettere di voltare pagina e, allo stesso tempo, rappresenta un lavoro notevole dal punto di vista letterario.
Erle Stanley Gardner sapeva scrivere trame intricate e perfette, ma i suoi personaggi erano di cartapesta. John D. MacDonald poteva mettere in pagina gente reale ma scriveva trame a dir poco casuali. Ira Levin è l’orologiaio svizzero del racconto di suspense e fa sembrare il lavoro di tutti noi altri orologi da bancarella. È anche vero che scrive un romanzo ogni sette anni, ma sono tutti libri perfetti. Come un orologio svizzero, ogni romanzo è realizzato con precisione, con un’incredibile attenzione ai dettagli e con una trama infallibile che lascia la storia scorrere con un perfetto ticchettio fino in fondo.»
In Danse Macabre, Stephen King, da sempre affascinato dagli scrittori prolifici, spende parole belle e inattese per un romanziere lentissimo. Certo, rimarca la scarsa produttività di quel pelandrone di Ira Levin, ma gliela perdona in virtù della sublime perfezione dei suoi romanzi. Benché abbia scritto il suo primo libro appena ventiduenne, Levin ha distribuito nei suoi quasi ottant’anni di vita una produzione letteraria composta da una decina di testi teatrali, un paio di racconti e appena sette romanzi.
Nel 1976, quarantasettenne e a trentun anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, pubblica I ragazzi venuti dal Brasile, il suo quinto romanzo a orologeria.

Yakov Liebermann, un cacciatore di nazisti, riceve una telefonata da un giovane in Brasile che sostiene di aver registrato un incontro segreto di Josef Mengele, il medico nazista che le sue vittime chiamavano “l’angelo della morte”. Il ragazzo rivela che Mengele ha attivato l’ODESSA, la rete clandestina degli ex gerarchi nazisti fuggitivi, per un’operazione segreta: l’eliminazione di novantaquattro uomini in Europa e Nord America, tutti sessantacinquenni e tutti funzionari pubblici. Prima di poter dire di più, il giovane viene ucciso.
Liebermann, benché scettico, inizia a indagare e scopre che gli omicidi stanno avvenendo davvero. Quasi per caso, nota che i figli di due delle vittime sono identici. Approfondendo le ricerche, arriva alla verità: ogni uomo assassinato ha un figlio di tredici anni, clonato da Adolf Hitler e affidato, grazie alla complicità di un’agenzia di adozioni compiacente, a famiglie con condizioni di vita simili a quelle dell’infanzia del führer. L’obiettivo di Mengele è ricreare Hitler, facendogli rivivere le stesse esperienze affinché possa dare vita a un nuovo Reich. Un po’ come il Pierre Menard borgesiano perché scriva il Chisciotte.
Le indagini di Liebermann costringono l’ODESSA a interrompere l’operazione, ma Mengele, ritenendola troppo importante, decide di portarla avanti da solo. Liebermann riesce a individuare la vittima successiva, Henry Wheelock, e si precipita a casa sua. Arriva troppo tardi: Mengele lo ha già ucciso. Tra i due scoppia uno scontro, durante il quale Liebermann rimane ferito. Mengele cerca di convincere Bobby, il figlio adottivo di Wheelock, uno dei cloni di Hitler, a seguirlo e a realizzare il destino per cui è stato creato. Ma il ragazzo, trovandolo folle, ordina ai cani di famiglia di sbranarlo.
Il piano di Mengele viene fermato, ma diciotto cloni hanno già perso i loro padri e vissuto il trauma d’infanzia hitleriano. Liebermann decide di distruggere la lista con i nomi dei ragazzi, rifiutandosi di condannarli a morte per crimini che potrebbero non commettere.
Una macchina narrativa perfetta che si chiude con un presagio: uno dei cloni, un aspirante artista, disegna figure che sembrano evocare le marce e la mobilitazione di massa del Terzo Reich. Come se la grande narrazione del Nazismo non fosse finita nel 1945.
Un fumettista giapponese sembra rispondere a Levin. È probabile che Tsutomu Takahashi conosca bene il romanzo I ragazzi venuti dal Brasile (e il film diretto da Franklin J. Schaffner, con Laurence Olivier nei panni di Lieberman e Gregory Peck in quelli di Mengele). Tra il 2017 e il 2020, ha pubblicato il manga Neun, che, a oltre quarant’anni di distanza, si aggira nel medesimo sistema di incubi.

Il Terzo Reich ha avviato un progetto segreto per creare tredici cloni di Adolf Hitler. Tredici bambini geneticamente modificati destinati a diventare la nuova generazione di leader per perpetuare il regime nazista. Ognuno di questi bambini, chiamati con un numero sequenziale in tedesco, viene nascosto in un villaggio, accompagnato da un supersoldato, chiamato wand (muro), che ha lo scopo di proteggerlo a ogni costo.
Il protagonista è Neun (“9”), un bambino che vive in un villaggio isolato della Germania, cresciuto sotto la protezione del suo wand, Theo Becker, un ufficiale delle SS che ha sviluppato un affetto paterno nei suoi confronti.
Nel 1941, qualcosa va storto (lo scopriremo dopo, uno dei tredici cloni, Zehn, “10”, ha preso il potere) e il Reich ordina lo sterminio dei ragazzini. Becker salva la vita al suo protetto facendo una carneficina e ammazzando decine di nazisti dell’Ordine Nero. Da lì in avanti la vicenda è un crescendo di violenza e di confronti con le scelte, con l’eredità del sangue e con il destino. Colpo di scena: il fumetto non chiude nulla, finisce in maniera così sospesa da rendere possibile qualsiasi interpretazione. Lo scenario più assurdo che possiamo configurarci è che quella grande narrazione sia precipitata in una distesa di rivoli – che non hanno nulla di ucronico – che hanno condotto il nazismo fino ai giorni nostri. Neun ci dice che il nazismo non è morto, ma si è frantumato in mille pezzi, come un bicchiere. E come un bicchiere, i suoi frantumi feriscono ancora chi li calpesta.
Al contrario di Ira Levin, Theodor W. Adorno, nei suoi sessantasei anni di vita, ha scritto e pubblicato moltissimo. Della sua ragguardevole produzione ricordo solo un aforisma del 1949: ritornato a Francoforte dopo essersi rifugiato, negli anni del Nazismo, prima a Oxford e poi negli Stati Uniti, appunta: «Scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie».
Adorno era un musicologo e un pianista dilettante. Compose, scrisse di musica e suonò fino alla fine dei suoi giorni, dedicando alla barbarie molto del suo tempo e rischiando di creare confusione. Avremmo dovuto aspettare il 1979 e La condizione postmoderna di Jean-François Lyotard per capire meglio le implicazioni di quella frase lapidaria.

Nel suo saggio, Lyotard annuncia la fine delle grandi narrazioni che hanno strutturato la modernità, innervandola di certezze positiviste e inoculando fiducia nell’ineludibilità dell’evoluzione del pensiero, della scienza e della società. Le narrazioni dell’emancipazione del soggetto razionale e della storia universale dello Spirito, a detta di Lyotard, sono finite: la conoscenza non può più fondarsi su un’autorità unica e unificatrice. Il sapere si frammenta in una molteplicità di linguaggi e pratiche, senza un centro attorno al quale orbitare. Siamo immersi nel postmoderno, in un’epoca in cui la conoscenza non si legittima più attraverso grandi narrazioni, ma si disperde in una costellazione di microracconti e giochi di linguaggio eterogenei che scombinano la parafrasi del tempo.
Adorno dice che dopo Auschwitz non si può più scrivere poesia. Lyotard dice che le grandi narrazioni sono morte. Ma la poesia sopravvive e il nazismo e il fascismo non sono grandi narrazioni, sono virus capaci di adattamento: non vogliono uccidere il loro ospite, lo vogliono modificare per renderlo idoneo alle loro esigenze. I virus sanno riscriversi e sanno infettare nuovi corpi, nuove storie e, purtroppo, anche nuove poesie.
Lo stato delle cose: un po’ di luoghi, un po’ di numeri

All’inizio del 1945, sul pianeta si muovono circa 2,3 miliardi di umani. Un numero di viventi in diminuzione rispetto all’anno precedente. Le stime che abbiamo ci dicono che nel Ventesimo secolo è successo solo due volte che gli umani che calpestano la superficie del globo diminuissero: tra il 1915 e il 1918, per effetto della Prima guerra mondiale (e, in parte, dell’influenza spagnola), e tra il 1940 e il 1945. Già, le guerre uccidono.
Fino all’inizio del 1945, si stima che la guerra abbia causato tra i 50 e i 55 milioni di vittime, 30 milioni delle quali civili. Entro la fine del conflitto, quella cifra salirà a un numero che oscilla tra i 60 e i 70 milioni. Stiamo parlando del 3% della popolazione mondiale. Per intenderci, la Grande Guerra (aiutata da una pandemia) ha ucciso meno dell’1% degli umani presenti sul pianeta.
All’inizio dell’anno, la guerra è ancora in corso su diversi fronti cruciali. In Europa, gli alleati, dopo essere sbarcati in Normandia, nel giugno 1944, e aver liberato Parigi, in agosto, avanzano in Germania, fronteggiando i tedeschi sulle Ardenne. Siamo a un punto di svolta: gli alleati si preparano ad attraversare il Reno.
Da est, l’Armata Rossa sovietica ha sfondato le difese tedesche e avanza verso Berlino. Il 12 gennaio, inizia l’offensiva Vistola-Oder, che porta i sovietici a meno di cento chilometri da Berlino in poche settimane.
In Italia, gli alleati percorrono la Linea Gotica, l’ultima grande linea difensiva tedesca nella penisola, mentre la resistenza partigiana intensifica le operazioni contro i nazifascisti.
Sempre all’inizio dell’anno, gli Stati Uniti sono in piena offensiva contro il Giappone. A gennaio le Filippine sono territorio di contesa, con la battaglia di Luzon. Il Giappone, seppure in ritirata, resiste con accanimento, usando gli aerei come missili in missioni suicide che ci piaceva chiamare kamikaze.
In Birmania, le forze britanniche e cinesi combattono contro i giapponesi. In Cina, il fronte tra giapponesi e cinesi è ancora attivo, anche se il Giappone perde terreno.
All’inizio del 1945, i cattivi – la Germania, il Giappone e l’Italia – sono in evidente difficoltà, ma la guerra è tutt’altro che finita. Ci aspettano altri 10 o 15 milioni di morti.
Non dovevamo fermarci

La liberazione dell’Italia è un processo lungo che vede i fascisti e i nazisti attaccati da due forze diverse: da un lato, l’esercito degli alleati e, dall’altro, i partigiani.
Mentre gli aerei bombardavano Milano e Napoli, nell’agosto del 1943, l’esercito anglo americano era già sbarcato in Sicilia (tra il 9 e il 10 luglio). Il 25 luglio, il Gran Consiglio del Fascismo aveva sfiduciato Benito Mussolini e il re Vittorio Emanuele III lo aveva fatto arrestare e aveva nominato Pietro Badoglio capo del governo.
Il 3 settembre l’Italia aveva firmato l’armistizio con gli Alleati, facendo incupire i tedeschi: la Germania aveva reagito occupando il centro-nord Italia e instaurando la Repubblica Sociale Italiana (RSI). A capo ci aveva piazzato Mussolini, liberato dal carcere il 12 settembre.
Intanto il Regno del Sud, sotto il controllo alleato, si era stabilito a Brindisi con il governo Badoglio.
Gli alleati avanzavano lentamente, ostacolati dalla resistenza tedesca: Napoli era sta liberata il 1º ottobre 1943; per Roma si deve aspettare il 4 giugno 1944.
Dopo la liberazione di Roma, Badoglio dà le dimissioni e viene insediato un governo di unità nazionale guidato da Ivanoe Bonomi, di cui non si ricorda proprio nessuno.
La Resistenza partigiana, nel frattempo, prosegue con azioni di guerriglia e sabotaggi. Ai nazisti e ai fascisti la cosa dà parecchio fastidio: la repressione della Resistenza è brutale. Hai presente cosa è successo a Marzabotto? E a Sant’Anna di Stazzema? Chi si sarebbe mai aspettato che postnazisti con le svastiche di peluche, alte cariche governative e personaggi con baffi e diastema avrebbero riraccontato a muzzo quella storia, la nostra storia, sui loro canali social, facendola diventare la loro? Ma ormai lo abbiamo capito: la verità non esiste e la realtà è l’abito di un dio che si cambia quando vuole senza alcun vincolo di coerenza.
Il 9 aprile, gli Alleati lanciano l’offensiva finale sulla Linea Gotica. Il 19 aprile Bologna è liberata. Il 25 aprile il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) proclama l’insurrezione generale («Aldo dice 26 x 1»): Milano, Torino e Genova insorgono e vengono liberate dai partigiani.
Il 28 aprile Mussolini viene catturato e ucciso a Giulino di Mezzegra. Poi viene esposto in Piazza Loreto a Milano.
L’Italia è libera, ma segnata da anni di guerra, occupazione e lotta fratricida. Quella lotta prosegue per un po’, anche dopo la Liberazione, ma poi si spegne. Anche in nome di una pacificazione nazionale che alla fine si è tradotta in una resa. Giorgio Canali ci dà una versione dei fatti diversa, quasi ucronica, in quel gioiello (inedito, dannazione!) intitolato Lettera del compagno Lazlo al colonnello Valerio:
«Fischiava il vento / nella canna del fucile, / rossa primavera / alla fine di aprile. // Poi venne maggio, / l’ordine di disarmarci. / Caro Valerio, / non dovevamo fermarci. // Non dovevamo fermarci, / si doveva continuare, / si fa con lo schioppo / l’unità nazionale! // Mandando ogni uomo / vestito di nero / prete, fascista o sbirro del re / al cimitero // E invece sono ancora tutti là / con i sorrisi smaglianti, / sono là i figli e i nipoti / vincenti e arroganti.»
Altri dittatori
Diciamocelo, il Ventennio è stato una merda, ma, come nemici, gli italiani erano abbastanza risibili. Nell’ultima mezz’ora di film girata da Bruce Lee nel 1972, quella nota come Game of Death, c’è una splendida intuizione che avrebbe influenzato tutto l’immaginario successivo. Per ottenere la vittoria bisogna scontrarsi con nemici sempre più potenti, risalendo, con la tutina gialla e aderente, la pagoda. Quello lasciato al primo piano è poco più che riscaldamento. Ed effettivamente, anche dal punto di vista dell’immagine, quegli italiani erano ridicoli, comandati da un brutto romagnolo, in pose sempre esasperate, con troppa mascella e il cranio liscio e tondo come un melone. Una macchietta inguardabile che solo gente con poco gusto – compresi scrittori e serializzatori televisivi nazional popolari – può continuare a mitizzare.
Non che Adolf Hitler fosse un granché, ma almeno si era tagliato i baffi come Charlie Chaplin. Cosa di cui avrebbe, nel tempo, avuto modo di pentirsi.

Il 12 gennaio l’Unione Sovietica lancia l’offensiva Vistola-Oder, avanzando rapidamente dalla Polonia fino alle porte di Berlino. A metà aprile inizia la battaglia di Berlino, con i sovietici che accerchiano la capitale tedesca.
Dopo la vittoria nelle Ardenne, avvenuta in gennaio, gli anglo-americani attraversano il Reno il 7 marzo. A fine marzo conquistano Colonia, Francoforte e altre città. Il 4 aprile liberano il campo di concentramento di Buchenwald e mostrano al mondo gli orrori del regime nazista.
Il 20 aprile i sovietici iniziano l’assalto finale a Berlino. Il 25 aprile avviene l’incontro tra le truppe sovietiche e americane a Torgau, sul fiume Elba.
Il 30 aprile, dopo aver sposato Eva Braun e nominato Karl Dönitz suo successore, Hitler si suicida nel suo bunker.
Il 2 maggio Berlino si arrende ai sovietici. Il 7 maggio il generale Alfred Jodl firma la resa incondizionata della Germania a Reims, presso il quartier generale alleato. Il giorno dopo, la resa viene ratificata a Berlino di fronte all’Unione Sovietica: la guerra in Europa è finita, ma il conflitto continua altrove.
Il nemico più facile da identificare come tale è culturalmente diversissimo dagli alleati. Invece di concentrarsi sulle tradizioni, sull’arte e sulla filosofia, con il consueto approccio stronzo degli umani, ci si concentra su differenze fisiche risibili che consentono di rimarcarne l’alienità. E i giapponesi, nell’immaginario di guerra che si trascinerà negli anni a venire, diventano, con pochissime preoccupazioni linguistiche, i “musi gialli”.
Nel Pacifico, la guerra contro il Giappone prosegue a lungo e si conclude con un evento militare epocale, reiterato a dimostrazione che la guerra ha più a che fare con la vendetta che con la giustizia.
Dopo la vittoria alle Midway, nel 1942, e la sanguinosa campagna di Guadalcanal, tra il 1942 e il 1943, gli Stati Uniti adottano la strategia “island hopping” e conquistano isole strategiche per avvicinarsi al Giappone.
La battaglia del golfo di Leyte, nell’ottobre 1944, è la più grande battaglia navale della storia: la Marina giapponese viene praticamente annientata e gli statunitensi riconquistano le Filippine.
Tra febbraio e marzo 1945, i marines combattono per oltre un mese per conquistare Iwo Jima.
L’ultima grande battaglia della guerra nel Pacifico è quella di Okinawa, tra aprile e giugno. I giapponesi usano tattiche kamikaze e resistenza disperata. Gli americani vincono, ma con oltre 200.000 morti tra soldati e civili. E, in primavera, inizia il bombardamento del Giappone: si levano i B-29 Superfortress,

Tra il 9 e il 10 marzo, Tokyo, una città in legno, viene distrutta da un bombardamento incendiario: le vittime civili sono 100.000.
Poi è la volta di Nagoya, Osaka, Kobe, Yokohama, Fukuoka, Kawasaki, Sendai, Shizuoka, Hamamatsu, Okayama, Kagoshima, Sasebo, Mito, Takamatsu, Hachioji, Niigata…
E non finisce qui.
Il 6 agosto 1945, viene sganciata “Little Boy”, la prima bomba atomica, su Hiroshima: 80.000 persone muoiono all’istante e oltre 140.000 entro la fine dell’anno. Tre giorni dopo, è la volta di “Fat Man”, la seconda bomba atomica su Nagasaki: 40.000 morti immediati e oltre 70.000 entro la fine dell’anno.
In totale, i bombardamenti convenzionali e atomici uccidono tra 500.000 e 1.000.000 di civili giapponesi e lasciano oltre 8 milioni di sfollati.
Tra un’esplosione atomica e l’altra, l’8 agosto l’Unione Sovietica dichiara guerra al Giappone e invade la Manciuria. Una settimana dopo, il 15, l’Imperatore Hirohito annuncia la resa e il 2 settembre il Giappone firma la resa a bordo della corazzata statunitense USS Missouri.
La Seconda guerra mondiale è finita.
Il taglio della torta: tra occupazione e corsa alla conquista
È facile trovare i cattivi della storia se questi sono degli osceni criminali che indossano camicie brune o nere. La ricerca dei buoni è più complessa: richiede un atto di fede infinita.
La guerra non si è ancora conclusa e già gli alleati si muovono per ridisegnare i confini del mondo.
La pace del 1945 segna l’inizio di un dopoguerra che forse non c’è mai stato. Il conflitto prosegue senza soluzione di continuità e, almeno nella sua fase iniziale, non si combatte più con le armi, ma con la diplomazia, l’occupazione militare e il controllo ideologico dei territori. Gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, formalmente alleati nella lotta contro l’Asse, si guardano con sospetto, brandendo le lame da torta più affilate. Pronti a dividersi il pianeta in due metà da contrapporre.
Già in febbraio, Franklin Delano Roosevelt, Iosif Stalin e Winston Churchill si incontrano a Yalta per delineare il futuro dell’Europa. L’accordo ufficiale parla di democrazia e autodeterminazione, ma nella realtà ciascuna potenza punta a consolidare la propria influenza. La Germania viene divisa in quattro zone di occupazione (statunitense, sovietica, britannica e francese), così come Berlino, ma pare proprio che nessuno si illuda che la convivenza sarà pacifica.
A luglio, la conferenza di Potsdam conferma le divisioni. Nel frattempo, Roosevelt è morto e il suo posto è stato preso da Harry S. Truman e Churchill è stato sostituito da Clement Attlee: Stalin ha gioco facile a imporre la sua linea con i novellini. L’Unione Sovietica si assicura il controllo dell’Europa orientale, giustificandolo come misura di sicurezza per evitare future invasioni dalla Germania. Gli Stati Uniti, dal canto loro, prendono tempo e mostrano i muscoli: il 16 luglio, mentre la conferenza è in corso, testano con successo la bomba atomica nel deserto del New Mexico. Truman non ne parla direttamente a Stalin, ma questi ha già le sue spie a Los Alamos e sa benissimo cosa sta succedendo.

Dopo il 2 maggio, americani e sovietici iniziano una partita a scacchi sulle macerie per il controllo del continente europeo. L’Armata Rossa, che ha liberato gran parte dell’Europa orientale dal nazismo, non ha alcuna intenzione di andarsene. In Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia, Romania e Bulgaria, i governi locali vengono progressivamente epurati dagli elementi non comunisti, spesso con la complicità della polizia segreta sovietica. Le elezioni promesse a Yalta diventano una farsa, con risultati già scritti a Mosca. La Jugoslavia di Tito segue una strada autonoma, ma comunque nell’orbita socialista.
Intanto, in Europa occidentale, gli americani fanno la loro parte per stabilizzare governi amici e contrastare la penetrazione comunista. La Francia di De Gaulle e l’Italia, dove il PCI è forte ma non abbastanza da prendere il potere, sono sotto stretta osservazione. Berlino, il cuore diviso del vecchio Reich, diventa il punto di frizione per eccellenza: una città in macerie, controllata da eserciti con visioni inconciliabili.
Se in Europa il controllo del territorio è una questione di sfere d’influenza, in Asia gli Stati Uniti adottano un modello più diretto. Dopo la resa del Giappone, il 2 settembre, il paese diventa un protettorato americano. Il generale Douglas MacArthur gestisce la ricostruzione politica ed economica. Il regime imperiale viene smantellato, ma l’imperatore Hirohito viene risparmiato e trasformato in una figura simbolica, utile per garantire la stabilità. Gli americani impongono una nuova costituzione, abolendo l’imperialismo e trasformando il Giappone in una democrazia parlamentare.
Altrove, la spartizione è più brutale. La Corea, liberata dall’occupazione giapponese, viene divisa lungo il 38° parallelo: a nord, l’Armata Rossa installa un regime comunista sotto Kim Il-sung; a sud, gli americani sostengono Syngman Rhee. Nessuno lo sa ancora, ma questa linea arbitraria sulla mappa getterà le basi per una delle guerre più sanguinose della seconda metà del secolo.

Alla fine del 1945, il mondo è finalmente in pace. Ma i vincitori non lo sono tra di loro: un confronto ideologico destinato a ridefinire l’ordine globale. L’Europa è spaccata in due, l’Asia è un mosaico di territori in fermento. E tutti sanno che esiste la bomba atomica, un’arma micidiale, e può essere usata. Anche per ragioni difficili da capire.
La costruzione di un simulacro di pianeta
Già, la bomba atomica. In questo teatrino militare da settanta milioni di morti c’è una domanda semplice alla quale troviamo solo risposte agghiaccianti. La guerra era vinta, che senso ha avuto la seconda bomba atomica?
Abbiamo risposte diverse e tutte molto insensate: innanzi tutto, bisognava imporre al Giappone la resa immediata; poi, bisognava dare un segnale ai sovietici, che avevano dichiarato guerra al Giappone il giorno prima e stavano invadendo la Manciuria; infine, ma temo soprattutto, bisognava giustificare l’enorme investimento del progetto Manhattan.
E dove lo trovi un laboratorio così efficace per sperimentare la testata al plutonio (“Fat Man”), dopo aver testato quella all’uranio (“Little Boy”)?

Una pace ottenuta con il terrore, con i muscoli e con una spregiudicatezza criminale, per interrompere una guerra fatta di epurazione e genocidi, rende difficile capire dove sia il bene. Cosa sia giusto.
Il 1945 è l’anno in cui la giustizia si misura con il passato e con il peso insostenibile dello sterminio e delle devastazioni. Mentre i vincitori processano i vinti, si aprono nuove ferite: la decolonizzazione, la ricostruzione economica e, soprattutto, lo sterminio degli ebrei pongono problemi che non si risolvono con un trattato di resa.
La guerra ha logorato le potenze coloniali europee. Francia, Gran Bretagna e Olanda, uscite stremate dal conflitto, faticano a mantenere il controllo sui loro territori. Il 1945 segna l’inizio della fine per gli imperi: i movimenti di indipendenza in Vietnam, in Indonesia, in India, in Africa sgretolano l’idea che le colonie siano eterne. Nel giro di due decenni, gran parte del mondo coloniale sarà indipendente, ma il prezzo sarà spesso la guerra e la repressione violenta.
L’Europa è in ginocchio. Le città sono devastate, le industrie distrutte e milioni di persone sono senza casa. Per evitare il collasso economico e contenere l’influenza sovietica, gli Stati Uniti avviano il programma di aiuti per la ricostruzione dell’Europa occidentale che culminerà, nel 1947, nel Piano Marshall, cementando la dipendenza politica ed economica dei paesi occidentali.
Un solo grande silenzio

Nel novembre del 1945 inizia il Processo di Norimberga, un evento senza precedenti: per la prima volta nella storia, i leader di uno stato vengono giudicati da una corte internazionale per crimini contro l’umanità. I gerarchi nazisti – tra cui Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop e Albert Speer – vengono processati per sterminio, aggressione militare e violazioni del diritto di guerra. Alcuni vengono condannati a morte, altri ottengono pene detentive.
Ma la giustizia non è uguale per tutti. Se in Germania il processo è spettacolare e simbolico, nelle altre nazioni le epurazioni sono caotiche e incomplete. In Francia, in Italia e in Giappone molti collaborazionisti si riciclano rapidamente nelle nuove istituzioni. Alcuni nazisti trovano rifugio in America Latina, spesso con la complicità di governi occidentali. Altri vengono reclutati dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica per sfruttarne le competenze scientifiche e militari, dando origine a programmi segreti come Operazione Paperclip e Azione Osoaviachim.
L’orrore dei campi di sterminio scuote il mondo. Le immagini di Auschwitz, Dachau e Treblinka rendono evidente la portata dell’Olocausto, ma la questione ebraica non si chiude con la Liberazione.
Le indagini condotte dopo la conclusione del conflitto ci danno un’informazione agghiacciante: durante la Seconda guerra mondiale, il numero totale di ebrei uccisi è di 6 milioni. Questa cifra spaventosa include uomini, donne e bambini assassinati nei campi di sterminio, nelle fucilazioni di massa e in tutte le forme di aberrante persecuzione progettate dai nazisti. Questo significa che circa il 10% dei morti della Seconda guerra mondiale è stato ucciso per l’appartenenza a una fede religiosa: un genocidio schifoso, dopo il quale scrivere poesia è un atto di barbarie. Ma, come umani, continuiamo a scrivere poesie e continuiamo a praticare il genocidio come forma di selezione ripugnante dell’umanità che desideriamo.
Alla fine del conflitto, centinaia di migliaia di sopravvissuti si trovano senza casa, privati di famiglia e proprietà. La Palestina, sotto mandato britannico, diventa il principale obiettivo del movimento sionista. Tuttavia, l’immigrazione ebraica si scontra con le restrizioni imposte dal governo britannico e con l’opposizione della popolazione araba locale. Una storia di tensioni, attentati e scontri armati che culmina nella spartizione della Palestina e la nascita dello stato di Israele nel 1948. Ed è solo l’inizio.
Ma torniamo al 1945.
Suonargliene quattro

Pare proprio che l’esercito alleato, che ancora non sapeva cosa succedeva ad Auschwitz, mentre risaliva l’Italia per liberarla dall’occupazione nazifascista, ascoltasse un sacco di musica. Non è poesia, ma ha struttura ritmica, ripetizioni, metafore e fa stare meglio: insomma, ci assomiglia parecchio.
È chiaro, un paese poco industrializzato, con infrastrutture danneggiate, non è l’ideale per trovare prese alle quali attaccare radio e grammofoni, ma una chitarra acustica e uno strimpellatore tra le truppe lo si riusciva a trovare.
Negli Stati Uniti la radio era il mezzo di comunicazione più diffuso: l’80% delle famiglie possedeva un apparecchio. Prima della guerra le radio riservavano il 7% del palinsesto ai notiziari; nelle fasi conclusive – e più concitate – la percentuale di programmazione dedicata alle notizie era salita al 25%. Reportage straordinari che hanno fatto la storia della radio, come quando, nel 1943, Edward R. Murrow fece la cronaca di un raid notturno su Berlino. In guerra, gli statunitensi si portano l’attitudine all’ascolto della musica. Ascoltano, soprattutto, jazz e swing, ma anche country, blues e rhythm’n’blues.
Il jazz, in particolare, è stato bollato dai nazisti come “arte subumana”. Forse, proprio per questo, sopravvive nei territori occupati. Anche in Germania, gli “Swing Kids” sfidano la Gestapo riunendosi in segreto per ascoltare musica proibita e sintonizzarsi sulle radio alleate. Jutta Hipp, pianista tedesca nata a Lipsia nel 1925, racconta che il jazz era una specie di religione e una forma di resistenza, al punto che lei e i suoi amici restavano ad ascoltarlo, invece di scendere nei rifugi, durante i bombardamenti.
Molti musicisti statunitensi registravano “V-Discs”, dischi speciali distribuiti tra i soldati. Le truppe americane, quando ne avevano la possibilità, ascoltavano la radio che trasmetteva programmi musicali pensati per mantenere alto il loro morale. In assenza di radio, i soldati americani, durante i periodi di riposo e se le condizioni operative e logistiche lo consentivano, organizzavano momenti di musica dal vivo con chitarre e armoniche.

In Italia, nel 1933, il regime aveva istituito l’Ente Radio Rurale, che mirava a introdurre la radiofonia nelle scuole di campagna e a diffondere apparecchi radio per l’ascolto collettivo tra scolari e lavoratori agricoli. L’obiettivo dell’Ente era duplice: da un lato, il nobile intento di estendere l’alfabetizzazione in regioni dalle forti differenze linguistiche; dall’altro, quello meno nobile di diffondere i valori del regime. C’era chiaramente l’illusione che un sistema centralizzato e capace di colpire un’utenza indistinta, la più vasta possibile, potesse modificare il modo di pensare in modo armonico e controllato. Nel tempo avremmo scoperto che il modello di divulgazione dal centro – quello che avremmo imparato a chiamare “broadcast” – agevola il fascismo molto meno di quanto fanno le tecniche di marketing e profilazione che oggi ci piace chiamare “l’algoritmo”.
Nel 1945, il numero di abbonamenti radiofonici registrati in Italia è di circa 1.580.000, con ulteriori 44.000 licenze speciali per i locali. Si tratta di circa 150.000 abbonamenti in meno rispetto al 1943. Del resto, c’era una guerra in corso e un bel po’ di case e gran parte dell’infrastruttura (pare il 75% degli impianti radio) erano state distrutte.
Nei primi mesi dell’anno, nelle regioni meridionali, liberate dagli Alleati, la presenza delle truppe anglo-americane introduce nuove influenze musicali. Soprattutto il jazz e lo swing, censurati dal regime fascista, si diffondono tra la popolazione locale. Le orchestre militari alleate organizzano concerti pubblici, e le stazioni radio gestite dagli Alleati trasmettono musica americana, offrendo agli italiani un assaggio della cultura musicale occidentale contemporanea.
Nel Nord Italia, ancora sotto il controllo nazifascista, la musica è una poltiglia di Giovinezza, Faccetta nera e altra fascisteria di regime. Canzoni patriottiche e inni di regime scandiscono i tempi delle trasmissioni radiofoniche e degli eventi pubblici. Nei circoli clandestini, si diffondono i canti della resistenza, come Bella Ciao e Fischia il vento e Dalle belle città.

Dopo il 25 Aprile, la musica diventa un collante culturale in un paese impegnato nella ricostruzione post-bellica.
«Dimane?… Ma vurría partí stasera! / Luntano, no… nun ce resisto cchiù! / Dice che c’è rimasto sulo ‘o mare, / che è ‘o stesso ‘e primma… chillu mare blu! // Munasterio ‘e Santa Chiara… / tengo ‘o core scuro scuro… / Ma pecché, pecché ogne sera, / penzo a Napule comm’era, / penzo a Napule comm’è?»
Tra malinconia, speranza e desiderio di normalità, in un paese devastato dalla guerra, Munasterio ‘e Santa Chiara segna il ritorno alla musica popolare in Italia.
Dopo la Liberazione, Alberto Barberis e Michele Galdieri scrivono la canzone a Napoli, città liberata dagli Alleati nel 1943, ma ancora segnata dai bombardamenti e dalla miseria post-bellica. Il Monastero di Santa Chiara, uno dei simboli della città, è stato distrutto dai bombardamenti dei B17 del 4 agosto 1943. Sofferenza individuale e dolore collettivo si mescolano in una riflessione poetica sulla devastazione della guerra e sul desiderio di ricostruzione.
E Napoli e la sua basilica diventano un simbolo del senso di perdita che tutto il paese sta vivendo. Il lamento di un individuo si unisce alla tragedia di un paese in rovina che cerca di ritrovare sé stesso, diventando la prima colonna sonora dell’Italia post-fascista: una canzone che non celebra la vittoria, ma racconta il lutto e la speranza, e accompagna il paese verso il processo di ricostruzione.
Una cultura che combatte le sofferenze
Il 29 settembre, esce il primo numero de “Il Politecnico”, settimanale di cultura contemporanea fondato da Elio Vittorini e pubblicato da Einaudi. Il giornale nasce con un’intenzione chiara: non limitarsi a raccontare la realtà del dopoguerra, ma trasformarla.
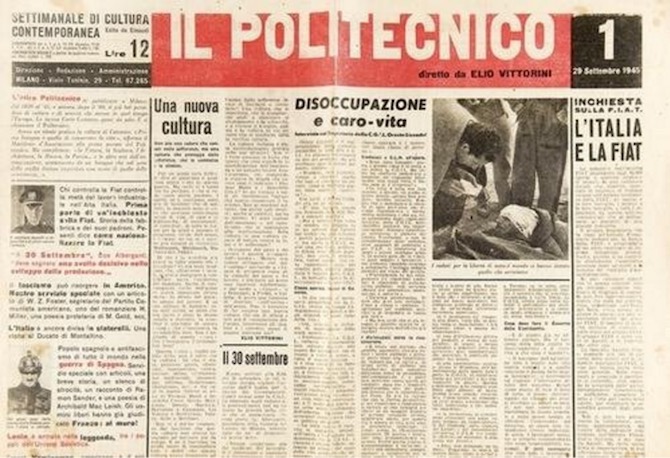
Nel suo editoriale inaugurale, “Una nuova cultura”, Vittorini lancia un attacco alla cultura tradizionale, incapace di prevenire il disastro della guerra. Il suo obiettivo è creare un sapere che non sia solo consolatorio, ma che serva a proteggere l’uomo dalle sofferenze, a combatterle e a eliminarle. Il Politecnico si rivolge a comunisti, cattolici, idealisti e mistici: a chiunque sia disposto a ripensare radicalmente il ruolo della cultura.
L’impianto visivo, curato da Albe Steiner, è essenziale ma innovativo: parole e immagini convivono in una struttura grafica che non si limita a impaginare i contenuti, ma li rende parte di una narrazione che mescola parole e immagini. L’attenzione alla fotografia e alla grafica è una delle cifre distintive del giornale.
Nei suoi primi numeri, “Il Politecnico” propone una miscela di saggi storici, analisi sociali, racconti, romanzi a puntate, sequenze fotografiche e illustrazioni. Il fumetto fa la sua comparsa fin dall’inizio: nella seconda pagina del secondo numero (6 ottobre), Giuseppe Trevisani firma “Il mondo a quadretti”, forse il primo articolo in Italia a tentare un’analisi dei fumetti, riconoscendone il valore espressivo e narrativo.
Ma “Il Politecnico” è soprattutto un luogo di dibattito e conflitto. Il progetto di Vittorini è ambizioso: una cultura militante, capace di confrontarsi con il presente senza ridursi a propaganda. Un progetto che entrerà presto in attrito con la guida del Partito Comunista Italiano, fino alla chiusura definitiva della rivista nel dicembre 1947. Ma nel 1945, “Il Politecnico” è il simbolo di un’Italia che prova a rialzarsi, che cerca nel pensiero e nelle immagini uno strumento per costruire il futuro.
Ma non è l’unico.
Si può, fare la Liberazione con i fumetti

Sul finire dell’estate, a Venezia, in un’osteria nascosta tra le calli, tre amici si ritrovano attorno a un tavolaccio. Mario Faustinelli, Alberto Ongaro e Hugo Pratt hanno tra i diciotto e i vent’anni. La guerra è finita da pochi mesi, l’Italia è un paese occupato e incerto sul proprio futuro. Venezia è un punto strategico per gli Alleati, ma in quella piccola osteria il mondo sembra fermarsi: una caraffa di Cabernet o di Refosco, un pacchetto di sigarette americane con il cammello stampigliato sopra, e un mazzo di giornali e giornaletti, forse lasciato proprio da qualche soldato statunitense. Dal mucchio di carta emergono le strisce di Terry e i pirati di Milton Caniff, di Phantom di Lee Falk e Ray Moore, di Dick Tracy di Chester Gould e gli albi di Superman (“Action Comics”) e Batman (“Detective Comics”). Faustinelli e Ongaro li divorano con entusiasmo. Pratt, più giovane e già con la matita in mano, li osserva sornione. Lui quei fumetti li conosce bene, e i suoi amici da tempo lo incalzano: «Dovremmo farlo anche noi!»
Non una striscia, però. Non in Italia, dove il fumetto non trova spazio sui quotidiani. Meglio un albo, un giornale di storie illustrate, qualcosa che abbia il ritmo serrato delle avventure americane, ma adattato a un formato pensato per i lettori italiani. Nasce così l’idea di una rivista: “Asso di Picche”. Per pubblicarla, i tre fondano una piccola casa editrice, la Albi Uragano Inc.
Il primo numero di “Asso di Picche” esce il 21 dicembre e ha formato orizzontale, con due strisce per pagina. Quel progetto proseguirà fino al. 1949, trasformandosi un albo verticale con quattro e poi cinque strisce per pagina. Il segno di Pratt è ancora acerbo, ma già lo si riconosce: la sintesi del tratto, l’uso dello spazio, la gestione delle ombre. È figlio di Caniff, di Moore, di Gould, ma con qualcosa di più: una naturale capacità di orchestrare la narrazione visiva, come un compositore di tango.
Nel bicchiere si svuota l’ultima ombra di vino. I tre amici hanno vent’anni, pochi soldi e un sogno. L’editoria a fumetti italiana può cambiare volto.
Contro ai re e ai tiranni
L’editoriale di Vittorini, nel primo numero del “Politecnico” è chiaro: «Non più una cultura che consoli nelle sofferenze ma una cultura che protegga dalle sofferenze, che le combatta e le elimini».
E se questi sono gli obiettivi cui deve mirare una nuova cultura, bisogna partire dai più deboli, da chi, per statuto, ha più bisogno di protezione: i bambini. Non c’è niente di peggio di una cattiva pedagogia che ambisce a modificare il pensiero dei bambini, inoculando loro cospicue dosi di sapere adulto, di valori del passato. Vecchi tromboni che cercano di perpetuare i loro ideali, immettendoli a forza nell’immaginario infantile.
Non siamo in grado di stimare quanti siano i bambini uccisi durante la Seconda guerra mondiale (forse dieci o, addirittura, quindici milioni), ma possiamo provare a enumerare le cause principali delle loro morti: massacri, stermini mirati, campi di concentramento, bombardamenti, esperimenti medici, fame e malattia. Alla fine della guerra, di quella guerra, i bambini meritano chiarezza e onestà: sono sopravvissuti a una catastrofe che ha ammazzato il 3% della popolazione umana nel mondo.
È giusto che arrivino storie, magari in forma di libro, capaci di portare messaggi di ribellione, critica sociale e riflessione sulle atrocità della guerra.

Il 26 novembre esce Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, un romanzo straordinario che racconta una storia realmente imprevista e rorida di anarchia.
Pippi è una bambina forte e indipendente che abita da sola a Villa Villacolle con il suo cavallo e la scimmietta Signor Nilsson. Diventa amica di Tommy e Annika, con cui vive avventure stravaganti, sfidando le convenzioni sociali e gli adulti che vogliono educarla. Con la sua fantasia e la sua forza sovrumana, affronta ladri, poliziotti e persino un toro, sempre con spirito giocoso. Nonostante le pressioni, rifiuta di andare a scuola e di conformarsi alle regole. Alla fine, decide di non crescere mai, continuando la sua vita libera e avventurosa. E fanculo chi è cresciuto, chi governa, chi fa la guerra!
In un mondo in cui un numero atrocemente grande di bambini non ha potuto scegliere di non crescere, Pippi dà un chiaro segnale di emancipazione e liberazione da un mondo adulto che non solo si è rivelato completamente inaffidabile, ma si è mostrato fottutamente pericoloso.

Negli stessi giorni, Dino Buzzati pubblica La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Prima dell’edizione in volume, quella storia era stata pubblicata, con differenze sostanziali, a puntate dal “Corriere dei Piccoli, durante gli ultimi mesi di guerra.
Gli orsi, guidati da re Leonzio e affamati da un inverno rigido, invadono il Granducato di Sicilia in cerca di cibo e per ritrovare il figlio del re, Tonio. Dopo battaglie epiche e l’aiuto del mago De Ambrosiis, gli orsi sconfiggono il Granduca e instaurano un regno di convivenza con gli uomini. Col tempo, però, si corrompono adottando vizi umani, fino a che il perfido ciambellano Salnitro tradisce e ferisce mortalmente Leonzio. Sul letto di morte, il re ordina agli orsi di tornare sulle montagne, abbandonando la civiltà e le sue tentazioni.
Una fiaba che esplora l’inevitabile corruzione e la perdita dell’innocenza portate dal potere. Animali che cercano la libertà, fanno la rivoluzione e si corrompono. Ed è impossibile non osservare una somiglianza tematica con un altro romanzo uscito nello stesso anno in Inghilterra: La fattoria degli animali di George Orwell.
Gli animali della fattoria Manor si ribellano al padrone umano e instaurano un governo basato sull’uguaglianza, guidati dai maiali. Col tempo, però, i maiali, sotto la leadership di Napoleone, assumono sempre più potere, instaurando un regime oppressivo e manipolando la realtà a loro vantaggio. Le regole iniziali vengono progressivamente distorte fino a rendere i maiali indistinguibili dagli esseri umani. Gli altri animali, sfruttati e ingannati, finiscono per accettare la loro condizione senza più opporsi. Il romanzo, che è una metafora della Rivoluzione russa e della degenerazione del comunismo, si conclude con la constatazione amara che il potere corrompe, indipendentemente da chi lo detiene.

Questi animali troppo umani affondano le radici in un tempo remoto. Senza però risalire la freccia del tempo come un salmone, basta guardare un fumetto pubblicato appena un anno prima in Francia: La Bête est morte! di Edmond-François Calvo, su testi di Victor Dancette e Jacques Zimmermann. Quest’opera, realizzata clandestinamente durante l’occupazione nazista, racconta la Seconda guerra ,ondiale attraverso una satira animalière, dove le diverse nazionalità sono rappresentate da animali: i tedeschi come lupi, gli inglesi come bulldog, i francesi come conigli, gli americani come bisonti e i giapponesi come scimmie. La narrazione, divisa in due volumi intitolati Quand la bête est déchaînée e Quand la bête est terrassée, offre una critica feroce del conflitto e delle sue atrocità.
E trovo incredibile come questo stratagemma di raccontare i gruppi nazionali come specie animali sia, alla fine, il nucleo allegorico del più grande racconto dell’Olocausto che abbiamo: Maus di Art Spiegelman,pubblicato tra il 1980 e il 1991.
Te, gli intellettuali e i pirati
E fanculo pure Lyotard! Le grandi narrazioni non sono finite per nulla. Il fascismo e il nazismo non sono eventi circoscritti a un periodo lontano, una guerra, un processo. Non sono nemmeno soltanto ideologie: sono strutture di pensiero, modelli organizzativi, virus narrativi. Il 25 aprile non è finito un bel niente. E nemmeno il 2 settembre. Quelli che si muovevano esplicitamente sotto l’egida del fascismo, del nazismo e dell’imperialismo hanno perso la guerra. Ha vinto la democrazia, bombardando Dresda, Würzburg, Pforzheim, distruggendo con tonnellate di esplosivo incendiario le città di legno del Giappone e sganciando due bombe atomiche. E, da quel momento, i buoni sono diventati indistinguibili dai cattivi. Perfino i più grandi perseguitati del conflitto, gli ebrei, vittime di un tentativo di sterminio, hanno rifiutato di fare i conti con la loro storia e, rappresentati dallo stato di Israele e in nome di un risarcimento dovuto per la terribile piaga subita, si sono trasformati, un giorno dopo l’altro, in genocidi a loro volta.

È inevitabile tornare, ancora una volta a Philip K. Dick, avvicinandosi questa volta a La svastica sul sole, il romanzo del 1962. Il racconto di un mondo in cui l’Asse ha vinto la Seconda guerra mondiale e gli Stati Uniti sono divisi tra il Reich Nazista e l’Impero giapponese, mentre gli ex vincitori sono ora oppressi e sottomessi. La cultura, l’economia e la politica sono ridefinite dal dominio tedesco e giapponese, con persecuzioni razziali e una costante tensione tra le due superpotenze. E, a dire che un altro mondo è possibile, un libro proibito racconta un mondo in cui gli alleati hanno vinto, insinuando il dubbio sulla realtà stessa. La storia non è fissa: il potere ridefinisce il passato e il futuro. Ancora una volta l’abito di un dio incoerente.
A guardare il mondo, non si capisce più tanto bene se i fascisti e i nazisti abbiano perso o vinto la guerra. Di sicuro non hanno perso la capacità di mutare e replicarsi. Per decenni hanno serpeggiato ai margini della storia, si sono sotterrati, si sono mossi nella rete fognaria col loro aspetto sorcino, hanno lavorato nel sottobosco delle frustrazioni, dell’inquietudine, dell’odio, in attesa di un nuovo ciclo di fioritura.
Ora sono ovunque. Non più solo nella retorica sgangherata dei nostalgici, ma nelle parole levigate dei politici eletti, nelle bolle digitali che generano consenso, nei discorsi rassicuranti sulle identità e sulla sicurezza. Sono algoritmi, sono simulazioni, sono procedure burocratiche che sembrano neutre, ma contengono il seme del dominio e dell’esclusione. Non hanno più bisogno delle camicie nere e delle svastiche: basta una legge sul decoro urbano, un filtro sui social, una politica dei dazi, un finanziamento a guerre assurde, una dichiarazione di volontà di trasformare una striscia di terra dolorante in una riviera mediorientale, una corsa al riarmo fuori misura, una narrazione che distingue i meritevoli dagli invasori. Sono meno appariscenti, più pervasivi. Sorridono dai palazzi governativi e si definiscono democratici mentre spogliano di senso la democrazia stessa. E dove fanno il deserto, lo chiamano pace.
Ricominciare da una caccia alla cometa

Eppure, nel 1945, in questo mondo disfatto e sfinito, qualcuno ha ancora la forza di immaginare qualcosa di diverso. In Finlandia, mentre l’Europa è un continente di macerie, una scrittrice di nome Tove Jansson disegna strane creature tonde, con occhi piccoli e attenti. Sembrano ippopotami, ma non lo sono. Sono Moomin, esseri gentili, curiosi, solidali. Nati dall’orrore della guerra, sono il suo antidoto più semplice e rivoluzionario: il desiderio di un mondo in cui ci si possa ancora fidare gli uni degli altri.
I Moomin non vivono in una società perfetta, ma in un universo parallelo che accetta le differenze. Accolgono chi arriva, cercano di capire gli sconosciuti, si prendono cura gli uni degli altri senza chiedere nulla in cambio. Non combattono, non tracciano confini, non cercano nemici. Esistono. Resistono.
Forse è questa la speranza: non vincere, ma resistere. Non sconfiggere, ma sottrarsi alla logica del dominio. Se il fascismo è un virus, la cura non è un vaccino, ma una pratica quotidiana: ricordare, riconoscere, scegliere. Cercare nello schifo ciò che schifo non è. Per avere almeno la sensazione di abitare un mondo abitabile.

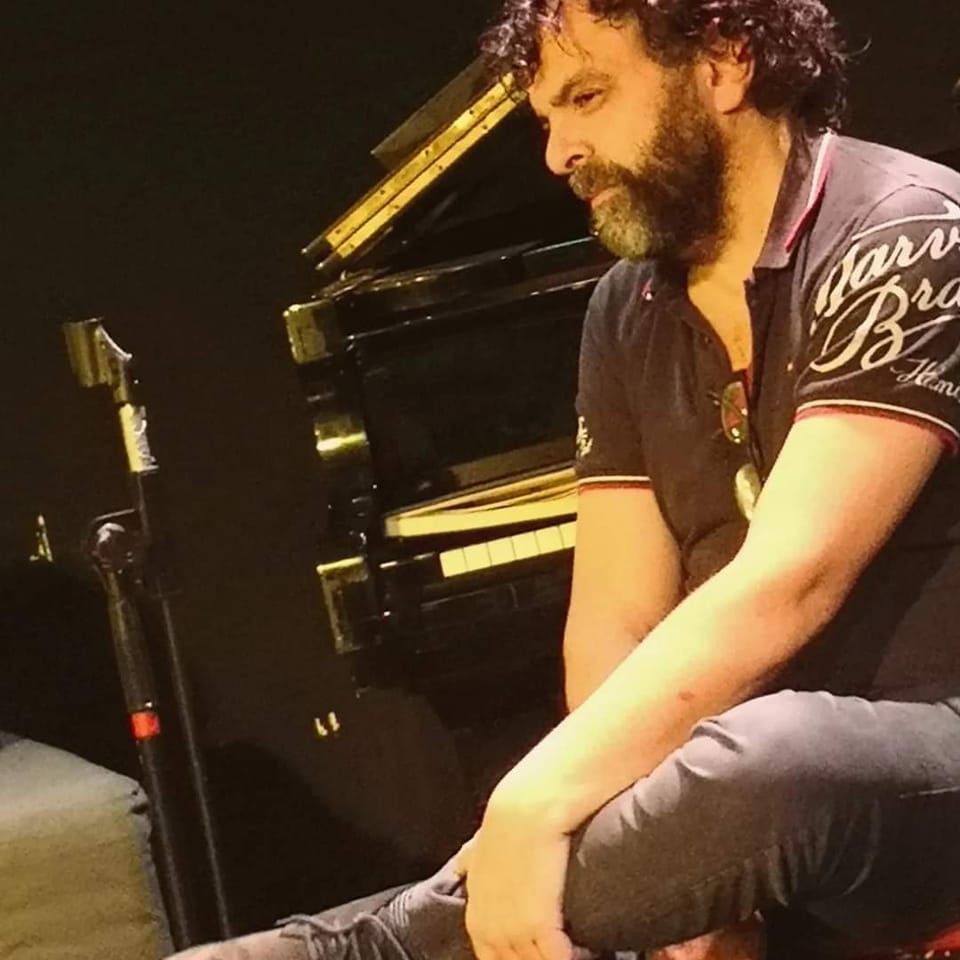
Scrive e parla, da almeno un quarto di secolo e quasi mai a sproposito, di fumetto e illustrazione . Ha imparato a districarsi nella vita, a colpi di karate, crescendo al Lazzaretto di Senago. Nonostante non viva più al Lazzaretto ha mantenuto il pessimo carattere e frequenta ancora gente poco raccomandabile, tipo Boris, con il quale, dopo una serata di quelle che non ti ricordi come sono cominciate, ha deciso di prendersi cura di (Quasi).