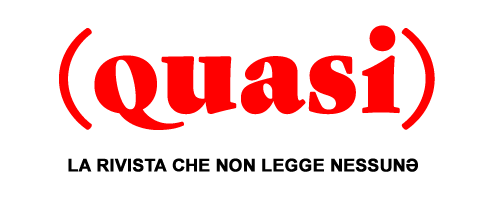«Le canzoni della Liberazione sono un territorio scomodo. A un certo punto diventano consolatorie. C’è un modo per leggerle diversamente?»
Questo mi chiede Paolo, in relazione a un mio possibile intervento sul tema che la redazione di (Quasi) ha scelto per aprile 2025, ovvero “Avere ottant’anni” (e, in caso non lo sapessi, Paolo è Paolo Interdonato, quello che, insieme a Boris, ovvero Boris Battaglia, dirige il carrozzone virtuale che stai leggendo).
Non dovrei specificarlo, ma visti i tempi malaugurati, è bene farlo: gli ottant’anni del titolo del tema mensile di (Quasi) si riferiscono a quelli che quest’anno ricorrono dalla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, avvenuta nel 1945, nella data simbolica del 25 aprile.
Qui è bene specificare anche un’altra cosa: la Liberazione in questione è dal nazifascismo, quindi non solo dalle truppe naziste che avevano invaso il paese dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 (quando l’Italia cambiò bandiera e si schierò con gli angloamericani contro i suoi ex-alleati nazisti), ma anche dal fascismo e dalla sua dittatura ventennale; dittatura che appoggiò pienamente il nazismo e che, dopo averne ispirato i fondamenti, si fece a sua volta ispirare per mostruosità come le leggi razziali e i campi di concentramento (non che l’Italia fascista fosse comunque a digiuno di mostruosità: basti pensare alle guerre coloniali e all’uso che fece il nostro esercito di allora delle armi chimiche).
Dopo vent’anni di dittatura, nel luglio del 1943, Benito Mussolini venne destituito dal suo stesso governo e arrestato. Con l’aiuto dei nazisti, che nel frattempo occuparono l’Italia, pochi mesi dopo, Mussolini tornò in libertà e rifondò il fascismo con la Repubblica Sociale Italiana, la cosiddetta “Repubblica di Salò”: è in quel periodo che, nel Nord-Italia, nasce anche la lotta partigiana.
Di nuovo, una cosa che è bene specificare: la lotta partigiana ha avuto moltissime incarnazioni e declinazioni differenti, sia politiche che ideologiche. Non erano solo i “rossi” a combattere, quindi non solo comunisti, socialisti o anarchici, ma anche, per esempio, cattolici e repubblicani. Tutti loro si consideravano antifascisti e il loro scopo principale era appunto la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.
Bene, fatta questa breve ma necessaria ricapitolazione, veniamo alle canzoni della Liberazione e della Resistenza, canzoni “scomode” oggi più che mai.
Da un paio d’anni, tengo insieme a Ilaria La Fata, ricercatrice del Centro Studi Movimenti di Parma, una lezione-concerto nelle classi delle scuole superiori della nostra città, intitolata “La storia siamo noi”. Il percorso prevede un racconto della storia d’Italia del Novecento, attraverso i canti popolari (per quanto riguarda la prima metà del secolo) e le canzoni d’autore (per la seconda metà): Ilaria racconta la storia e io, con la chitarra, canto dal vivo le canzoni di cui parliamo. Spesso i ragazzi fanno domande riguardo a fascismo e comunismo che, nella visione distorta dei media odierni, gli sono stati tramandati come i due poli di uno stesso concetto. Quando mi dicono questo, chiedendomi magari perché se canto Bella ciao non canto anche Faccetta nera, io rispondo che, a mio parere, per parlare di fascismo e comunismo, è necessario prima di tutto ridurre le due cose ai minimi termini e soprattutto storicizzare.
Il fascismo, ai minimi termini, è violenza. È sopruso, prevaricazione. E il fascismo italiano e mussoliniano, nello specifico, è anche il banco di prova e, più o meno direttamente, l’ispiratore delle altre grandi dittature del Novecento: quella nazista hitleriana, quella fascista franchista e quella comunista stalinista. Alla base del fascismo c’è l’idea che chi è fascista abbia il diritto di imporre la sua verità agli altri con la forza: idea che si è poi palesata nei modi del Partito Fascista Italiano al governo. Il comunismo invece, come idea di base, ha l’uguaglianza di classe, il fatto che non ci debbano essere differenze tra le persone, e che tutti devono avere le stesse possibilità.
Quando nel 1917 c’è la Rivoluzione d’Ottobre in Russia e “il popolo” prende il potere, tutti i miserabili e gli sfruttati d’Europa (e non solo) alzano la testa e pensano che, forse, c’è modo anche per loro di avere una vita migliore. Questo ha significato, nel mondo dei primi del Novecento, la rivoluzione proletaria: un sogno di uguaglianza sociale. E per questo il comunismo si è diffuso tanto, anche se, a differenza del fascismo, ha avuto forme e derive molto diverse tra loro. Se in Russia, sotto Stalin, è diventato una dittatura quasi per nulla diversa da quella fascista o nazista, in paesi come l’Italia ha avuto altre forme, come PER esempio quella partitica, del cooperativismo o delle amministrazioni locali, più vicine alla filosofia originale del concetto (come dice Giorgio Gaber, che certo non era comunista, nel suo monologo-canzone Qualcuno era comunista: «Qualcuno era comunista, perché pensava di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri»).
Detto questo poi, specifico ai ragazzi che, per quanto mi riguarda, pur disprezzando completamente l’ideologia fascista e avendo decise simpatie per quella comunista, anche se assolutamente non per il comunismo stalinista (d’altra parte, vorrei vivere in un mondo dove non è la legge del sopruso e della violenza a dominare, ma quella dell’uguaglianza), non mi considero nemmeno comunista. Anche perché fascismo e comunismo non sono i due poli di uno stesso concetto, ma due concetti completamente diversi.
A questo punto, quindi, perché canto Bella ciao e non Faccetta nera? Certo, perché Faccetta nera è una canzone fascista, ma non solo: non canto quell’orribile canzoncina perché Faccetta nera è, prima di tutto, una canzone colonialista. Un brano che, su una marcetta trionfale, inneggia alla conquista armata di un paese e alla sottomissione di un popolo. Anzi, fa anche di peggio: dice che libererà l’Abissinia dalla “schiavitù” per dare al suo popolo «un’altra legge e un altro Re». Quindi, oltre al messaggio di violenza camuffato da messaggio di libertà, c’è anche la presa per il culo.
Canto invece Bella ciao che – altra specifica oggigiorno necessaria – non è una canzone comunista, ma è invece una canzone antifascista, ed è una canzone che parla di qualcuno che si è battuto non per conquistare un altro paese, ma per liberare il proprio. Non è una canzone di invasori, ma di chi si difende da un’invasione.
Ecco quindi dove sta la “scomodità” delle canzoni di Liberazione oggi. Nel fatto che sono antifasciste, ovvero anti-sopruso, anti-violenza, anti-tutta la narrazione contemporanea dove, sempre per ridurre ai minimi termini, più sei uno sbruffone violento, più sei “giusto” (non a caso, molti capi di Stato contemporanei si comportano esattamente così) e questo tipo di narrazione è per me completamente inaccettabile.
Perciò canto ancora, e con piacere, le canzoni di Liberazione, le canzoni della Resistenza, le canzoni antifasciste. Le canto ben sapendo che la lotta armata è qualcosa di lontanissimo dalla mia concezione della vita. E per questo motivo, la più bella canzone di Liberazione che conosco non parla di guerra ma di chi le guerre le diserta.
Quindi, per rispondere alla seconda domanda di Paolo posta all’inizio, le canzoni della Liberazione non sono consolatorie. Lo sono soltanto per chi decide di chiudere gli occhi e non guardare più la realtà attorno: quella passata che converge in quella contemporanea.
Scrive fumetti e scrive di fumetti, poi scrive anche canzoni e le canta, insieme a quelle degli altri che gli piacciono. Il suo sito è www.francescopelosi.it.