In Catch-22 (Comma 22) di Joseph Heller ci sono tutti i mostri della società occidentale plasmata dalla geopolitica bellicosa del XX secolo e dalla sua lunga genealogia capitalista e proto-tale. Oh mamma, sì dirà, eccolo che riparte, che barba che noia (i.e.: che palle) con ‘sto anticapitalismo condito col sugo pronto di postmarxisti di sessant’anni fa. In effetti… Però non sono io a essere noioso e fastidioso (nel caso è una verità valida solo localmente, basta non leggermi – e quindi vado in pubblicazione sul medium giusto) è la realtà a essere spiacevolmente simile a una malcomfort di cui state, oltretutto, pagando metaforici, ma neppure tanto, mutui pluridecennali.
La violenza della guerra agita, ma più che altro subita, a distanza grazie alla tecnologia; la morte servita attraverso strumenti e oggetti spropositati; la burocrazia come fonte primaria e unica, non solo di distorta moralità, ma anche di vera e propria realtà (vedi il morto nella tenda di Yossarian, gli orari di ricevimento del maggiore Maggiori o le lettere al ciclostile del colonnello Cathcart); profittatori, «squali», ambiziosi, con agende che si realizzano con lo sfruttamento materiale dei corpi degli altri in nome di entità impersonali (la «patria», il «profitto»); il disprezzo, salvo isolate eccezioni, del genere femminile e quello dei socialmente svantaggiati e degli idealisti, il razzismo; il feticismo coprofilo e sadomasochistico dell’ordine; la vita da emarginati degli outsider, dei dissenzienti ai quali restano in mano solo le due carte dell’«inselvatichimento» kurtziano o della follia disabilitante; il trauma continuo del «servizio», che nessuno si azzarda a denunciare, a pena di una proscrizione che viene, in ultima analisi, comminata anche dal soggetto a sé stesso. Tutto questo vive in questo libro di cinquecentoquaranta pagine (che diventano cinquecentosettantasei nell’edizione del 2019) che dovreste leggere anche perché è sommamente divertente. Uno dei più divertenti che siano mai stati scritti.
E allora uno dice, ma che, dobbiamo sempre confezionarvi tutto in salsa entertainment altrimenti non vi si può presentare un quadro onesto e brutale della tragedia che è non tanto l’esistere, quanto il vivere in questa, esattamente questa, società? Lo sappiamo, il giullare è quello a cui si permette di vivere anche se ha detto quello che non doveva ma ci ha fatto così ridere… e poi è così scemo che anche se dice la verità vera verissima è così poco autorevole, con quel ridicolo berretto coi sonagli e le fattezze sgraziate. Ne I Versi Satanici però Baal il poeta viene fatto fuori perché le sue irrisioni rischiano di corrodere in modo effettivo il potere e ne Il Nome della Rosa vari fratacchioni periscono avvelenati perché non devono scoprire il testo perduto di Aristotele nel quale si loda il riso, risata, me vie’ da ride’ [cit.]. Insomma, come dice Adorno, il rifiuto della benché minima ambiguità è il tratto distintivo della personalità autoritaria. E si ride, in primo luogo, proprio per le ambiguità.
[Quanto ad Adorno prima o poi arriverà la «rece» di Minima Moralia e sarà una cosa ridicola, fatta con imperizia da un non addetto ai lavori, su un libro di settant’anni, senza ombra di nozioni sulla produzione filosofica successiva. Sarà come una brutta cover ma a me mi piace – nel senso terribile del piacere, perché l’altoborghese espiantato Theodor la butta dentro praticamente sempre, ma non come nei Saggi di un Montaigne, no, in aforismi che possono attraversare epoche barocche e preindustriali e raggiungerci come massime quasi universali, no – quella che scrive lui è una Apocalisse perfetta per l’epoca automatizzata che premeva alle porte e che ci ha finalmente, compiutamente raggiunti. Devo ancora capire quale musica abbinarci, forse qualcosa di Arvo Pärt]
Ma in Catch-22 la risata non è edulcorante o eccipiente, non è un escamotage motivante, no: è consustanziale alla tragedia. Lo è perché si afferma in modo definitivo la sproporzione tra la dimensione umana, la prestanza dell’individuo, le sue caratteristiche di destrezza e il mezzo di produzione (o meglio, distruzione) divenuto immane. La proporzione umana non può che uscirne ridicolizzata. Questo fenomeno ci spiega che la guerra tecnologizzata che diventa più letale diminuisce la rilevanza degli eroi. Se andiamo a leggere le motivazioni per la concessione del medagliame più prestigioso, come la Medal of Honor americana, ho l’impressione che troviamo via via sempre meno casi di ammazzasette alla Audie Murphy, smitragliatori solitari che falciano decine di crucchi e ne escono vivi, e più tizi che si sono sacrificati buttandosi di pancia su una granata innescata per salvare i commilitoni. Pensiamo agli «assi» della prima guerra mondiale, tutti ne conoscete almeno due (uno italiano e uno tedesco). Della seconda guerra mondiale, nessuno. Eppure nella prima l’arma aerea era poco più di una novità che animava l’eccitazione di un pubblico che immaginava questi cavalieri dell’aria a giostrare sopra il macello delle trincee. Nella seconda ha fatto milioni di morti. Nessuno ricorda il nome di Thomas Ferebee ma è l’uomo che ha preso la mira con il dispositivo di puntamento Norden Mk.XV sopra Hiroshima e ha premuto il pulsante di sgancio della Little Boy. Nessuno gli ha, appropriatamente, appiccicato l’epiteto di eroe.

Yossarian, il protagonista di Catch-22 siede nella capsula di plexiglass del muso di un Mitchell B-25, un bombardiere di medie dimensioni ampiamente utilizzato dagli americani nella seconda guerra mondiale per missioni di bombardamento tattico (da distinguere da quello strategico, eufemismo per definire ondate di centinaia, a volte oltre mille, bombardieri, ciascuno con un paio di tonnellate di bombe incendiarie o dirompenti, rilasciate a distesa sulle città, tedesche e non). Funziona così: Yossarian, nel muso dell’aereo attende che il pilota, il copilota e il navigatore portino l’aereo in prossimità del bersaglio, in volo stabilizzato, senza manovre evasive e a quel punto entra in gioco lui, o meglio, il Norden, a dire quando possono essere sganciate le bombe. Se non ci fosse stata la contraerea non sarebbe stato questo granché ma c’era la FlaK. FlugabwehrKanone vuol dire, con la solita leggerezza teutonica, cannone antiaereo, e i tedeschi produssero la migliore arma del settore nel secondo conflitto mondiale, il cannone da 88 millimetri (Flak 18/36/37/41), tanto buona anche come arma anticarro [La producevano Krupp e Rheinmetall – la seconda oggi fabbrica il cannone ad anima liscia Rh-120 da 120 millimetri che arma un bel po’ di main battle tanks, incluso l’Abrams M1A1 americano e il Leopard 2 tedesco. Come vedete certi talenti non vanno dispersi].
Trovarsi in mezzo al fuoco antiaereo voleva dire che il più delle volte ce la facevi ma qualche volta no (si stima che nella seconda guerra mondiale i bombardieri siano passati indenni attraverso gli sbarramenti antiaerei il novanta percento delle volte). Questa aleatorietà tutto sommato a favore del bersaglio era in grado di indurre livelli di stress estremi. Se non riuscite a raffigurarveli la lettura potrà aiutare. Metto giusto una foto per dare l’idea.

Certo, gli equipaggi svolgevano, inevitabilmente, una funzione di assassini volanti pronti a rovesciare, essenzialmente a casaccio, le migliaia di chili di ordigni che trasportavano. Quegli altri sotto cercavano a loro volta di ammazzarli prima che arrivassero a destinazione. Tornando al bombardiere: era l’uomo più importante nel momento topico della missione. Decideva lui quando sganciare e annunciava il messaggio «bombs away!» che annunciava al pilota che era ora di chiudere la stiva bombe e iniziare con le manovre evasive più radicali possibili per tentare di portare le chiappe a casa intere. Lo strumento di lavoro del bombardiere americano, il dispositivo Norden, nell’anteguerra era stato tenuto segreto a livelli da progetto Manhattan, anche in ragione della probabilità di errore circolare rilevata nell’ordine di ventitré metri. Durante la guerra, in condizioni di utilizzo effettivo, questa probabilità circolare è stata stimata in trecentosettanta metri. Se leggete il libro vi fate un’idea del perché.
Ho cercato di non spoilerare, perché vale la pena seguire la trama, per quanto folle e picaresca, e il percorso di Yossarian, un americano sospetto, già dal nome («assiro», si dice da qualche parte nel libro), non integrato e per niente incline a farsi integrare nel modello di «classe dirigente» che gli viene proposto.
In pratica non ho il ricordo di un abbinamento musicale rispetto a questo libro, anche perché l’ho letto e riletto varie volte. Lo recupero quindi seguendo un altro filo – quello della prosopopea mediatica che non ha mai smesso di ammantare l’esperienza bellica di una allure totalmente irrealistica. Il prodotto che realizzava questo tipo di operazione in modo più pieno era il newsreel, il cinegiornale. Trovo un paper dal titolo molto interessante, “Pitched Battles: Music and Sound in Anglo-American and German Newsreels of World War II”, ma purtroppo nessuna versione gratuita del testo completo. Qualche decina di euro per sapere cosa dice mi pare un po’ troppo – resto nella mia relativa ignoranza. Però posso dire che, da che ricordi, il sound del periodo bellico, nei racconti più o meno documentaristici, sembra essere quello del swing più che quello dell’Adagio di Barber o del War Requiem di Britten.
Entra in scena la codificazione dell’intrattenimento nel teatro di guerra, con la creazione di una nonprofit ancora in esercizio, l’USO (United Service Organization). Avete presente lo spettacolo in mezzo alla giungla in Apocalypse Now? Ecco, quello è il tipo di mestiere di cui viene investita questa organizzazione, fondata nel 1941 e ancora in attività a tutt’oggi, cosa non sorprendente vista la quantità di guerre inanellate dagli Stati Uniti negli ultimi settant’anni.
Diverse star del cinema e della musica abbandonarono le loro redditizie carriere per arruolarsi e contribuire in modi a volte artistici altre meno agli sforzi bellici degli alleati. Uno di essi fu Glenn Miller. All’inizio degli anni ’40 era all’apice del successo, un popolarizzatore del swing, accusato dai critici di avere reso il jazz popolare attraverso un approccio troppo rigido e banalizzante all’arrangiamento, apprezzato da molti per la capacità di scrivere melodie che ti si piantavano in testa, Miller riesce, all’età di trentotto anni, a farsi accettare nell’esercito che lo mette all’opera come musico, trovando una formula definitiva nel formato della Army Air Force Band, una banda di cinquanta elementi con cui tiene centinaia di concerti in Inghilterra e registra pure vari dischi agli Abbey Road studios di proprietà della EMI. Miller è sulla cresta dell’onda, partecipa anche ai programmi del servizio radiofonico del comando supremo alleato, in quel periodo il suo ufficiale comandante è David Niven, tenente colonnello inglese con, alle sue dipendenze, un maggiore americano. Il messaggio di Miller è quello America = Freedom senza il minimo dubbio che la musica fosse parte essenziale, primaria, dell’espressione di quella libertà.
Il pezzo che rappresenta il contrasto più stringente, tra quell’afflato di libertà – sincero, ci mancherebbe – e la costrizione mortale in cui si dibattevano milioni di persone è per me In the Mood, un pezzo che nei decenni seguenti chiunque avrebbe piazzato sui documentari (spesso cinegiornali rimontati un po’ come veniva) a tema Seconda Guerra Mondiale e «America Victrix». Che diamine, nella città dove sono cresciuto, sarebbe stata l’insopportabile colonna sonora di un noto commerciante locale di abbigliamento ammeregano. Si presentava, nelle pubblicità televisive sulle reti locali, guadando un torrentello alla guida di una Jeep d’epoca (quale non saprei) dalla quale sbarcava vestito come un Patton de noantri e annunciava con tono infervorato e accentaccio dialettale che aveva «spogliato l’America per voi».
Il rigore con cui Miller fa suonare i suoi pezzi non ha niente di dissimile dall’inflessibilità con cui sono congegnati i successi pop di oggigiorno. Ancora non si arrivava a quel punto ma la strada, probabilmente, era tracciata – anche il prodotto musicale si sarebbe trasformato in qualcosa di così standard da non essere più un riferimento, una traccia, ma l’unico modo possibile di eseguirlo e ascoltarlo. In the Mood rallegrava platee tra le quali si annoveravano quelli che di lì a poco sarebbero stati accolti dalle raffiche di MG sulle spiagge della Normandia. Quelli che su quelle spiagge non ci sarebbero sbarcati rimanevano una maggioranza quindi l’eco dei concerti non aveva molto di diverso da quella del tempo di pace, non fosse per il fatto che c’erano tutte quelle divise. Alla fine, anche per quelli che avevano superato le spiagge, apparve conveniente non alzare troppo la mano per raccontare una realtà diversa, per la quale In the Mood, ma anche gli altri cavalli di battaglia, Chattanooga Choo Choo, Moonlight Serenade, Pennsylvania 65000, e così via, non potevano andare, proprio per niente. Non a caso, David Niven evitò in modo accurato di parlare dell’esperienza di guerra per tutto il resto della sua vita nel rapporto con i media. Come lui molti dei reintegrati nella società civile americana sfruttarono le opportunità fornite dal clima economico e culturale e da misure come il GI Bill che avevano lo scopo di reintrodurre (Servicemen’s Readjustment Act recita il titolo ufficiale della legge) i reduci nella produttivissima società del boom.
Glenn Miller non tornò mai – non mise neppure piede in Francia. Scomparve da qualche parte sulla Manica il quindici dicembre del 1944, in un pomeriggio freddo e umido. Nessuno trovò mai traccia del piccolo monomotore su cui viaggiava (effettivamente non autorizzato, avendo accettato un «passaggio» che non avrebbe dovuto accettare). Scompare come uno dei personaggi di Catch-22, in modo un po’ più solitario e nordico – nel libro, dell’aereo scomparso si perdono le tracce in una nube al largo dell’isola d’Elba in un pomeriggio altrimenti di bel tempo.
Heller le cose che scrive le scrive con cognizione di causa – il posto del bombardiere sui B-25 lui l’aveva occupato, essendo di stanza in Corsica, per sessanta missioni, anche se la maggior parte di quelle missioni, a sentir lui, altro non erano che milk runs, compiti di mero trasporto. L’accoglienza da eroe riservatagli al ritorno non deve essergli piaciuta, a giudicare da quello che ha scritto nella sua opera più famosa. Certo, non mi risulta che nessuno che sia sopravvissuto, che ne so, a Stalingrado, abbia scritto opere satiriche sulla guerra, forse è una questione di scala – la guerra vista dalla fittizia isola di Pianosa di Catch-22 è comunque un posto nel quale puoi ascoltare In the Mood al grammofono tra una missione e l’altra – però mi viene in mente che un grande amico di Heller fu uno che l’ordine di magnitudine della guerra moderna l’aveva sperimentato appieno. Si chiamava Kurt Vonnegut ed era americano pure lui.
Forse avevamo bisogno della satira spietata dei vincitori su sé stessi come anticorpo culturale. Per me è andata esattamente così.
In questa puntata abbiamo chiamato in causa:
- Joseph Heller, Catch-22, edizione italiana Bompiani, 2019 (la mia è una ristampa di non so quando dell’edizione del 1986)
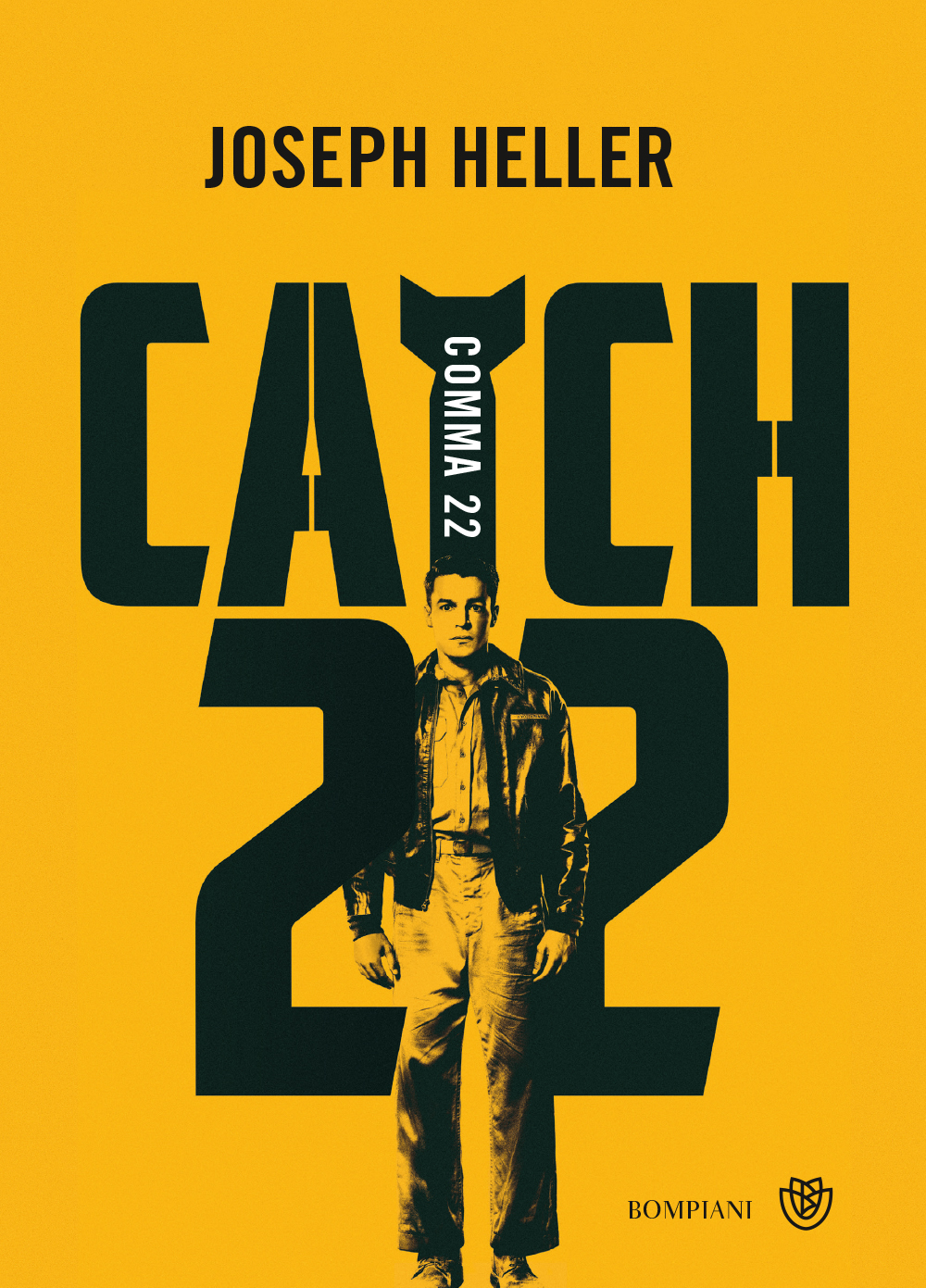
- Glenn Miller Orchestra, In the Mood
È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.



