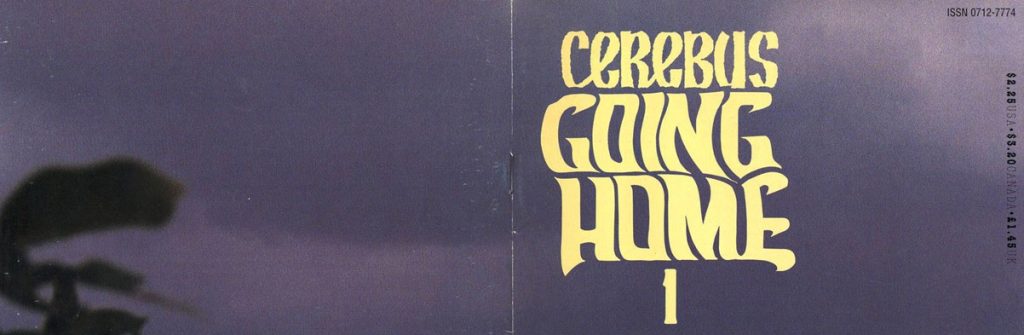Yasunari Kawabata lo hai già incontrato su queste pagine. Oggi ti parlo del suo ultimo romanzo, Denti di leone, del 1972. Rimasto incompiuto per la morte (forse per suicidio) dell’autore, fu pubblicato su una rivista letteraria, prima a puntate e poi integralmente, dopo un editing da parte del genero di Kawabata. Da noi è arrivato solo nel 2019, per Mondadori.
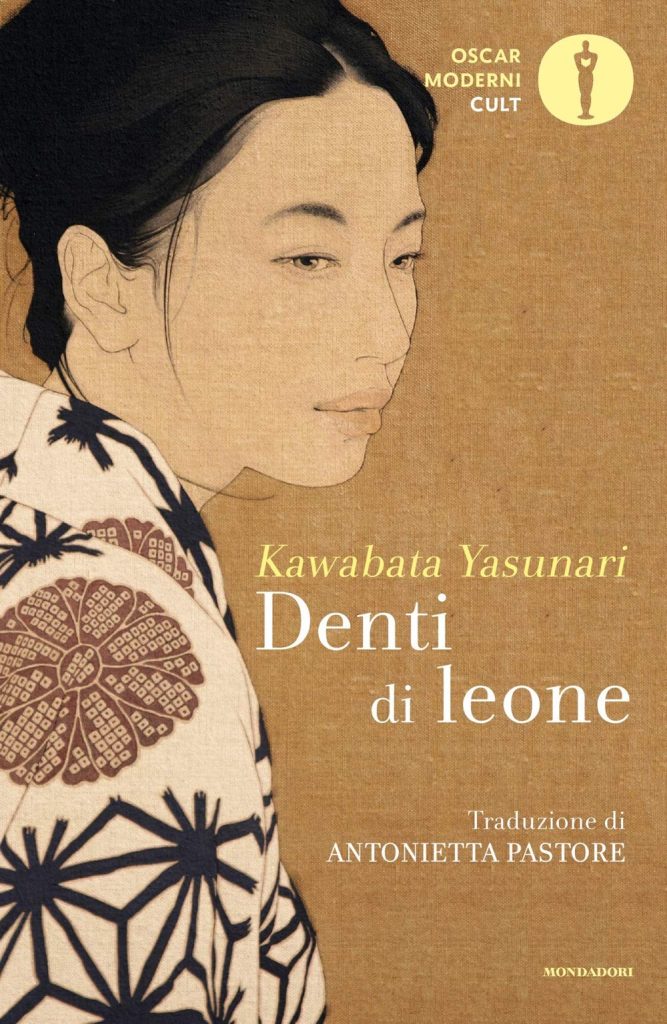
Ineko è giovane e bella. Ed è affetta da asomatognosia. Per quel poco che so (anzi, nulla: tocca andare su Google) si tratta di «incapacità da parte di un paziente di riconoscere una parte o tutto il suo corpo come parte di sé, in seguito a una lesione cerebrale localizzata». Ineko, invece, soffre di questa sorta di cecità selettiva verso la persona amata: alla sua vista, all’improvviso, scompare il corpo del fidanzato Hisano, precipitandola nella disperazione.
Ora, siamo a Ikuta, città in collina caratterizzata da ampie distese di denti di leone. E da una clinica psichiatrica. Durante la giornata, dalla clinica si odono i rintocchi di una campana. La suonano i pazienti, a rotazione. È usanza che i nuovi degenti si vedano assegnato il compito nel giorno del loro arrivo. I medici pensano che questo possa avere un effetto terapeutico. Il romanzo non servirà a sciogliere il dubbio sull’utilità effettiva del rito, in termini di cura o anche solo di sollievo.
Comunque sia, Ineko è lasciata nella clinica dalla madre e da Hisano. I due si incamminano sulla via del ritorno, a tratti rincuorati proprio dai rintocchi della campana, e cominciano un dialogo sulle condizioni della ragazza. Hisano condivide a fatica la decisione del ricovero. Ama moltissimo Ineko, vorrebbe sposarla, è convinto che il matrimonio potrebbe aiutarla, crede che il suo amore potrebbe guarirla. La donna, invece, ritiene che sarebbe sbagliato per entrambi se Hisano sposasse una ragazza affetta da malattia mentale, per quanto lieve.
È Hisano a convincere la donna a non fare ritorno immediato a Tokio. I due si fermano in un albergo di Ikuta, con l’intenzione di fare visita l’indomani a Ineko. La strana coppia passerà un’intera giornata assieme, parlando del passato della ragazza, cercando un motivo della sua malattia e confidandosi reciproche speranze.
Ma veniamo al climax della rubrica. Che stavolta, te lo dico subito, sarà particolare. Perché ha origine, sì, proprio dalle ultime righe del romanzo, ma NON saranno queste le righe da tradurre e tradire…
«Durante l’amplesso, Ineko non teneva gli occhi aperti. Li chiudeva senza rendersene conto. In quei casi, non c’erano problemi, ma quando gridava: “Ah, non ti vedo, non ti vedo più!”, aggiungendo poi: “Coprimi le palpebre”, e lui lo faceva con le mani o con le labbra, l’effetto era diverso… Se chiudeva gli occhi spontaneamente, conservava l’immagine di lui, ma se a coprirglieli era Hisano, la perdeva definitivamente.»
È qui che si innestano le due parole che finiscono nel mirino del Tradrittore. Perché qualcuno (l’editor italiano, il genero di Kawabata, vedi te) HA SCRITTO:
[testo incompiuto]
Così, tra parentesi quadre. E stavolta una semplice olofrase (vabbè, quasi: son due parole, non avvitarti sulla semantica…) diventa, più che qualcosa da tradurre o tradire o interpretare col consueto “VOLEVA DIRE”, ciò che dà un senso alla lettura di un’opera incompiuta, andando oltre la semplice “comunicazione di servizio” dell’editor.

Seguimi. Torna ai dialoghi fra Hisano e la madre della ragazza, lunghi, estenuanti, cervellotici e ridondanti. Non è dato sapere se Kawabata, avesse potuto, li avrebbe limati in stesure successive. Però, ti dico, ho l’impressione che fosse sua intenzione mostrare quel dialogo così, pacato quanto privo di punti d’incontro. La comunicazione tra i due personaggi è cortese, affettuosa, reciprocamente rispettosa, ma priva di sincera comprensione, viziata com’è da un contrasto di fondo. Che i due siano entrambi tesi alla ricerca del bene della persona amata (figlia o amante che sia) è ininfluente. La donna nega che l’amore possa sanare la malattia della figlia. L’uomo pensa che solo l’amore possa.
La madre proviene dalla generazione ferita dalla guerra. Sullo sfondo, una tragedia familiare solo parzialmente metabolizzata, la tragica morte del padre di Ineko, il colonnello Kizaki Masayuki. Quella morte ci parla di un Giappone scomparso, certo, ma soprattutto ci indica un possibile inizio del disagio della figlia. E quei drammi, nella mente della madre, sembrano impedire qualsiasi speranza per il futuro.
Ineko non appare mai, se non in pochi flashback. La conosciamo attraverso due interpreti non concordi, fidanzato e madre, che la raccontano e cercano di interpretare il suo disagio col filtro dei rispettivi sentimenti.
Ineko, insomma, è un’ombra. Ed è così che rimane, come i rintocchi della campana della clinica restano un’eco lontana, vibrazioni di anime segnate dalla malattia. Suoni che chiunque può interpretare come crede, grida di dolore o voci di speranza, ma nella sostanza incomprensibili. Pure l’intero romanzo, al netto delle vicende narrate, è segnato da una tragedia, la morte di Kawabata. Non ha un incipit particolarmente azzeccato e del finale ti ho già detto:
[testo incompiuto]
Non possiamo sapere quanto avrebbe inciso una revisione dell’autore, o se esista un finale stracciato perché da rivedere. Ma l’effetto resta: il testo rimanente è un finale non tanto “mancante”, quanto “scomparso”. Proprio come il corpo di Hisano dalla vista di Ineko, o come Ineko stessa dalle pagine.
La chiave interpretativa di Denti di leone sta nella magia di quelle diverse dissolvenze. Una magia forse maligna, ma pur sempre una magia, che rende la lettura di Denti di Leone, non facile né “piacevole” in senso tradizionale, qualcosa di diverso. Una lettura ipnotica come l’eco di una campana lontana. Sfuma anch’essa nel silenzio e nel mistero.

Vive una crisi di mezza età da quando era adolescente. Ora è giustificato. Ha letto un bel po’ di fumetti, meno di quanto sembra e meno di quanto vorrebbe. Ne ha pure scritti diversi, da Piazza Fontana a John Belushi passando per Carlo Giuliani (tutti per BeccoGiallo) e altri brevi, specie per il settimanale “La Lettura”. Dice sempre che scrive perché è l’unica cosa che sa fare decentemente. Gli altri pensano sia una battuta, ma lui è serio quando lo dice.