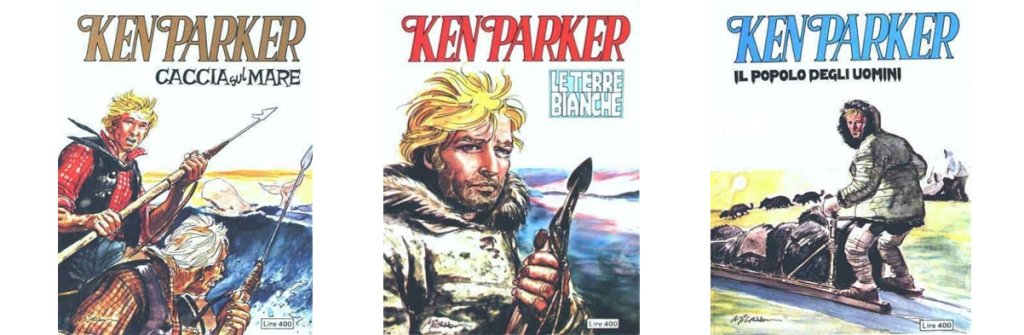Il tema di questo mese potrebbe invitare, in modo quasi didascalico, a seguire uno tra due principali possibili percorsi. Da una parte quello della denuncia del pregiudizio verso il soggetto di cui si è sempre detto che non potrà mai perdere lo stigma del vizio, per quanto cambi coiffure, condannandolo a una sempiterna, automatica reprimenda e quello, quasi perfettamente opposto (ma è più un quinconce che un centottanta gradi) dell’ineluttabilità, della inveterata e immutabile, inerentemente viziata natura dell’animale in questione. L’allegorico lupo per dire uomo. Ciao, Hobbes.
Potrei partire con un pippone sul Leviatano e che aspetto e conformazione abbia in quest’epoca contemporanea ma di questo ho già scritto, in sostanza, in tutte le precedenti trenta puntate (più, probabilmente, anche le sei della rubrica Interni). Risparmiamovelo [sic].
Oggi mi trovo nella condizione di non sapere bene che partito prendere, tra le due polarità non perfettamente in asse. Sicuramente, la coazione a ripetere è una delle caratteristiche più spiacevoli dell’essere umano – e si commette un torto mostruoso a raccontar storielle sul lupo o su ingrati serpenti/scorpioni che, seppur aiutati dalla vecchietta, la pungono mortalmente, perché l’ineluttabilità della predazione, dell’attacco mortale, non è neanche poi così certa, e, in generale, l’animale, una volta che ha la pancia piena e non teme per la propria incolumità, può anche passare la mano – ed è tanto più spiacevole nella misura in cui viene presentata dai soggetti umani in cerca di discolpa o da chi tenta di manovrarli nel modo più deterministico possibile. Si tratta sempre di una giustificazione o di un punto debole da sfruttare, per ottenerli o farci leva non si trova di meglio che diffamare qualche animale.
La cosa abbastanza imbarazzante poi è che, a livello collettivo, produttivo, oserei dire, uno dei mantra dell’epoca contemporanea è quello del Change Management organizzativo. Ma, santa pazienza, se la gente non cambia mai, di quale cambiamento staremmo parlando? Probabilmente quello del verso in cui gira il mulo o del modo in cui l’abbiamo attaccato al basto del carro o della macchina del caso. Questi cambiamenti producono spesso benefici economici per chi possiede il macchinario ma potrebbero essere peggiorativi per chi ci vive attaccato.

Catechismi del cambiamento per esseri estensivamente accusati di non riuscire a cambiare. A che gioco stiamo giocando?
Il cambiamento è visto spesso con sospetto, dà fastidio sempre e fa male in modo particolare quando si desidera che avvenga, per tornaconto personale, e poi non avviene. Che gli altri cambino veramente non ci interessa. Esempio: io vorrei che tutti diventassero più attenti e sensibili verso l’ambiente, nella gestione dei rifiuti, nella cura degli spazi e dei beni comuni, ma lo spero, più che per loro, perché possano diventare degli individui migliori e meglio inseriti in una armonia del vivere insieme, per me, perché mi sono rotto le palle dello spettacolo disarmante dell’impune smerdare collettivo.
Magari mi sarà capitato di trovarmi a deplorare certi mali della società in conversazioni con individui che buttano via le vernici vecchie nello scarico del lavandino o i piccoli elettrodomestici nell’indifferenziato (anche se sono sicuro che riescono a farlo anche nell’umido). La conversazione andava, verso un consenso – ma in realtà eravamo nemici su fronti opposti che non si stavano riconoscendo. Molto spesso il patto sociale resiste perché non riconosciamo i nostri nemici – o meglio, per uno che, come me, volesse fare un discorso in termini di bene comune (ancorché in una prospettiva di preferenze personali), i nemici della società stessa (aperta, chiusa o semiaperta che sia).
Al povero Popper che ci diceva che non si può pensare di tornare indietro alla società chiusa vagheggiata da Platone, rispondono in quest’epoca tanti, troppi, zozzi epigoni dello spirito antidemocratico, ancorché non esattamente platonico, in un casotto globale in cui ognuno tenta di tracciare confini dettati da un puro spirito di omofilia. Se anche tu pensi che il presidente X sia uno strumento del divino per sventare il satanico complotto del partito Y, prendi il tuo fucile semiautomatico AR-15, un po’ di abbigliamento tattico militare e vieni con noi nel nostro ranch nelle Catskills, insieme sconfiggeremo i nostri nemici. Attenzione, però, ché funziona anche se ci metti dentro ingredienti più raffinati. Non è che se presiedi la debate society di una università Oxbridge e rimani a quello hai risolto qualcosa, se non per il tuo CV. Sarai socialmente meno pericoloso, almeno in prima battuta – tutto sta nel vedere se poi, decenni dopo, ti ritrovi nell’agone politico, magari come primo ministro, ma lasciamo stare.
Quindi, sì, il vizio è inerente. Non mi sento proprio di dare dello scemo a Isaiah Berlin, quella storia del legno storto kantiano risuona sempre giusta, ma ci sta che sia un po’ omofilia anche la mia, perché in de Maistre, per quel che poco che ne so, ho sempre individuato un antesignano di quel marzapane ideologico Dio-Patria-Famiglia di cui sono fatti tutti i fascismi occidentali. Qualcuno ci vede un padre nobile del conservatorismo. Fate un po’ voi, sul tema dei paradossi della tolleranza hanno scritto e detto tanto in tanti ma ci sono posizioni con cui non vedo, perché non può esistere, conciliabilità. [Su de Maistre e la fascio-erotizzazione del solito mito più o meno platonico di un’epoca in cui gli uomini erano veri uomini dovrò tornare ancora, nel prossimo pezzo di Interni, siate avvertiti]
Abbarbicarsi agli usi e costumi, anche quelli che non si sono mai avuti ma che troviamo lì per lì accessibili per poter rivendicare una appartenenza, un senso di identità, è un meccanismo sempre a portata di mano, un ottimo refugium peccatorum, specie per i figlioli più prodighi e per le pecorelle più smarrite. Nell’ambito musicale, per fortuna, il concetto di tecnica prescinde, almeno in parte, da connotazioni religiose e identitarie – si cerca di mettere mani e testa sugli strumenti secondo dettami che appaiono sensati, intorno ai quali si genera un consenso nella comunità professionale prima, e in quella dei musicanti da salotto poi. Però non è che tutti insieme si procede, evolutivamente, verso un miglioramento continuo – eh, no. Ci sono almeno due livelli di fallimento, uno che riguarda più i docenti e insiste sulla scarsa disponibilità a cambiare approccio didattico («a me hanno insegnato così», quando magari è un po’ di tempo che sulle diteggiature su cinque tasti non si insiste più come una volta) e uno, plebiscitario, che affligge chi dovrebbe imparare e gli fa dire «ma io mi trovo bene così». Se il primo viene mitigato dall’apertura mentale di chi insegna, per il secondo ci vuole un lavoro del soggetto su sé stesso non banale. Perché si tratta di riconoscere che suoni male. Quasi tutto e quasi sempre – che la butti dentro, in termini di correttezza esecutiva e interpretazione, molto raramente.
L’errore sta nel considerare l’inadeguatezza performativa il vizio. Quando invece lo è l’indisponibilità a farsi un giro a Canossa, anche una Canossa solitaria, per provare a migliorare.
La prima fase è il rifiuto, anche per un bassista da salotto – però poi vorresti suonare le cose un po’ più fighe e allora metti in scena piccoli compromessi per cui ti dici che tutto sommato, forse, ci arrivi quasi e non è malissimo neppure così.

Non basta suonare le note. Ti sembra di arrivarci ma stai arrancando. La risolvi facendo un po’ la volpe (altro animale che subisce abusi allegorici) e l’uva, dicendoti che in fin dei conti poi non la suoni mai con nessuno quella cosa un po’ più difficile che ti sei studiato e la lasci stare per un po’.
Se, e dico se, dopo un po’ di tempo sei riuscito a digerire un minimo di percorso di esercizi di tecnica, di rafforzamento della muscolatura delle dita, di miglioramento della destrezza e della coordinazione, di apprendimento di stili che non avevi mai frequentato, di lettura (e intendo la lettura vera, non quella delle tab, che tutti le usiamo ma probabilmente arrivano sì prima ma poi fanno solo male, come il glutammato di sodio), insomma se studi, deve passare un po’ di tempo ma poi scopri che sei migliorato. Che i passaggi difficili a velocità medio-alte riesci a farli un po’ meglio. Ancora non suona benissimo ma sei meno concitato, meno in sofferenza, e scopri che le mani viaggiano molto meglio e danno meno preoccupazioni alla testa che può concentrarsi su cosa arriva tra un attimo (la dimensione ansiosa e terrificante della musica suonata davvero).
Sarai appagato per il relativo progresso? Ni.

Non lo sarai, per due ottime ragioni (oggi gli argomenti sono un po’ tutti binari – deve essere un segno di declino cognitivo più che di manicheismo): quello che prima ti veniva male, adesso ti viene un po’ meno male e, al contempo, ci sono cose che, come non ti riuscivano prima, oggi continuano a essere inarrivabili. Anzi, te le vai a proprio a cercare. Altro che centro di gravità permanente, non appena guadagni un guizzo di fiducia esci di scatto dalla trincea a farti falciare dalle mitragliatrici nella terra di nessuno.
Molti risolvono dicendosi quanto sono fighi perché magari hanno acquisito a repertorio un qualche feticcio (di solito è vizio da chitarristi, ma non solo) oppure solo dicendoselo e credendoci. Certo è che nel microcosmo musicale la voglia di apparire bravi supera in modo esponenziale lo stesso desiderio riferito alla società in generale. «Bravo cittadino» oggi ha un po’ lo stesso appeal di «coglione idealista» o «rompipalle perfettino». Il perché, lo conosciamo tutti: gli è che non c’è nessuna claque adorante, nessuno a dirtelo, «bravo». Né dovrebbe esserci, del resto. Invece, meglio annusarsi il culo a vicenda e farcisi su dei complimenti in contesti tribali.
Devo aver già citato quella storiella del violoncellista Pablo Casals due o tre volte qui, ma mi piace parecchio. Uno che a novant’anni dice che ancora studia perché «sento che sto migliorando». In quanto nani che faticano anche solo a salire sulle spalle di altri nani – i quali raramente sono d’accordo, tra l’altro – evitiamo di frequentare i giganti, quelli con uno sguardo più lungo, perché sono andati materialmente più avanti, principalmente perché ci fanno sentire sminuiti. Li accettiamo solo comportandoci da fan, da adepti. In realtà, una mezz’ora di studio al giorno – studio sensato – senza particolari legami emotivi con nessun modello o profeta, ti rende clamorosamente migliore nel giro di pochi mesi, invariabilmente. Eppure ci dà un gran fastidio che la soluzione sia così semplice, e ci intruppiamo ostinatamente in ragionamenti sul setup dello strumento, le corde, l’amplificatore, lo sapete, sempre la solita roba, sempre il solito dare la colpa a degli oggetti e a citare guru e dispute bizantine a casaccio. Non ci piace che la soluzione sia avere quel tanto di fiducia in sé stessi e quella disponibilità al compromesso che, insieme, ci possono garantire di progredire, anche se con dei limiti. Tutti noi, anche quelli che imbracciano il basso in salotto, ci s’ha qualcosa di smodato dentro che vorrebbe non si è capito cosa, mentre di tappe intermedie ce ne sono tante e pure interessanti. Provo spesso a ricordare che tutti i musicisti professionisti che conosco non sono mai contenti di come suonano, soffrono dello stesso male essenziale di cercare di migliorarsi e spesso tornare alle forme più essenziali per sperimentare il senso di un «meglio». Insomma, se non si è capito, nella musica suonata non pare esserci un porto in cui sbarcare, solo mare sempre più aperto. In quella prodotta industrialmente per essere venduta ci sono altri parametri, del tutto alieni, di cui penso di non sapere proprio niente.
Il nemico lupino, in fin dei conti, non è altro, non è fuori – è solo l’esternalizzazione di un tentativo di far coesistere entrambi i termini della polarità che credevo di avere individuato. Lasciami continuare a essere come sono, la mia invarianza è dettata dalla natura. Ma anche: ricordati però che non sono un lupo, sono una persona. A questo gioco giochiamo con noi stessi, in continuazione, ne sono convinto – a parte i forsennati che non si ritengono né lupo né umano ma qualcos’altro, para-divino – per smarcarci da quel che ci assilla, senza troppo successo.
Per usare uno dei miei rari (e assai prevedibili) riferimenti al mondo del fumetto, siamo su quel piano concettuale per cui non ci sono dubbi sul perché Calvin e Hobbes si chiamino esattamente Calvin e Hobbes. Siamo sempre lì a ragionare in termini di predestinazione e cattive inclinazioni. Scherzarci su ci va bene, ma a patto che siamo noi stessi a farlo, o, al limite, figure «deboli», immature o immaginarie come un bambino e il suo amico tigre ghiotto di sandwich al tonno.

In un’altra zona della capoccia mi viene da ricordare che Bach, fino alla riscoperta guidata da Mendelssohn, fu sostanzialmente riconosciuto come virtuoso (segno che anche nel ‘700 si tendeva a fare caso a quante più note riuscivi a buttare dentro l’unità di tempo e con posizioni e diteggiature difficili) più che come compositore, per essere poi dimenticato per qualche decennio, conservato e tramandato con un livello di cura non ideale neppure da parte dei suoi figli e discendenti.
Sarebbe stata una gran perdita (e chissà che non ne abbiamo subite di simili, o anche peggio) non avere nozione dell’opera di J.S., ma quello che immagino, e spero, è che lui si sia potuto divertire un mondo a suonare quello che gli andava di suonare, senza essere divorato dall’ambizione di essere necessariamente tramandato e ricordato.
È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.