(considerazioni sui diari di viaggio da Bruce Chatwin a Guy Delisle)
Originariamente pubblicato su “Bistrot Babeuf”

Quando Bruce Chatwin arriva a Buenos Aires nel dicembre del 1974, è appena cominciata l’estate australe e, lo dice lui stesso nelle prime pagine del suo In Patagonia, nella calda aria inquinata della città si respirano i prodromi di un ormai prossimo golpe. Non è che ci volesse un genio per capirlo. Isabelita Peron, succeduta nominalmente alla presidenza del paese dopo la morte del marito nel luglio dello stesso anno, ma in realtà figura fantoccio nelle mani del segretario di stato Josè Lopez Rega (terrorista di destra, esoterista e membro della P2 di Licio Gelli) ha istituito –in novembre- lo stato d’assedio per far fronte ai gravi disordini dovuti a una lunga serie di attentati terroristici (la maggior parte compiuti da un’organizzazione che faceva capo allo stesso Rega). Quello che sarebbe successo nei due anni successivi lo si poteva tranquillamente intuire già allora.
Ma le questioni politiche e sociali, in fondo, a Chatwin non interessano. Non ha molto tempo. Deve girare in pochi mesi Argentina e Cile per poi tornare a Londra e tirarci fuori un libro che lo renderà ricco e famoso.
In quel libro non lo racconta, ma qualcuno gli ha detto che lo storico «anarquista y pacifista a ultranza» – come lui stesso si definisce – Osvaldo Bayer è il più profondo conoscitore della storia della Patagonia. Fa un salto a trovarlo a casa sua, nel quartiere di Belgrano, e gli chiede se può fornirgli una bibliografia sulla Patagonia. Solo libri di viaggio, di curiosità, di leggende, magari qualche biografia di bandoleros, ma per carità niente sociologia, etnografia e politica. «Ce lo mettiamo un bel libro di scioperi, dai?», gli chiede Bayer. «Uh?», dice Chatwin, «di scioperi…?». «Sì», ribatte Bayer, «storie di gauchos, peoni e anarchici». «Ah!», fa sollevato Chatwin, «Sì, gli anarchici sì, fanno folclore.». Bayer allora gli riempie lo zaino di libri e ci ficca pure la sua monumentale storia in tre volumi del lungo sciopero insurrezionale dei peones anarchici che scosse, nel 1921, tutti i latifondi patagonici: Patagonia Rebelde (lo trovi in una bella edizione ridotta e curata e tradotta nel 2009 da Alberto Prunetti, per Eleuthera – parte di quello che ti sto raccontando viene dalla sua introduzione al libro).
Poi si salutano. Chatwin parte per la Patagonia. Tre settimane dopo è già di ritorno a Buenos Aires e gli restituisce tutti i libri.
Tra il 1975 e il 1976, quando Videla e la sua giunta militare portano a compimento il colpo di stato, Osvaldo Bayer, già a lungo osteggiato e perseguitato negli anni precedenti dalle forze governative e militari proprio per quel suo libro, deve abbandonare l’Argentina e rifugiarsi a Berlino.
In Patagonia, il libro che Chatwin trarrà da quel suo viaggio, lo sai, uscirà nel 1977 e sarà un successo straordinario, capace di trovare lettori ininterrottamente fino a oggi. Poco prima dell’uscita del libro Chatwin stranamente pubblica, sul numero del 31 dicembre 1976 del “Times Literary Supplement”, una lunga recensione del libro di Osvaldo Bayer.
Prima di raccontarti quello che Chatwin pensava dell’opera di Bayer (se hai fretta puoi andartelo a leggere da pagina 137 a pagina 151 dell’edizione Adelphi di Anatomia dell’Irrequietezza, dove la recensione è stata raccolta postuma), devo però parlarti del libro di Bayer.
Nell’Estado Burocratico Autoritario, come il politologo Guillermo O’Donnell definì la dittatura militare che tenne il potere in Argentina dal 1966 al 1973, tutti i partiti politici erano stati soppressi. Non stupirti quindi se affermo che fu sicuramente un atto di coraggio la decisione dell’avvocato Felix Luna di fondare nel 1967 a Buenos Aires una nuova rivista di divulgazione storica: “Todo es Historia”. Racconta lui stesso che la necessità di fondare quella rivista gli era sembrata evidente quando aveva capito che, benché il governo avesse proibito ogni attività politica, questo non bastava a spegnere le preoccupazioni e le idee politiche della gente. Solo non c’erano più luoghi dove esprimerle e confrontarle. Allora si era chiesto a cosa la politica fosse più prossima. Ovvio, si era risposto, alla storia.
Allora, fatto.
Non è un caso che tra i primi collaboratori della rivista ci fu Osvaldo Bayer che praticamente da subito affrontò con un lungo saggio uno dei più radicati – a causa delle forti corrispondenze con il presente – tabù della storiografia argentina.
Durante la Prima Guerra Mondiale il prezzo della lana era andato alle stelle. L’estremo sud dell’Argentina, quella gelida e desolata terra che chiamano Patagonia, aveva visto una crescita esponenziale degli allevamenti di ovini, i quali erano arrivati a occupare quasi tutte le terre con la conseguente creazione di vastissimi latifondi quasi tutti nelle mani di proprietari inglesi e nordamericani. Le condizioni delle migliaia di peones che vi lavoravano avevano raggiunto livelli intollerabili. Per capire quanto dovessero essere terribili basta leggersi le richieste sindacali che i lavoratori rurali, che lavoravano 16 ore al giorno per sette giorni la settimana, avevano presentato nel novembre del 1920 alla Società Rurale che rappresentava la categoria dei latifondisti.
- un letto di pagliericcio invece dei tavolacci
- non più di tre lavoratori per ogni alloggio da 4mt x 4mt
- un pacco di candele al mese
- libertà al sabato sera per fare il bucato personale
- scritte in castigliano e non in inglese sulle cassette del pronto soccorso.
La Società Rurale rifiutò. I lavoratori risposero con quello che diventerà uno degli scioperi generali più lunghi della storia. I padroni licenziarono tutti gli scioperanti e mandarono polizia e vigilantes a braccarli. I lavoratori trovarono in quattro anarchici molto diversi tra loro Alfredo Forte, Josè Aicardi, Antonio Soto e Josè Font capacità aggregativa e organizzativa. In poco tempo organizzarono la resistenza e cominciarono a rispondere alle violenze.
Nel gennaio del 1921 lo sciopero diventò insurrezionale.
Durerà un anno. Resisterà per mesi all’attacco dell’esercito. Finirà sotto la spietata campagna del colonnello Varela, finanziata e istigata da Inghilterra e USA che non avevano intenzione di rinunciare ai latifondi, che si conclude con il massacro di 1.500 operai.

Sul numero doppio 14-15 di “Todo es Historia” (uscito nell’autunno australe del 1968) Osvaldo Bayer pubblica il saggio Los vengadores de la Patagonia tragica in cui racconta, con una precisissima analisi documentaristica, questi fatti.
Negli anni successivi continua la ricerca storica e tra l’agosto del 1972 e l’inizio del 1974 pubblica tre ricchissimi volumi (per circa 1600 pagine) con il titolo definitivo di Patagonia Rebelde.
Proprio nel 1974 il regista Hector Olivera realizza addirittura un film ispirato all’opera di Bayer con lo stesso titolo.
Per averlo scritto Osvaldo Bayer comincia a essere perseguitato dai servizi segreti e il suo nome viene incluso in una lista di condannati a morte redatta dal gruppo terrorista di estrema destra Triple A che fa capo al segretario di Stato Josè Lopez Rega.
Con il colpo di stato del 1976 Bayer è obbligato all’esilio e tutte le copie del suo libro che la sbirraglia riesce a trovare finiscono con gli altri libri ritenuti sovversivi nei roghi divenuti comuni in quegli anni a Buenos Aires. La storia di come Bayer riuscì a recuperare il manoscritto per farne un edizione tedesca in lingua spagnola nel 1978 da sola meriterebbe un romanzo. Un’altra volta magari.
Fin qui quello che avevo da dirti sul libro di Bayer. Adesso torniamo alla recensione che, come ti dicevo, ne fece Chatwin.
Pur considerandolo un grandissimo scrittore – posso dire di avere consumato a furia di rileggerle le mie edizioni Adelphi di In Patagonia, Il Viceré di Ouidah e Le vie dei Canti – non ho mai nutrito particolare simpatia per Bruce Chatwin. La sua vera natura narcisistica e, a mio avviso, reazionaria è mostrata senza remore soprattutto negli scritti minori. Illuminante in questo senso è la raccolta postuma di articoli vari (dagli anni sessanta alla sua morte nel 1989) curata da Jan Borm e Matthew Graves e pubblicata nel 1996 sotto il titolo di Anatomia dell’Irrequietezza. In cui è inclusa anche, la sua recensione a Patagonia Rebelde di Osvaldo Bayer.
Per farti capire quale livello di malafede raggiunge Chatwin in quello scritto dovrei fare un’analisi comparata della lunga recensione e mostrare tutti i punti in cui mente a proposito del testo di Bayer. Ma io sono uno che blatera gratis e quindi, visto che non mi paga nessuno, te la faccio breve e risparmio il tuo tempo e il mio.
Con un’acrimonia apparentemente inspiegabile Chatwin attacca il lavoro di Bayer definendolo una lunga tirata retorica e ideologica contro i latifondisti inglesi che aveva acquistato le terre patagoniche dal governo argentino ed erano poi stati abbandonati alle violenze dei peones. Dopo una descrizione della gente della Patagonia così carica di disprezzo da far pensare che durante il suo viaggio qualcuno gli avesse rubato il portafogli, Chatwin dice che Bayer trascura nella sua analisi storica quella nota parte del carattere dei peones patagonici per cui «il loro ritegno esplode d’improvviso di una frenesia di sesso, di bevute e di violenza».
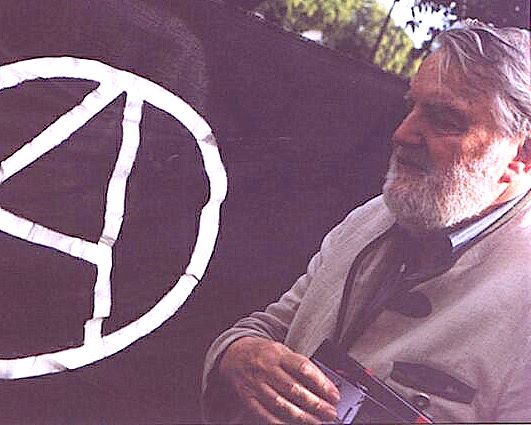
Poi. Uno dei punti cardine dello studio di Bayer è la dimostrazione indiscutibile della falsità delle accuse mosse dalle autorità argentine – per giustificare il massacro – a quelle cilene e poi a quelle russe, di aver provocato sostenuto e finanziato i rivoltosi. Chatwin sostiene che su questo Bayer sbaglia perché le autorità di frontiera argentine gli avevano assicurato dell’esistenza di documenti che dicono il contrario. Ovviamente, a differenza di Bayer, questi documenti lui non li cita e non li mostra. Ma il momento più alto lo raggiunge quando, in chiusura, millanta di aver conosciuto a Punta Arenas, dove si era rifugiato per fuggire alla fucilazione, un vecchio tosatore di pecore scampato al massacro che gli avrebbe raccontato che i capi dello sciopero, quelli non erano mica lavoratori, non avevano lavorato un giorno in vita loro, perché erano baristi, barbieri, artisti!
C’è da chiedersi perché Chatwin sentì la necessità di pubblicare uno scritto così feroce contro Bayer e contro gli anarchici come Antonio Soto che avevano condotto gli scioperi e la rivolta in Patagonia? Perché uno che come lui si considerava un nomade, quindi – a portare alle estreme conseguenze quanto sosteneva nei suoi scritti sul nomadismo – il discendente di quei pastori vagabondi senza preoccupazioni di ordine politico e sociale, mostra una così spiccata simpatia nazionalista per quei latifondisti che stabilivano ordine, gerarchia e proprietà?
Probabilmente perché Chatwin come ci spiega Paul Thereux nel suo Chatwin Revisited (Granta, giugno 1993), non era quello che diceva di essere. Cioè un viaggiatore. E gli serviva quindi screditare da subito, prima che In Patagonia uscisse, l’unica persona che sapeva come l’aveva realizzato quel libro. Un ottimo lavoro, racconta Bayer, di splendida struttura narrativa ma non il diario di un viaggiatore, semmai il solido romanzo di un abile cocinero. Cioè di uno che aveva saputo dosare alla perfezione in una nuova struttura (sostengono i malevoli soprattutto grazie alle competenze della sua editor Susannah Clapp) gli ingredienti presi nei libri che lui gli aveva prestato.
Per quanto gli piacesse darsi giustificazioni alla Montaigne o alla Ibn Battuta non riesco a trovare nei suoi libri una cosa fondamentale che, ritengo, deve esserci negli scritti di ogni viaggiatore. La consapevolezza, come diceva un altro grande viaggiatore a me sentimentalmente più vicino Ryszard Kapuscinsky, che quando scrivi del tuo viaggio non puoi sfuggire alla responsabilità di qualcosa (L’altro, Feltrinelli, 2007). Quando scrivi del tuo viaggio sei responsabile della strada che percorri perché ogni passo ti avvicina all’incontro con l’altro.
Quando leggo Chatwin ho la sensazione che gli fosse indispensabile partire solo, come in una vecchia brutta canzone di Vecchioni, per vedersi ritornare. Dell’ALTRO, di incontrarlo, mi sembra ogni volta che lo leggo, che in realtà non gliene fregasse niente.
In fondo quando uno di quei critici impiegati paragonò, se non ricordo male sul “Corriere Della Sera”, il Jovanotti autore di quel florilegio di irrilevanze – spacciato per diario di viaggio – che era Il Grande Boh a Chatwin, non era in preda a un raptus di selvaggio servilismo verso l’editore che non aveva avuto la vergogna di pubblicarlo, ma dimostrava che persino in quel ambiente avevano da tempo capito il valore del secondo come viaggiatore.
Che. Sia chiaro, resta comunque, a differenza di Lorenzo Cherubini, un ottimo romanziere.

Guy Delisle nemmeno quello.
Mi diverto a dire che i fumetti di Guy Delisle non sono reportage di viaggio, ma i diari delle sue vacanze. In realtà non è nemmeno così. Una vacanza comporta comunque almeno una scelta: quella della destinazione. Delisle non sceglie le proprie destinazioni. Gli sono, in qualche modo, imposte: le prime trasferte lavorative a Pyongyang e Shenzen; poi al seguito della sua compagna Nadège che lavora per Médecins Sans Frontières in Birmania e a Gerusalemme.
Nei primi tre volumi (Shenzen, Pyongyang e Birmania, tutti pubblicati da Rizzoli Lizard) Delisle interpreta la cultura di quei paesi e quello che gli accade personalmente secondo i punti di riferimento di quello che Michel Onfray (Filosofia del Viaggio: Poetica della geografia, Ponte Alle Grazie, 2010) definirebbe «il suo sguardo prefabbricato», rinchiuso nel paraocchi del tempo del suo lavoro e della sua appartenenza geografica: quella del mondo ricco, comodo, occidentale. Lambisce la cultura dei paesi dove soggiorna per lunghi periodi senza mai affrontarla seriamente; non si mette mai in gioco, non rischia nulla; resta sulla superficie, virtuoso surfista del neocolonialismo produttivo (è supervisore di non so quale studio d’animazione globalista), di tutti gli epifenomeni della sua vita in quei paesi e in quei periodi; milita incessantemente alla radicale difesa della propria appartenenza borghese e occidentale.
Di conseguenza il suo lavoro – tra l’altro la costruzione delle sue tavole è di una piattezza disarmante, che se non ci fosse l’azzardo di qualche ellisse narrativa ogni tanto, quasi ti coglierebbe la noia – non comunica al lettore nessuna sorpresa, nessuna meraviglia per la differenza, la diversità e la molteplicità. Trattandosi, in questi primi tre libri, dei diari della sua permanenza in paesi, da lui stesso definiti, del terzo mondo, oltretutto governati da dittature ideologicamente avverse alla sua indefessa occidentalità, non sorprende che le caratteristiche del suo approccio a quelle culture risulti rassicurante per il lettore occidentale, che ne ha decretato il successo.
Ma quando deve raccontare del suo soggiorno in un paese che, tutto sommato, in parte rientra nello specifico occidentale, ma che è anche centro conflittuale di incontro di almeno quattro culture diverse e inconciliabili, i nodi vengono al pettine.

Cronache di Gerusalemme (2012, Rizzoli-Lizard) svela la sua assoluta incapacità a raccontare il viaggio. Il suo non è lo sguardo del colonialista arrogante ed eurocentrico, come poteva essere quello di Chatwin, pronto comunque all’estetica dell’avventura e della conquista e alla responsabilità che comporta; non è nemmeno lo sguardo, come vorrebbe il mio amico Paolo Interdonato nella sua introduzione all’edizione di questo libro per il “Corsera”, di un viaggiatore disambientato: tutto sconcerto e stupore. È lo sguardo di uno che semplicemente non capisce, non si assume nessuna responsabilità e vorrebbe andarsene al più presto.
Cronache di cosa, le sue da Gerusalemme? Che a parte i lamenti dell’autore non ci succede niente. Già nelle prime tavole, favorevolmente colpito dalla modernità dell’aeroporto Delisle afferma che finalmente stare lì per un anno gli permetterà «una volta tanto di vedere qualcosa di diverso dai paesi del terzo mondo». Già lo capisci, i paesi che ha visitato, dove ha vissuto sono per lui un tutto indistinto, la piattezza della normalità dell’arretratezza rispetto alla diversità (perché superiorità) del suo mondo vero, quello di plastica dei centri di relax dove le multinazionali per cui lavora mandano i loro dipendenti a ritemprarsi. Ma già l’accento della persona che li riceve all’aeroporto lo colpisce: è arabo. Così in tre vignette il collegamento arabo–terzo mondo lo porta a preoccuparsi per quello che sarà lo stato del loro alloggio. Poi ogni volta viene smentito, ma questo non gli insegna niente. I suoi processi epistemologici restano sempre gli stessi.
Quando una rappresentante di MSF passa a spiegargli la situazione di Gerusalemme, prima che sua moglie cominci a lavorare, Delisle ammette di non averci capito niente. Ma dice di avere un anno per riuscire a capirci qualcosa. Quando partirà, dopo 340 pagine di noia del lettore, continuerà a non averci capito niente e quel che è peggio senza avere fatto capire niente a noi, nonostante la pazienza che abbiamo dovuto metterci nel leggerlo.
Nel trattato primo del Convivio, Dante ci dà una spiegazione di quali sono le cause che tengono gli uomini lontano dalla conoscenza. Alcune le colloca dentro l’uomo, altre al suo esterno. Le prime possono riguardare il corpo (qualsiasi sorta di impedimento fisico) oppure la mente (un qualche impedimento caratteriale). Le seconde attengono alle circostanze e sono di due tipi: gli impegni lavorativi e famigliari che non lasciano tempo per la sperimentazione, e le condizioni ambientali. Per Dante, uomo del suo tempo, l’impedimento fisico e quello famigliare non sono da vituperare, anzi. Gli impedimenti ambientali sono, a suo avviso (ché Marx era ancora lontano) colpa di chi li subisce, certo, ma non poi così gravi come l’impedimento mentale: l’incapacità di essere responsabili. Una specie di vigliaccheria epistemologica. Conoscere significa prima di tutto assumersi la responsabilità di interpretare.
Dunque se ha ragione Gaston Bachelard (e ha ragione, cazzo!) quando dice nel suo La poetica dello spazio (Dedalo, 2006) che compito del viaggiatore è dare risposte alla richiesta senza tregua di decodificazione che ci fa il mondo, i libri di Delisle, che a questo livello epistemologico non riescono ad arrivarci, non possono essere definiti diari di viaggio.
Ed è proprio questo il motivo per cui riscuotono così tanto successo.
P.S. Se ti va di sapere veramente qualcosa di quelle zone guardati Joe Sacco, Palestina, Mondadori. Oppure leggiti Edward Said, La questione palestinese, Il Saggiatore; James L. Gelvin, Il conflitto israeliano-palestinese, Einaudi; T.G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, Il Mulino; e il mio preferito per semplicità e immediatezza Alain Gresh, Israele-Palestina, ancora Einaudi. Li trovi tutti facilmente in qualsiasi libreria.
Non fa un cazzo da anni, ma è invecchiato lo stesso. Vive a Milano, e non potrebbe farlo in nessun’altra città italiana. Legge e parla di fumetti dal 1972 (anno in cui ancora non sapeva leggere). Ha una cattiva reputazione, ma non per merito suo. Ama e praticava la boxe, poi si è rotto. Beve tanto in compagnia di gente poco raccomandabile, tipo Paolo con il quale – per colpa di una di quelle bevute – si è ritrovato a curare QUASI.



