Me ne stavo a testa in su nella Cappella Sistina, dopo probabilmente due o tre decenni che non ci entravo, e stavo cercando di rimettere in fila le mie nozioni sulla Genesi rispetto alle sette «tavole» sul soffitto (o meglio, volta), così, giusto per curiosità, forse in memoria di una breve parentesi protestante tra i tredici e i quattordici anni, durante la quale mi ero letto, in serena autonomia, la Bibbia. In tempi di pandemia ci si può permettere il lusso di bighellonare a piacimento nello stanzone, una cosa che aveva dell’impensabile in epoche precedenti, quando passavi per il pertugio a destra dell’altare, venivi canalizzato nel moto browniano della folla facendo un po’ di sumo improvvisato e, ruotando la testa a casaccio come una tartaruga rovesciata, finivi nello «scarico» della porta all’altra estremità della sala.
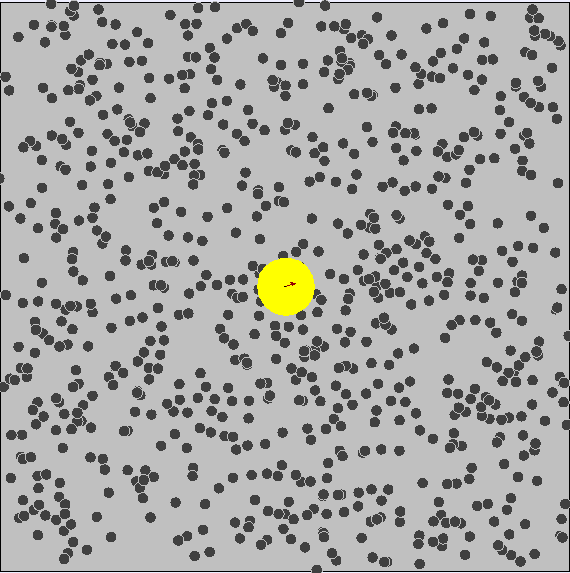
Stavolta si poteva prendersi tutto il tempo necessario per apprezzare sia il meraviglioso casotto del Giudizio Universale sia il timelapse a denti più radi del mondo, sul soffitto sulla volta. Il «casotto» a un osservatore mediamente ignorante come me non fa che suscitare una volta di più un sentimento di immedesimazione in quegli artisti dotati di questo potere incredibile, la capacità di rappresentazione del mondo reale e di quelli della fantasia tramite l’immagine ma frustrati a dover sempre, costantemente, ripetutamente, ineluttabilmente rappresentare soggetti sacri. Una uallera cosmica. Nondimeno, in due puntate, prima la volta, poi la parete, a distanza di venticinque anni, Michelangelo si butta là dentro e fa la sua cosa, sgobbando veramente duro.
Come dicevo, me ne stavo lì, quando un poco alla volta mi cade l’occhio su qualcosa che il cervello si rifiuta di processare correttamente per quel che è. Uno dice la pervasività dell’educazione cattolica anche quando, praticamente, non l’hai avuta… Dopo, uscito di lì, ho scoperto che non ero improvvisamente caduto preda di allucinazioni, almeno non di allucinazioni solo mie, e che esistevano tracce di appunti e riflessioni di altri su quel che avevo appena contemplato.
A un certo punto c’è Dio, col suo tunicone color vino annacquato (se non rosa), che, tutto preso dalla Work Breakdown Structure della creazione, si dedica a un paio di cose, strettamente connesse, specie se hai fatto Agraria: crea gli astri, Sole incluso, con imperiosità cazzutissima, un cipiglio che diobonino non ne avete mai visto uno così, e dà vita alle piante. Un aspetto fico è che qui Dio compare due volte nello stesso quadro, fronte e retro, e ti dà l’idea che la fotosintesi clorofilliana se la inventi al volo tra il primo gesto e il secondo in un continuum tumultuoso.
Ora, però, veniamo al dunque. Non c’è un altro modo per dirlo, quindi: Michelangelo ritrae il culo di Dio.

Oltretutto ti viene il dubbio, più che il dubbio, guardando da ventuno metri più in basso, anzi, no, il timore quasi, che quel rosa chiaro sia quello dei muscolosi chiapponi à la belle étoile e non, come poi scopri cercando sul web, quello del tessuto che aderisce tipo spandex alle forme del barbudo e, al contempo, viene rischiarato dalla stella di classe spettrale G2 testé creata. In pratica vai nel panico, anche se la scena che immagini si è svolta un po’ più di cinquecento anni fa, pensando a cosa dirà il papa quando vedrà quella roba.
Ovviamente non lo sappiamo, ma il Michelangelo trentasettenne (ci sono un sacco di numeri legati al tempo nel pezzo di oggi, mi spiace) ne esce illeso e il papa «assai ben sodisfato [sic]», secondo una lettera del Buonarroti al padre, almeno secondo Wikipedia.
Ecco, oggi, nella musica, ma anche nelle altre arti, i vincoli che pativano gli artisti di allora non ci sono più. Non c’è più bisogno di appioppare necessariamente il ruolo di Cristi et santi ai corpi e ai volti che vuoi raffigurare. Puoi anche non fare volti o corpi, li puoi fare a pezzi, tramutare, ricomporre, parodiare, quello che vuoi. Similmente nella musica, che pure ha patito forse meno la prescrittività religiosa (una ballata cantata in un’osteria – o nel chiuso di una dimora nobiliare – poteva essere anche un capolavoro musicale e un trionfo di lascivia ma non restava appesa sopra la capoccia del vicario in Terra del figlio di quello di cui sopra), nella musica, dicevo, si sono via via spezzate, anche grazie all’epoca della riproducibilità, le catene dei vincoli di «destinazione d’uso» per le composizioni e le rispettive occasioni. Oggi, se vuoi, puoi cucinare ascoltando Musica per il Funerale della Regina Maria di Henry Purcell o far celebrare il tuo matrimonio al suono di Where is My Mind.
Ovviamente non sappiamo perfettamente come pensavano le menti di cinquecento anni fa, il mestiere dello storico consiste anche, in parte non trascurabile, esattamente in questo, in un tentativo onesto di portarci in quella direzione senza cadere nella trappola di immaginare categorie eterne – però, per la miseria, sei veramente un artista al top quando fai accettare al papa che non solo hai ritratto Dio, e d’accordo che non è il Gran Muftì di Alessandria o l’Ayatollah Khomeini (non che faccia tutta ‘sta differenza, eh, Adriano VI considerava la Sistina una «stufa d’ignudi»), ma, ragazzi, gli si vedono le terga, il sedere, il culo. QVLUM VIDEMVS EIVS.
Non so nella musica moderna dove possiamo trovare un’equivalente messa a quasi-nudo del culo di Dio, i parallelismi dipendono anche dai gusti (e dalle convinzioni). Il punk ha scoperchiato un po’ di culi però erano più probabilmente quelli dei matusa, dei genitori, dei capi. Ma va anche detto che non ne so molto di punk, quindi, man muß schweigen. Nel jazz Dio forse non c’è mai entrato, mi sa perché non ce lo volevano proprio. Se la linea genealogica che passa dalle navi negriere ai campi di cotone e genera spiritual, gospel e blues, porta tanta sostanza al jazz, il contenuto di invocazione al Signore non sembra proprio passare. Chissà se per disinteresse o vera e propria incazzatura. Nel secondo caso non mancavano certo i motivi, oltre a quelli pregressi della schiavitù: a seconda dei casi il jazz era «black music» (un po’ tutti), a «Jewish creation» (quell’antisemita di Henry Ford), pieno di «Negroid influences» (chi non riusciva a suonarlo), la «voce del voodoo» (i particolarmente fobici) e così via. Tutto questo e altro ancora, come sappiamo, ha perpetuato ancora e ancora l’apartheid e il segregazionismo in America e in Europa da parte dei bravi cittadini timorati di Dio. Una ipotesi più articolata e calzante per il jazz è però che in tutto un sottobosco di lowlife e strambi che includeva anche bianchi, creoli, mezzosangue e altri ancora, abbia attecchito una cultura del creare ed eseguire musica che si innestava in modo «laico» e libero sulla disciplina per, essenzialmente, divertirsi. I relativi ma sostanziali miglioramenti nelle condizioni economiche e sociali nella società americana nel secondo dopoguerra fornirono poi carburante essenziale per la dignificazione del genere al di là del successo popolare del swing. Wynton Marsalis, che oggi da molti viene visto come un talvolta pomposo guardiano della tradizione, ricorda che suo padre Ellis, portato via dalla pandemia di COVID-19 qualche mese fa, pianista di rilievo e docente di jazz, molto spesso amava tirar tardi con i suoi amici a suonare. Il contesto, quello di un sobborgo di New Orleans, dove i figli dei vicini di casa finivano più facilmente nell’eroina che nella musica.

Sia come sia, iniziando, giustamente e anche rapidamente, a lasciare da parte i divini quarti posteriori, mi viene in mente che nel jazz Michelangelo probabilmente è Charlie Mingus. Vuoi per la barba un po’ satanica, vuoi per il temperamento per niente facile, vuoi per la capacità di mettere le mani su tante cose (Michelangelo che dice che la pittura non è il suo mestiere fa il paio con Mingus che registra Mingus Plays Piano). Ah, giusto, dimenticavo: Mingus era un contrabbassista!

Mingus è letteralmente perfetto da tanti punti di vista. Bassista virtuoso, pianista mica da ridere, compositore e direttore, nipote di un anglo-cinese e una sudamericana per parte di madre, di un contadino nero e di una svedese per parte di padre. Un pastiche totale, un melange adultero di un po’ tutto. Non fu facile come persona come non fu facile la sua vita, fin dall’infanzia, ma quel che ne maturò come musicista fu spettacolare, un paladino dell’improvvisazione ma anche dell’aderenza allo spirito dei suoi pezzi, non necessariamente di quello che avevi dentro tu. Insomma, tutto il contrario del bassista che non si fila nessuno.
Oggi si è volato alto, sarà che dobbiamo prendere la mira per attraversare la falsa bonaccia d’agosto, sarà che dipingere sempre le micragnose miserie del bassista da salotto non è cosi esaltante però a quel salotto ci si deve tornare eccome. Ritorniamo ai quindici-trenta minuti di pratica/studio giornalieri, alla goccia che scaverebbe la roccia se solo cadesse nello stesso punto per un po’ di volte invece di disperdersi e però che meraviglia quando riesci a seguire Goodbye Porkpie Hat in qualche modo, anche suonando male e facendo scelte di pessimo gusto! [ascoltatevela, tirate su il volume e assicuratevi di avere dei bassi sufficienti, magari in cuffia]
Parlando di noi, dunque, il para-sistema di riferimento che ha dato struttura al discorso di oggi ci dà il destro di proporre un altro accostamento, non tanto sul piano del livello artistico, quanto su quello di come certi aspetti accessori e incidentali finiscano pressofusi nell’eternità (nel lungo periodo, va’) nella loro incongruità, a spese di tutto il resto. Daniele da Volterra fu un epigono di Michelangelo – e a giudicare da un busto e un ritratto del Buonarroti, anche uno bravo. È passato però alla storia come «Il Braghettone», avendo dovuto disegnare drappeggi e panneggi mutandeschi a coprire le pudenda delle figure del Giudizio Universale nel pieno della brutta brutta aria che tirava dopo il Concilio di Trento. Non li fece neppure tutti lui ma, come un Erostrato involontario, questa fama sempiterna gli si è affissa addosso irrimediabilmente.
Noi, le mutande posticce le mettiamo in continuazione a tutte quelle decine di sbavature e cazzatelle di cui disseminiamo i pezzi che suoniamo, quelli che si dovrebbero fare per bene, perché sono scritti così, perché sono registrati così, di cui non siamo mai veramente contenti – il giudizio non è universale, ma a ciclo continuo sì. Quando capita di registrarli (raramente, per fortuna) la tecnologia digitale estende all’infinito l’apparente rimediabilità di quel che proprio non andava e per mettere insieme tre minuti di pezzo facciamo cinquantaquattro take. Se alla fine il risultato suona stanco e banale non c’è da stupirsene (ammesso che l’abbiamo registrato a modino – lì si aprirebbe un #l’ingegneredelsuonoviveun’esistenzadimerda ma, per fortuna, è oltre il mio orizzonte).
Quando sento qualcuno suonare bene dal vivo non gli chiedo niente, so che potrei scoprire che ritiene di avere «mutandato» ineffabili, impercettibili errori così come trovarmi davanti la spiacevole sicumera di chi pensa di fare tutto solo ed esclusivamente «bene». Certo che la spavalderia pare che un po’ aiuti, a colpi di pippe mentali affondi anche se stai facendo With or Without You. La cultura del dubbio mal si attaglia a quattro minuti di pedale a ottavi… Per questo quando atterri dalle parti del jazz l’atmosfera di relativa confusione che si respira affascina, invece di sgomentare e basta. Sei inadeguato, è vero, ma meglio essere un paria in una terra ammaliante che un tremolante travet nel quartiere degli uffici.
Intanto possiamo pure consolarci: la scienza pare volerci dire che il basso è, in pratica, lo strumento più importante all’interno della band. Oh, quindi basta suonarlo bene, giusto?
[E qui si può tornare all’episodio 1. di questa rubrica e non uscire mai dal loop]
È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.



