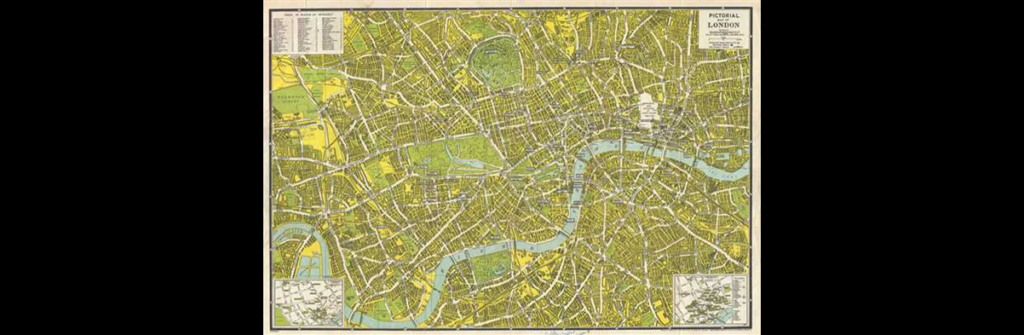Chi sa fare critica
C’è una frase che viene attribuita a Frank Zappa che, con ogni probabilità, quel musicista non ha mai detto: «Parlare di musica è come danzare di architettura». È una delle innumerevoli versioni che assume la sentenza dell’artista che si scaglia contro la critica. «Chi sa fare fa; chi non sa fare critica».

In fondo è evidente: quella cosa che chiamiamo critica è fatta di sole parole, sa usare solo quelle e, spesso, lo fa anche male. Se ha quella forma, chi la frequenta non può che sviluppare chiacchiere intorno a manufatti che solo a volte sono fatti di parole, più spesso di pennellate, inquadrature, accordi, mattoni, bit, odori, scatolette di latta contenenti materia fecale artistica…
Chi fa critica, poi, con le sue sole parole, sente spesso di essere una funzione del sistema culturale: vorrebbe orientare il pubblico, magari dandosi anche il ruolo nobile, pedagogico e formativo, di chi indica la bellezza. Ma se la critica vive per orientare gli acquisti (e poi, sia chiaro, anche le fruizioni, le letture, gli ascolti eccetera), si trasforma in una funzione mercantile, subalterna alla produzione, distribuzione e vendita dei prodotti culturali.
Per adempiere a questa funzione autoassegnata, chi fa critica si sente spesso in dovere di inseguire i ritmi e le frenesie del mercato. Usa tutte le sue energie per raccontare le ultime uscite, per inseguire le ricorrenze e per assecondare gli equivoci del marketing e della pubblicità, per muoversi all’unisono con il ciclo di vita del prodotto culturale che si sposta tra i canali di vendita.
Quell’attività rispettabilissima non è critica. Si chiama giornalismo – eventualmente culturale, se proprio dovesse servire una qualifica – e mira all’informazione e all’orientamento del pubblico. Se il sistema editoriale rilascia innumerevoli prodotti, dal ciclo di vita abbastanza breve, con continuità, è necessario che qualcuno li descriva, esprimendo giudizi di qualità (anche sommari), e rilevi le discontinuità. Il giornalismo è un sistema imperfetto e fallibile: ha vincoli di tempo e di costo; regole di presentazione; posizionamento ideale; limiti imposti dalla proprietà, dagli investitori, dalla direzione, dall’idea di pubblico di riferimento; canali in divenire; frammentazione dei contenuti a scapito della linea editoriale…

E, nonostante tutti questi limiti, resta uno dei modi più efficaci a disposizione dei pubblici per scoprire quali siano i prodotti in uscita o in vendita. Gli altri prevedono la frequentazione dei posti in cui si comprano quei prodotti per esaminare la vetrina, la lettura delle pubblicità (anche di quelle più attive, costruite tramite aggregazione digitale per colpire specifici acquirenti), le chiacchierate con altre persone…
La critica non è nulla di tutto ciò. Anche lei è una macchina imperfetta e fallibile, ma per ragioni completamente diverse. Chi fa critica ha il dovere della militanza. E fare critica militante significa, senza eccezioni, assumere una posizione assoluta, indifferente – il più possibile – alle regole del mercato, alle periodicità, alle stagionalità, ai gruppi di potere, agli investitori, perfino ai pubblici.
No, così è un po’ esagerato. Chi fa critica sta producendo un manufatto con finalità artistiche. Vuole produrre bellezza, lavorando esplicitamente sulla rete di relazioni tra le opere che analizza, sintetizza, contraddice, verifica e, in definitiva, usa e tutto quello che ha dentro. Quella persona è imperfetta e fallibile, eppure fa critica.
Per farlo, può usare le parole (e quasi sempre lo fa), ma anche le pennellate, le inquadrature, gli accordi, i mattoni, i bit, gli odori, le scatolette di latta contenenti materia fecale artistica…
Parlare di musica e danzare di architettura sono due delle forme che può assumere la critica. E non è un paradosso.
L’umarell e l’immortalità dell’anima
«Chi sa fare fa; chi non sa fare critica».
Questa frase, enunciata in una delle sue innumerevoli varianti da chi produce arte e si sente ignorato o malcompreso, ha un corollario: chi critica, se non tesse elogi e riconosce grandezze, è un umarell che, pur non essendo né artista né editore, vuole spiegare come si fanno quei mestieri. Per amore d’onestà, quella dell’umarell non è una delle metafore più usate dagli artisti incompresi – ai quali può anche succedere di non avere grande dimestichezza con le figure retoriche – ma la si incontra, ed esprime bene un sentire diffuso.
Poi, è completamente fuori fuoco come gran parte della critica alla critica. E lo è per diverse questioni.

La prima questione riguarda la definizione. L’umarell è una figura mitica che vive nelle aree metropolitane, nei pressi dei cantieri. Rimane in piedi, accanto alle recinzioni di sicurezza, con le mani ancorate dietro la schiena; oscilla lento spostando il peso da una gamba all’altra; commenta l’operato di chi sta lavorando, spesso dando consigli di dubbia utilità, mentre i lavori sono in corso. Ecco: “mentre i lavori sono in corso” è una specifica chiave della funzione dell’umarell. Chi critica ha già comprato – o ottenuto in altra forma – il manufatto artistico su cui esercita le proprie capacità. A meno che non stia fischiando una rappresentazione, tirando ortaggi su un palcoscenico, o vandalizzando un’opera esposta, chi critica non è mai lì mentre i lavori sono in corso. Anche se, a volte, vorrebbe e ha tenuto da parte secchi di vernice rosa e pomodori marcescenti per l’occasione.
La seconda questione riguarda l’assurda confusione tra produzione e prodotto. Nel 1985, Michael Porter, uomo d’affari e professore universitario, ha pubblicato un bestseller: Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. In quel libro, Porter definisce un modello per rappresentare le organizzazioni produttive che, da allora, chiamiamo “catena del valore”. IfM (Institute for Manufacturing) dell’università di Cambridge ne dà questa definizione:
«La catena del valore si basa su una vista per processi delle organizzazioni. L’idea centrale è che un’organizzazione manifatturiera (o di servizi) può essere vista come un sistema composto da sottosistemi, ognuno dei quali ha degli input, un processo di trasformazione e degli output. La gestione di input, processi di trasformazione e output richiede l’acquisizione e il consumo di risorse (cioè denaro, lavoro, materie, equipaggiamento, edifici, terreni, amministrazione e gestione). Il modo in cui vengono eseguite le attività previste dalla catena del valore determina i costi e ha un impatto diretto sui profitti.»
Nella rappresentazione della catena del valore ci sono due classi di attività: quelle primarie, disegnate come scatole verticali e sequenziali, che devono essere lette da sinistra verso destra, a dire che gli output di una diventano input della successiva; e quelle di supporto, rappresentate come scatole orizzontali, che producono servizi comuni a tutte le altre. Quando parliamo di industria culturale, tra i processi di supporto ci sono (o ci dovrebbero essere) il marketing, la comunicazione e l’ufficio stampa. La critica non è tra quei processi. Ogni industria che invece dovesse avere, all’interno della propria organizzazione, personale poco consapevole degli obiettivi, dei limiti e dei vincoli e lontano dalla progettazione culturale potrebbe essere in preda a un’infestazione di umarell. Nel qual caso sarebbe opportuno inserire tra le proprie attività di supporto la gestione e il contenimento dei danni da loro indotti.

La terza è ultima questione riguarda il luogo in cui agisce la critica. Chi la fa, se decide di usare un manufatto culturale, può essere ovunque, con chi vuole o gli capita, per tutto il tempo che gli serve o che ha a disposizione. Il cantiere è stato chiuso da un pezzo ed è veramente raro che la critica sia mossa in presenza di chi ha partecipato alla progettazione o alla produzione del manufatto in analisi o in uso.
Chi fa critica non spiega mai a chi lavora come avrebbe dovuto farlo. Se ha abbastanza fortuna, riesce a essere indifferente a tutti i processi che hanno portato quel manufatto al suo cospetto. E, sicuramente, della creazione del valore industriale e organizzativo non gli importa alcunché.
Come quando fuori piove
“Come Quando Fuori Piove” è uno dei trucchi mnemonici che preferisco. Se, da un lato, aiuta a ricordare la priorità dei semi francesi quando si gioca a poker (Cuori, Quadri, Fiori, Picche), dall’altro, racconta uno stato dell’essere.
Sì, hai visto bene: ho ricominciato a scrivere in prima persona e, già, anche a rivolgermi a te, proprio a te, usando il più alto grado di confidenza possibile. Mi è passata. Ero furioso, lo sono stato per una decina di giorni, forse addirittura per due settimane. Ora non più: mi è passata. Per riuscire a riemergere dalla rabbia, ho avuto bisogno di rimanere da solo. Mi accoccolo in un angolo e inizio a riempirmi di storie dall’esterno: schermi accesi, musica e suoni, libri aperti un po’ ovunque, sapori, attenzione alle sensazioni tattili. Combatto il rumore che ho dentro con l’osmosi e mi comporto assecondo la mia natura: sono un critico.
Essere un critico significa vivere come quando fuori piove. Cerco un posto tranquillo e asciutto, dove posso star bene e tenere lontana la tristezza e cerco di capire il mondo. L’unico modo che conosco è partire dai miei sensi e dalle mie esperienze, riconoscendomi imperfetto e fallibile, e mettere in dubbio tutto, per cercare un’approssimazione di verità.

“Approssimazione” e “verità” sono le parole chiave. La verità non esiste: esistono innumerevoli versioni dei fatti che raccontano volontà, obblighi e possibilità diversi. Cercare la verità significa sviluppare un punto di vista. La soggettività è imprecisa e fallibile (e anche la vista, ma su questo torno prossimamente), può essere solo un’approssimazione. Ed è proprio per questo che lo spazio critico che Boris e io abbiamo voluto si chiama (Quasi).
Il critico non ha intenzioni pedagogiche o divulgative. Io, sicuramente, non ne ho. Non voglio formare, informare o divertire. Voglio capire il mondo.
Non ho una pulsione intellettuale o etica. Sono un dannato egoista che lotta solo per sé. E per questo non ho neanche un lettore ideale: infatti (Quasi) si rivolge a nessunə. Non è spocchia o stronzaggine: è consapevolezza.
Quando ho detto che non ho lettore ideale ho chiaramente esagerato. Quella figura mitica e idealizzata con un sacco di attributi diversi è definita, con assoluta precisione, da Umberto Eco in Lector in fabula come:
«L’insieme di condizioni di felicità, testualmente stabilite, che devono essere soddisfatte perché un testo sia pienamente attualizzato nel suo contenuto potenziale».
Che bella definizione. Per chi ama i fiumi di parole impetuose, c’è anche quella di Alberto Manguel, riportata in Al tavolo del cappellaio matto:
«Il lettore ideale è lo scrittore appena prima che le parole prendano forma sulla pagina.
Il lettore ideale esiste nel momento che precede quello della creazione.
[…]
La letteratura non dipende dai lettori ideali, ma solo da lettori sufficientemente buoni.»
Un lettore ideale, lo sai, ce l’ho, eccome.
Io scrivo proprio per te.

Scrive e parla, da almeno un quarto di secolo e quasi mai a sproposito, di fumetto e illustrazione . Ha imparato a districarsi nella vita, a colpi di karate, crescendo al Lazzaretto di Senago. Nonostante non viva più al Lazzaretto ha mantenuto il pessimo carattere e frequenta ancora gente poco raccomandabile, tipo Boris, con il quale, dopo una serata di quelle che non ti ricordi come sono cominciate, ha deciso di prendersi cura di (Quasi).