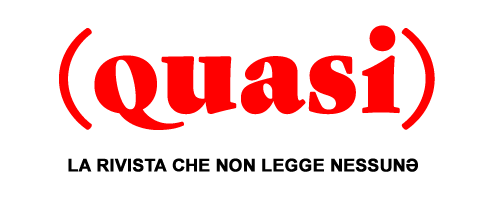Giorno della memoria. Leggo un po’ di stampa on line. Non pensare a chissà quale attività da intellettuale, semplicemente scrollo gli articoli cercando quelli su cui soffermarmi quando potrò. Tutto questo prima di gettarmi su caffè e sigaretta, per attivare in me la vita cosciente, e prima di iniziare il lavoro. Mi sembra di essere il Giovanni Telegrafista di Jannacci. «Per le sue mani passò mondo, mondo che lo rese urgente, crittografico, rapido, cifrato». Conosci?
Sotto le mie dita passano migranti incatenati, persone senza documenti da deportare. Notato lo sdoganamento del termine e del concetto stesso di deportazione? Poi, un torturatore libico liberato e riportato a casa, sia mai troppo il disturbo. Saluti nazisti, pure loro sdoganati in mondovisione. E mica in un posto a caso, ma durante l’insediamento del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Poi passa proprio Trump. Propone un’idea che, solo pochi anni fa, avrebbe proposto un imbriago dopo l’ennesimo grappino al bar. In pratica, spostiamo i palestinesi della Striscia in Egitto e Giordania. «Gaza is a beautiful location! Let’s go and make a resort!».
[Oh, ti giuro, stavo scrivendo questo articolo e lui rincara la dose: «Diventerà la Costa Azzurra del Medio oriente». Qui sotto puoi vedere i palestinesi tornare alle loro case. Ora è un deserto di macerie, ma presto sembrerà Cannes!].

Si tratti di migranti rispediti in Colombia dalla nuova amministrazione USA o di uomini e donne di Gaza, c’è da ragionare, dicevo, sul via libera alla parola deportazione. Un tempo, neanche tanto remoto, un politico avrebbe anche potuto PENSARE di attuare una deportazione, ma MAI l’avrebbe definita così. L’avrebbe programmata ugualmente magari, ma nascondendola dietro altri termini.
«Solo semantica», potresti obbiettare. Vero, però a me spaventa quando vengono sdoganate le parole, perché significa che non c’è più neppure la vergogna di proporre/attuare certe idee. Significa (anche) che si ritiene l’opinione pubblica talmente assuefatta da non provare indignazione di fronte a certi termini, e certi politici sentono che il campo è ormai libero. «Promessa mantenuta».

«Passò prezzo caffè passò matrimonio Edoardo ottavo,
oggi duca di Windsor,
passarono cavallette in Cina,
passò sensazione di una bomba volante,
passarono molte cose…»
Assieme ai giorni, scorre la sequela di scuse con cui il governo prova a giustificare la liberazione di Najeem Osama Almasri, il militare libico contro cui la Corte penale internazionale ha spiccato un mandato di arresto. Le scuse sono molte e variegate. La colpa è dei magistrati, della sinistra, dei servizi tedeschi, di traduzioni dall’inglese. Gomma bucata, benzina finita, smoking in tintoria, cavallette. Jake Joliet Blues insegna, vediamo se Carrie Fisher se la beve.

Passano i giorni, insomma. Passa, fra l’altro, la mail con uno spunto. «Baro, ma se ‘sta amministrazione USA fosse in realtà solo un gigantesco reality show in cui si esamina un’ucronia?». Tutto questo mi porta l’idea di realizzare una compilation del Tradrittore.
Piantedosi è un buon candidato. «Il cittadino libico presentava un profilo di pericolosità sociale, come emerge dal mandato di arresto emesso in data 18 gennaio dalla Corte Penale Internazionale … Ho adottato un provvedimento di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato».
Ossia: «Sì, è un criminale pericoloso. Per questo, anziché consegnarlo alla giustizia, lo abbiamo riportato proprio dove può tornare a commettere gli stessi crimini per cui è accusato. Con un volo di Stato». Un capolavoro!

Buon candidato è anche Tajani. Nell’immediato ha ridimensionato il giudizio del Tribunale dell’Aja, dicendo che mica è la bocca della verità. Poi è andato oltre, giustificando i ritardi del ministro della Giustizia: «Non era semplice. C’erano quaranta pagine in inglese da tradurre». Roba talmente ridicola e sbilenca che potrei chiuderla qua, il Tradrittore è stato superato. A destra e dalla realtà.
Bruno Vespa, in un accesso di realpolitik, tenta uno spericolato «così fan tutti». Letteralmente: «In ogni Stato si fanno delle cose sporchissime, anche trattando con i torturatori, per la sicurezza nazionale».
Giorgia Meloni si produce nel solito «Non mi faccio ricattare, non mi faccio intimidire». Per lei ormai è un evergreen, forse un intercalare. Molti si sono soffermati sul «ricattare», sottolineando – non senza ragioni – come siano frequenti i casi a dimostrare il contrario. In fondo, pure la difesa pronunciata da Vespa va in quella direzione. Ogni governo è ricattabile, nella misura in cui è costretto a scendere a patti con la gente peggiore. Eccoti, per esempio, la premier trattare col rappresentante di uno Stato verso cui si scagliava, pochi anni prima, per la scarsa considerazione dei diritti civili e altre cosucce.

Tornando all’intercalare di Meloni, personalmente sono colpito maggiormente dall’altro termine: intimidire. Significa incutere timidezza. Non quella spontanea di chi si sente umile o fuori posto, ma quella imposta a forza, più simile alla subordinazione.
Esattamente. Meloni, nel caso Almasri, è priva di timidezza. Il cui contrario in fondo è spudoratezza, assenza di pudore. In questo lei e Vespa sono sinceri. E fu un governo moderato (a definirlo anche solo di centrosinistra mi viene il mal di pancia) ad affidare alla Libia la gestione dei flussi migratori, a lasciare i migranti in mano a gente senza scrupoli. In poche parole, Meloni dice una verità (come Vespa, da altra angolazione). E contemporaneamente conferma che il governo ha mentito, inventando scuse traballanti che peraltro si annullano l’una con l’altra.
[En passant. In modo più ufficiale, ossia durante l’informativa al parlamento, il governo ha poi dato il suo punto di vista definitivo. Nordio in sostanza ha detto che la CPI ha fatto un gran pasticcio. Piantedosi, da ministro dell’interno, ha ribadito di aver espulso Almasri per la sua pericolosità. Incuranti della contraddizione logica prodotta dal combinato delle due versioni, la maggioranza ha accolto con applausi scroscianti il lieto fine della vicenda. Come ai tempi della nipote di Mubarak. E ora, con animo più sereno, può tornare alle occupazioni consuete.]

Va bene, sono felice di avere inserito un veloce omaggio a Magnus e Bunker, però non ho ancora risposto allo spunto offerto per l’attuale mese di (Quasi), che pure mi solletica. Siamo davvero dentro un’ucronia? O una distopia? La realtà in cui siamo precipitati cos’è, come la si può definire?
Ebbene sì, lo confesso, con la compilation del Tradrittore hai letto solo un’introduzione. Lunghetta, ti vedo già steso. Ripigliati, dai!

Questa “rivista che non legge nessunə” si è già occupata del merdone scoppiato attorno a Neil Gaiman, così come altre testate, fumettistiche e non. Io, giuro, fin qui non l’avevo fatto perché aspettavo che qualcunə lo affrontasse da un punto di vista che mi sembrava doloroso e naturale, e invece sembra sfuggito all’attenzione.

Nel 1984 Tori Amos ha 21 anni. Tiene già concerti, ma non è ancora famosa. La fama arriverà nel 1992 con Little Earthquakes, per poi esplodere con Under the pink (dove trovi il suo brano più noto, Cornflake girl) e consolidarsi in alcuni album davvero belli ed esibizioni live di grande intensità. Questo, se la conosci poco o nulla, ti valga anche come consiglio di ascolto.
Ma, dicevo, nel 1984 non è per nulla famosa. Un uomo l’attende dopo un concerto. La minaccia con un coltello, la fa salire in auto e la violenta. Otto anni più tardi, dopo aver visto Susan Sarandon uccidere l’uomo che vuole violentare l’amica in Thelma e Louise, Tori riesce a sfogare rabbia e dolore scrivendo una delle sue canzoni più intense, Me and a gun. I versi più strazianti sono quelli dove confessa che, per resistere durante la violenza, si è trovata a pensare alle cose più assurde. Che non aveva mai visto le Barbados, per esempio, e anche per questo doveva uscire viva da quell’incubo…
«It was me and a gun
And a man on my back
But I haven’t seen Barbados
So I must get out of this.
And do you know Carolina
Where the biscuits are soft and sweet?
These things go through your head
When there’s a man on your back
You’re pushed flat on your stomach
It’s not a classic Cadillac.
Me and a gun
And a man on my back
But I haven’t seen Barbados
So I must get out of this
I haven’t seen Barbados
So I must get out of this»
Il sogno delle Barbados, il pensiero dei biscotti della Carolina. Una fessura attraverso cui la sua anima poteva fuggire in quei momenti. «DEVO uscirne viva», ecco.
Vabbè, ma cazzo c’entra l’autore di Sandman? C’entra, c’entra…

Tori Amos è stata la prima portavoce della RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network) la maggiore organizzazione contro la violenza sessuale negli USA. Neil Gaiman è stato suo grande amico fin dai tempi di Little Earthquakes, proprio l’album con Me and a gun. Un amico vero, padrino della figlia Tash. E, sia chiaro, lei era totalmente all’oscuro della “doppia vita” di Gaiman, così come, per quanto vale la mia opinione, non ho dubbi sulla sincerità dell’affetto dello scrittore verso di lei, che così si è espressa sulle recenti accuse a Gaiman.
«That’s not the Neil that I knew, that’s not the friend that I knew, nor a friend that I ever want to know. So in some ways it’s a heartbreaking grief. I never saw that side of Neil.»
Ecco, Tori Amos è persona a cui non chiedere, per delicatezza nei suoi confronti, se sia possibile o necessario o impossibile separare un artista dalle sue opere, anche se sarebbe interessante la sua risposta.
Di pipponi su questo ne hai letti abbastanza. Roba da farti due palle che riempite a mo’ di mongolfiera arrivi su Marte prima di Musk…
[Vabbè, scusami, sono un po’ sbrigativo. La questione in realtà è molto importante. Se la faccio breve è, in primo luogo, perché io (ben prima dell’esplosione di questi dibattiti su Gaiman e molti altri) non ho mai avuto particolare interesse a conoscere personalmente i miei miti e neppure dettagli sulla loro vita. E il dito più lungo della mia mano, già sai, non è l’indice. In secondo luogo, soprattutto, il dilemma su separazione artista/opere conta assai poco in questo articolo. Se t’interessa, Sandman lo consiglierei ancora, anche se la mia opinione sul suo autore è precipitata al grado lombrico.]

Insomma, rispondere al quesito a me proposto per il tema mensile non è semplice. La realtà che stiamo vivendo, temo, non è né un’ucronia né una distopia. Semplicemente è proprio la realtà (spostati, cazzo, mi copri la vista della svastica sul sole!). L’immagine più immediata che mi viene in mente per rappresentarla è quella tremenda di Tori, ventre schiacciato sul sedile di un’auto, mentre un uomo la violenta minacciandola con un coltello – che nella canzone, per metrica, lei trasforma in una pistola, a gun. A rafforzare l’immagine, rifletti: quello stronzo non è detto sia tanto diverso da uno come Neil, magari colto e sensibile. Non un individuo “trasformato” da un demone interiore, e neppure uno che sta mostrando il proprio vero volto. Semplicemente, un essere umano che mostra UNO dei suoi volti.
Mi viene in soccorso un passaggio firmato da Boris e Paolo proprio su queste pagine.
«Quelle che attribuiamo alla “disumanità”, sono invece caratteristiche tipicamente umane: siamo l’unica specie a presentare un’aggressività intra-specifica così spiccata. La crudeltà dell’uomo, come sottolinea Lorenz ne Il cosiddetto male, non è bestiale, bensì tipicamente umana.»
E per concludere mi aiuta un’altra citazione tratta dall’editoriale con cui (Quasi) ha aperto il mese.
«Non c’è atteggiamento che chiunque possa assumere ovunque, il quale non finisca per agire, in ultima analisi, a favore del sistema.»
Un sistema che ci soffoca, ci violenta. Da cui possiamo difenderci con lo sberleffo del giullare. Oppure, attaccandoci a desideri innocenti. Il sogno delle Barbados mai viste, la voglia dei biscotti morbidi e dolci della Carolina, che mai abbiamo assaggiato e vorremmo provare.

Vive una crisi di mezza età da quando era adolescente. Ora è giustificato. Ha letto un bel po’ di fumetti, meno di quanto sembra e meno di quanto vorrebbe. Ne ha pure scritti diversi, da Piazza Fontana a John Belushi passando per Carlo Giuliani (tutti per BeccoGiallo) e altri brevi, specie per il settimanale “La Lettura”. Dice sempre che scrive perché è l’unica cosa che sa fare decentemente. Gli altri pensano sia una battuta, ma lui è serio quando lo dice.