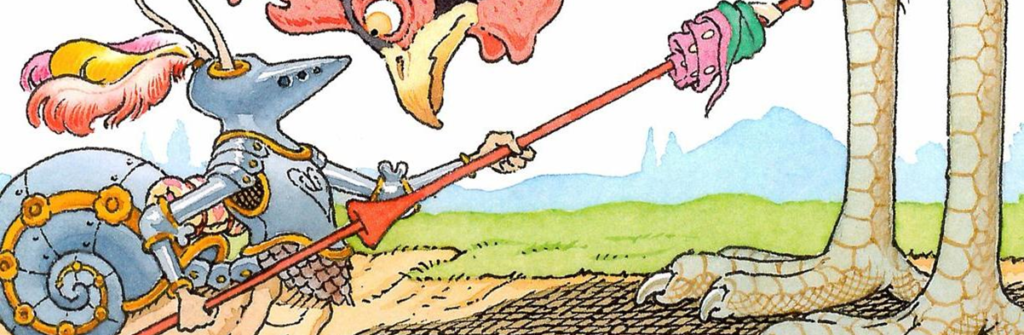Se questi fossero tempi normali… no, non esistono tempi normali, mettiamola così: se non ci fosse la pandemia, questa conversazione sarebbe avvenuta a qualche tavolino ingombro di pubblicazioni Oblò e di bicchieri in Piazza delle Erbe a Padova, e saremmo entrambi storti dei troppi spritz e hugo. Invece, siamo ognuno a casa propria e ancora, cosa che va a tutto vantaggio della chiarezza della chiacchierata, sobri.
Così dopo che ho sfogliato questo primo numero dei “Baccanti” con assoluta lucidità, gli dico a Claudio…
Più che il risultato finale, sul quale pesano soprattutto le aspettative estetiche del lettore (e ogni lettore ha le sue), mi interessa il percorso che ti ha portato a decidere di realizzare questa serie… perché è una serie quella che hai in mente, vero?
…e lui mi risponde:
Certo che sarà una serie, ho visto i comic book di Officina Infernale e mi sono convinto che se non hai il tuo comic book personale non sei più nessuno…
Mica hai torto, sai. Sono anni che mi assilla l’idea di un feuilleton tipo tascabili anni Sessanta, cose alla Isabella… una serie tutta mia… comunque, è evidente che ti stai divertendo un casino. Ma immaginiamoci di essere a un festival dove possiamo vendere le cose di Oblò avendo commercio fisico con chi passa dal banchetto. Prendo in mano lo spillato dei Baccanti e la prima cosa che mi colpisce, è la scelta della bicromia. Così sfogliandolo, mi sembra sbilanciata verso il rosso. Ora. Il rosso è uno dei due mie colori preferiti. Ma qui è veramente tanto. È la prima cosa che noto…
Hai ragione, il rosso è tanto. I Baccanti saranno probabilmente sempre in bicromia, anche se il colore cambierà di volta in volta. Diciamo che da qualche tempo, probabilmente coincidente con la mia esperienza su “Linus”, mi sono convinto di “funzionare meglio” con una tinta intermedia tra bianco e nero. E per varie ragioni questa tinta, per i primi due numeri dei Baccanti, non poteva essere altro che rosso. La funzione di questa tinta intermedia è anche quella di… ridurre il mio uso di neri, costringermi a disegnare di più. Probabilmente combinando queste due cose… hai ragione, c’è davvero un sacco di rosso.
Ecco… il disegno. Il tuo segno è cambiato molto. Dall’uso… diciamo, simbolico, come fosse una scrittura, che ne facevi nei primi lavori (probabilmente per gestire al meglio i limiti grafici di cui eri consapevole) e che ci ha dato quelle che per me restano ancora le tue cose migliori: Porto Marghera e l’intervista a Toni Negri, sei approdato a un segno che mi sembra allontanarsi da quel simbolismo originale, per diventare più “mimetico” – con un riferimento diretto – mi sembra- a quello di Gianluca Costantini. Ora. È stato il cambiamento del tuo segno a comportare anche un cambio di genere: dal graphic journalism alla narrativa con taglio feuillettonesco, oppure è stata la tua necessità di raccontare storie inventate ad agire sul tuo segno modificandolo?
Ci sarebbero così tante cose da dire su queste tue due frasi. Intanto ti ricordo che Porto Marghera quando uscì me l’hai stroncato. Fa piacere conoscere la tua opinione qualche anno dopo…
Ah ah ah, ma davvero ho stroncato Porto Marghera? sai che non me lo ricordo… che avevo detto? Comunque, invece, rileggendolo recentemente, l’ho apprezzato almeno quanto il Toni Negri (di quello ne ho sempre parlato bene, ammettilo!) e in parte Dossier Tav.
Ricordo nella Lucca del 2008 che un ragazzo venne da me allo stand Black Velvet a comprare Caro Babbo Natale che usciva in quell’occasione e mi portò una copia di Porto Marghera da dedicare, e mi disse che lo acquistava perché ne avevi parlato tu sul tuo blog, stroncandolo ma, ehi, «se dedica attenzione a questo libro ci sarà pure un perché».
Confermo, sei tra i pochi pochissimi ad avere sempre apprezzato È primavera, il mio flop più clamoroso.
Comunque, probabilmente Porto Marghera e È primavera, a parte poche, pochissime eccezioni, sono i miei libri che in assoluto hanno lasciato più fredda la comunità dei lettori di fumetti, se questo termine può avere un senso (forse “prosumer” è il termine adatto). Uno dei miei editor italiani preferiti, quando Becco Giallo gli spedì il mio Porto Marghera, gli disse qualcosa del tipo «ma Calia era bravo a disegnare come mai fa così adesso? Fatemi un favore, non speditemi più suoi libri». Dici che il mio stile di disegno “simbolico” potrebbe essere stato uno stratagemma per aggirare i miei limiti grafici, ma questa non è forse la definizione di “stile” di ognuno? La lotta quotidiana di ogni disegnatore è quella con i propri limiti grafici, sempre, ce li abbiamo tutti. Ma quello “stile” non era casuale, e ricercava espressamente, di riprodurre un tipo di segno che mettesse a proprio agio il lettore di libri, quasi a riprodurre una “calligrafia”.

Questo l’ho sempre rilevato nel tuo fare fumetti. Non un linguaggio codificato, che permetta solo narrazione standardizzata, ma SCRITTURA in evoluzione continua, che permetta persino la realizzazione di un saggio sul pensiero di un filosofo.
Devo aprire un’altra piccola parentesi: ho avuto molti scossoni nella mia vita professionale di recente. Prima di tutto… boh, tre/quattro anni fa, a un certo punto ho deciso che dovevo rovesciare il mio baricentro: prima il lavoro “alimentare” (la mia salvezza e dannazione: sono bravo con i siti internet e il web marketing) aveva lo spazio predominante nella mia vita e mi ritagliavo gli spazi tra famiglia e lavoro per fare i fumetti, a un certo punto ho deciso di rovesciare il rapporto, dedicarmi ai fumetti e al disegno come attività principale, lasciando le cose web alle poche (mai troppo poche, dannazione!) cose praticamente “amicali” che continuo a portare avanti. Ho preso molto seriamente questa decisione, e stabilendo che il disegno sarebbe diventato la mia attività principale ho investito in un ipad pro e apple pencil … praticamente ormai non uso più carta e pennarelli. Il primo scossone che ha causato il mio “cambio di stile” è stato senz’altro questo. Questo slittamento di priorità ha funzionato, se conto anche i corsi ormai posso dire che vivo di fumetti a tempo pieno.
Ora: le prime cose che ho realizzato, a fumetti, con l’ipad sono state le tavole aggiuntive della nuova edizione di Dossier TAV, e le due storie sull’Iraq pubblicate su “Linus”. Tutti i disegnatori che cominciano a disegnare con l’ipad, secondo me, corrono questo pericolo di “sembrare Gianluca Costantini”… lui è stato tra i primi a passare al digitale e tendiamo ad associare un certo tipo di effetto digitale al suo segno perché è stato tra i primi e i più produttivi e costanti a usarlo. Nelle tavole nuove di Dossier TAV riconosco questa cosa. Su “Linus” io credo di avere già cambiato e riplasmato le potenzialità di questo nuovo strumento con quelle del mio stile precedente.
Perché ho cambiato segno? Perché piace di più. Ho messo da parte le mie riflessioni sull’uso narrativo del segno, non c’è platea per questo tipo di ragionamenti, oggi, e dal momento che ho deciso che voglio vivere di disegno devo concedere qualcosa a questo mestiere, sfumare quanto di più ostico ho portato avanti negli anni per permettere ai miei contenuti di avere più circolazione. Non ci sono lettori di libri che leggono fumetti. Ci sono lettori di libri che ogni tanto leggono un libro a fumetti. Ho sempre avuto un “pubblico” che si rivolge ai miei lavori per il “tema”, non per il segno, non per la narrazione, in definitiva: non per me. Questo ha fatto sì che i miei libri vendano più o meno come tanti altri, ma io non sia riuscito a crearmi una riconoscibilità come autore, e anche questo è qualcosa che ho dovuto e voluto affrontare, in virtù del mio cambiamento di prospettiva.
Per cui, per tornare alla domanda: il segno è cambiato per fenomeni terzi rispetto a quel che volevo raccontare. Il fatto che io riconosca, oggi, di avere bisogno di una pausa dal graphic journalism è dato da altri fattori.
Va beh, adesso mi dici quali sono questi fattori.
Guarda, possiamo fare finta di continuare a parlare come fossimo in un salottino borghese servendoci del tè caldo e disquisendo amabilmente di fumetti…
Naah, quella sciacquatura da intellettuali pacificati, andiamo avanti con il prosecco!
Ecco, allora non possiamo dimenticarci di essere nel mezzo di una pandemia globale, a un anno giusto dall’inizio, e non posso mica dire che non abbia e stia influendo sul mio umore, come per tutti suppongo. A febbraio 2020 esce la mia prima storia su “Linus”, frutto di un lungo lavoro di editing insieme a Igort, e a marzo 2020 la seconda. Comincia il lockdown, scrivo a Igort che avrò tutto il tempo per cominciare a lavorare alle prossime e… mi blocco. Provo disagio pure ora a scriverne: ho un fiume di idee da raccontare sull’Iraq, ma solo l’idea mi paralizza. Era qualcosa che era già iniziato a farsi spazio dentro di me, probabilmente con Dossier TAV.
Sai che non ho mai venduto le mie tavole originali? Perché mi chiedo sempre, alla fine, nel profondo: a chi appartengono queste tavole? Ho venduto tavole solo in aste di beneficenza per iniziative in Val Susa o in Rojava; per Amnesty International, ne ho regalate alcune a Supporto Legale per sostenere le spese legali relative al G8 di Genova, e ho regalato disegni per aste in solidarietà a Mediterranea Saving Humans.
Insomma, mi sembrerebbe di lucrare sulla vita degli altri, e non sono capace. Visto quanto guadagno dai libri quello non mi preoccupa, il soldo non è mai proporzionato all’impegno che ci vuole e il lavoro è sempre in perdita.
Ok. Ma torniamo a “Linus”…
A Igort interessava che raccontassi storie dai miei viaggi in Iraq. In Iraq ci vado continuamente dal 2016, inizio un corso a distanza pure sabato prossimo con loro. C’è questa cosa che a me è palese ma non riesco a fare capire questa cosa con le parole: quelli che frequento non sono “personaggi”, sono “persone”. E niente, per farla breve, su questa cosa sono andato in crisi… sono finito per la prima volta in vita mia da una psicologa e, semplicemente, nonostante lei abbia cercato in tutti i modi di convincermi del contrario, in questa fase della mia vita mi sono sentito un ladro di storie, uno che guarda le vite degli altri per tirarci su soldi e niente, da quando si è fatta spazio questa idea, nonostante soldi poi non ne abbia mai fatti, io – e qui chiedo scusa a Igort che non mi ha più sentito e io la verità non ho mica avuto il coraggio di dirgliela… che sono pavido – non sono più riuscito ad approcciarmi al racconto delle storie degli altri. Ho bisogno di fare qualcosa che possa sentire interamente “mio”, di cui possa disporre senza sensi di colpa, motivati o meno che siano. Ho bisogno de I Baccanti.

Non so se ho capito quello che vuoi dire. Kapuściński diceva due cose fondamentali: che quando racconti degli altri devi averne condiviso un po’ la vita, solo attraverso questa condivisione puoi non sentirti, come dici tu, “ladro di vite altrui”, e aggiungeva che, quando lo fai, devi sempre sentirti “responsabile di qualcosa”. Ora, siccome la prima parte mi sembra che tu l’abbia tenuta ben presente per ogni libro che hai fatto, dai lavoratori di Porto Marghera ai resistenti della Val Susa, ai giovani iracheni… hai condiviso con loro un pezzo di strada. Mi sembra che il tuo problema nasca dal fatto di non essere riuscito a definire quel “qualcosa” di cui essere responsabile (non ci era riuscito nemmeno Kapuściński, in realtà) e al momento, se ho capito bene, lo vivi come una responsabilità di appropriazione indebita di storie altrui.
Non temi però che i Baccanti, che se non ho capito male ti dovrebbero aiutare a chiarire questo paradosso (inventare storie di fantasia per trovare la strada che ti porti di nuovo a raccontare storie di realtà – tornare alla cronaca attraverso la fiction) esorcizzandone il senso di colpa, non si riveli invece un punto d’arresto… di radicale cambiamento, oltre il quale sarà difficile tornare a raccontare storie di altri?
No, non intendevo questo! Ho un problema col graphic journalism, mio, piccolo e individualissimo, non ho “finito” col graphic journalism. In questo momento ho dovuto interrompere qualche giorno la lavorazione de I Baccanti numero due perché sto lavorando contemporaneamente a tre storie brevi “di realtà” (è il ventennale del G8 di Genova e mi trovo coinvolto in qualche progetto). Lo ammetto qua, tanto “non ci legge nessuno”: mi sta costando tantissimo.
Umanamente dico, e il nodo è sempre lo stesso: quanto diritto ho di raccontare cose collettive dal mio, unico e infinitamente piccolo, punto di vista? A chi interessa il “mio” punto di vista?
Scusa, ma stai muovendo una critica, velata all’autobiografismo imperante nel fumetto? Mi sembra di ricordare che, seppur in modo particolare, penso a Maledetti Fumetti, sia un genere che hai sperimentato.
Mmmh, vedi che non stai attento? Eppure l’ho detto: «A chi interessa il “mio” punto di vista?». Il problema non è mai “cosa” raccontare, ma “quando”, semmai. Di sicuro ho racconti interessanti che farebbero la gioia di questure di mezzo mondo, ma raccontarli a quale pro? E poi… sono il “proprietario” di azioni collettive “solo” perché ci ho partecipato? Poi certo, per autobiografia si intende anche altro. Joe Matt, Seth e Chester Brown sono tra i miei autori preferiti. Certo, sono fumetti “autobiografici”, ma di che vite stiamo parlando? Joe Matt si fa scaricare dalla ragazza che gli trova i fumetti in cui dice quanto gli piacciono le altre, vive in appartamenti di fortuna con coinquilini sempre diversi… Chester Brown sperimenta la vita senza amore romantico andando a prostitute… insomma, io ho una moglie e una figlia, vivo in campagna, non credo di avere niente di autobiografico di così interessante da raccontare e soprattutto niente che non coinvolgerebbe, per forza, la vita delle persone che mi circondano e, andiamo… per togliermi la soddisfazione di un racconto mi metto a dire cose di mia figlia in pubblico? Ma anche no, dai.
Si, è una questione di sensibilità personale, e sull’autobiografismo spinto, quello dei cazzi propri, per intenderci, sono d’accordo con te. Vorrei capire meglio invece il problema del raccontare “storie di altri”. Capisco la questione della responsabilità, ma non ne comprendo a fondo il tuo attuale rifiuto.
Effettivamente è molto complicato: cerco di essere il più chiaro possibile, rischiando anche il didascalismo. Chi vuole che racconti di Iraq si aspetta, legittimamente, racconti commoventi. E, giuro, è quello che mi verrebbe, è quello che ho cominciato a fare, cosa vuoi raccontare dell’Iraq? Ma, poi, ci rifletto. E penso che nella seconda storia su “Linus” faccio parlare una ragazza, che mi descrive come è morto suo fratello. Ecco, per chi legge, quella è “la ragazza a cui l’Isis ha ucciso il fratello” ma, ehi, io con lei ci ho passato giorni, è una persona, la sua esistenza non si esaurisce nell’essere definita quella a cui è morto il fratello. E queste persone sono vive, usarle come artificio narrativo per far sgorgare la lacrima a un placido lettore occidentale sì, forse potrei ritenerlo pure cinicamente utile in qualche modo, ma io, oggi, ora, non me la sento di usare quella vita per creare una reazione di questo tipo qui.
Quasi contemporaneamente a I Baccanti uscirà in libreria, My Covid In Comics, un librone con i contributi di 137 artisti da tutto il mondo e sono mie la copertina, la storia breve che apre il volume, le illustrazioni che ne caratterizzano i capitoli… ecco, rivivere l’anno passato attraverso la storia breve a fumetti e le illustrazioni dei capitoli è stato straziante. Forse è questo continuo giocare col dolore nel graphic journalism, cosa che devi fare perché il lettore lo devi pur buttare dentro la storia, ad avermi fatto male. Che tu lo voglia o no, quando lo racconti ti rimane appiccicato addosso, almeno è quello che è successo a me. È anche normale poi che dopo anni per un po’ di gente io sia “Il” Graphic Journalist. E non è che funziona come un interruttore che spingi e si spegne, continuo e continuerò ad avere richieste in questo senso e quando possibile lo farò, immagino non tanto presto in forma libro perché per come sono ora non potrei reggere quello sforzo.
Poi non è vero che I Baccanti sarebbero una sorta di “cura” per tornare a raccontare la realtà.
Ho tre racconti brevi, che potrebbero diventare un libro un giorno, più o meno reali sul consumo di droghe leggere. Se oggi sto facendo I Baccanti – non ci avrei mai creduto! – credo sia proprio possibile che prima o poi arrivi anche il loro turno. Poi, torniamo all’inizio, io una cosa da raccontare, che sento “grande” e “importante” ce l’ho. È sopravvissuta allo scorrere del tempo arrovellandomi per più di vent’anni. E credo ci sia più autobiografia nei Baccanti di quanto riuscirei a mettere in un fumetto sulla mia colazione la mattina (spoiler: bevo solo il caffè).
Ah ah ah, aspetto con ansia l’episodio sulla Rivoluzione Francese, per vederne la tua lettura autobiografica… io vorrei fare la parte di Saint Just… a parte gli scherzi, quindi i Baccanti non sono una risposta estemporanea a questa tua crisi…
I Baccanti nascono attorno al 1999 e davvero come idea non mi hanno mai abbandonato. Semplicemente non c’è mai stata l’occasione per mettermi a farlo e ora ho deciso di darmela io, anche perché forse ho trovato una certa tranquillità economica che prima non avevo… in questi termini, ho seminato dando vita a Oblò, sperimentando la vendita diretta sia per lavoro “vero” che con l’associazione, costruendomi quella cassetta degli attrezzi che mi ha consentito a un certo punto, circa a dicembre del 2020, di dirmi “sì, è il momento” e realizzare dalla “A” alla “Z”, grazie all’aiuto di Omar Martini e Cisco Sardano, il primo albo e cominciare il secondo in tempi brevissimi.

Dei Baccanti mi piace che siano una società rivoluzionaria a carattere segreto… è un’idea in parte anarchica: Bakunin ha passato la vita a fondare fallimentari associazioni segrete volte a creare i presupposti per l’insurrezione, ma la vera fonte la troviamo durante la Rivoluzione Francese con Babeuf e la congiura degli eguali. Però d’altro canto mi vengono in mente anche fantasmatiche società segrete come quelle degli Illuminati di Baviera, o degli Alumbrados spagnoli, che però erano reazionarie volte, a governare sulle macerie. Come si muoverà la tua serie attraverso l’inevitabile ambiguità che un’associazione segreta porta con sé?
Ahia, se ti rispondo rivelo uno spoiler grosso come la serie. Mi trincero dietro un doveroso “no comment”. Dico solo una cosa: uno dei riferimenti che tanti vedono nella serie è The Invisibles di Grant Morrison. Bellissima serie, eh. Ma leggendo Invisibles ho sempre pensato a quanto Morrison probabilmente – voglio sperare – conoscesse e si sia in qualche modo fatto ispirare da Gli Invisibili di Nanni Balestrini. Ecco, se possiamo parlare certo di una ispirazione a The Invisibles vorrei che passasse agli atti che qua, nelle intenzioni, siamo più in zona Balestrini. Insomma, I Baccanti non sono una “società rivoluzionaria a carattere segreto”, e quel che sono davvero emergerà nel tempo.
Beh, non vederci Grant Morrison è impossibile: lo dichiari già nello slogan con la traduzione del suo «Say you want a revolution». E poi anche i tuoi personaggi, in qualche modo richiamano Dane, Boy, Ragged e gli altri che non ricordo. Il riferimento a Balestrini invece un po’ mi spiazza. Ti spiego perché: Gli Invisibili è vero che è un romanzo, e che sicuramente quello che racconta appartiene alla tua storia umana e politica, ma lo stile in cui lo fa, quella prosa che volutamente si trasforma in trascrizione orale di una lingua/storia collettiva – qualcuno, molto tempo fa quando si usavano i magnetofoni l’ha definita addirittura magnetofonica… io non la amo particolarmente, ma non posso non riconoscere che quello stile, in particolare in questo romanzo e in Vogliamo Tutto, è carico del coraggio di una titanica e antinarcisistica assunzione di responsabilità che trasforma la propria voce (l’io dell’autore) in una voce collettiva (il noi della generazionale di cui racconta) pur restando IO. Non temi in questo senso, rifacendoti alla sua esperienza letteraria, per raccontare i Baccanti, di ricadere in quell’impasse da cui volevi liberarti?
Non posso fare a meno di risponderti intanto sul titolo, perché mi sembra divertente e ci ho pensato parecchio sopra. Io acquisto il primo volume degli Invisibles a New York, nel 1998. Perciò per me, ehi, quel volume, la prima storia degli Invisibles è sempre stata Say you want a revolution, che è ovviamente un titolo che mi ha entusiasmato dal principio. Penso al primo albo o ciclo dei Baccanti una delle tante volte che ci ho rimuginato sopra e mi convinco, a un certo punto, che potrei intitolarlo Rivoluzione Baccante. Poi verifico e dannazione, in italiano Say you want a revolution non è mai stato tradotto come «Di’ che vuoi una rivoluzione» ma, attenzione, qui è Rivoluzione invisibile. Nel gioco delle coincidenze, pur capendo perché gli editori italiani abbiano optato per un titolo senza apostrofi e imperativi, ho deciso di assecondare il destino e togliermi la soddisfazione di tenermi la “prima italiana” del titolo Di’ che vuoi una rivoluzione. Che cade naturale con la storia, eh.
Su Nanni Balestrini, o mio biografo in erba, ti verserei un (l’ennesimo?) bicchiere di bianco biologico di Vo’ se ti avessi qua davanti, ti devo ricordare che ho sguazzato nel mondo della poesia, come bidello dapprima, assemblando cd-rom multimediali e siti sulla poesia orale e gli slam poetry…
…certo stiamo pure aspettando una tua cosa per QUASI sullo slam poetry comic, se non ricordo male.
…e poi come scarabocchiatore seriale con il mio amico e poeta Lello Voce, con cui ho pure vinto uno dei miei pochi premi, e sicuramente l’unico in moneta sonante, con Piccola Cucina Cannibale insieme a Frank Nemola. Insomma, Balestrini me lo ritrovo all’incrocio di molteplici dei miei interessi e ho occasione di incrociarlo fin da abbastanza piccino diciamo, ma questo non significa sia un modello a cui ambire, anche perché, mio complice di bevute, poi dipende anche dall’epoca che ti ritrovi a dover raccontare.
I BACCANTI È FICTION.
Fiction architettata su certe ispirazioni e tra questi, in senso largo, molti colgono The Invisibles e mi piace l’idea di dire, da qualche parte, ehi, siete migliaia là fuori (esagero?) che leggete Invisibles: sappiate che quasi certamente Grant Morrison per quel titolo si è ispirato a un romanzo di uno dei più importanti poeti italiani del 900 che non avete degnato di uno sguardo. Concedetegli una possibilità.
Mi associo all’invito…
e mi finisco il bicchiere di bianco.
Non fa un cazzo da anni, ma è invecchiato lo stesso. Vive a Milano, e non potrebbe farlo in nessun’altra città italiana. Legge e parla di fumetti dal 1972 (anno in cui ancora non sapeva leggere). Ha una cattiva reputazione, ma non per merito suo. Ama e praticava la boxe, poi si è rotto. Beve tanto in compagnia di gente poco raccomandabile, tipo Paolo con il quale – per colpa di una di quelle bevute – si è ritrovato a curare QUASI.